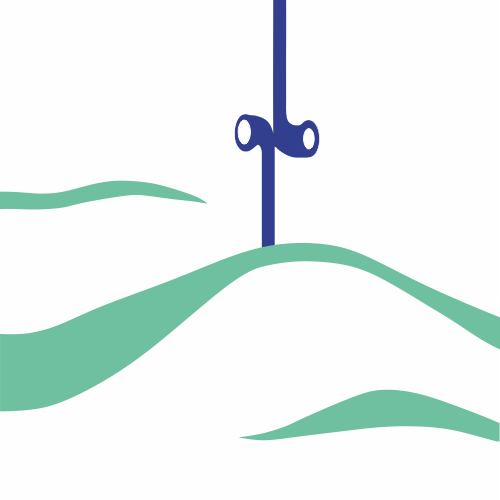Aut tace, aut loquere meliora silentio. Salvator Rosa, o della libertà di pensiero dell'artista
Aut tace, aut loquere meliora silentio. “O taci, o di’ qualcosa che sia meglio del silenzio”. La scultorea evidenza di quelle sei parole incise sulla tavola che Salvator Rosa regge con noncuranza nel suo Autoritratto alla National Gallery, così chiare, così imperative, così ficcanti, lascia una traccia indelebile nelle menti di tanti che rimirano quel quadro tanto potente. Sarà per la disarmante semplicità di quel consiglio mutuato da Strabone, che a sua volta lo attribuiva a Pitagora (ed è ozioso rimarcar qui l’importanza e il ruolo del silenzio nella scuola pitagorica), sarà per la posa altera del pittore, che si ritrae come fosse un filosofo antico lasciando sotteso il riferimento a quello stesso Pitagora che per secoli è stato ritenuto l’inventore della filosofia stessa, sarà per quello sguardo fiero e arcigno da cui traspare e trapela il suo temperamento tenace, scontroso, passionale, ruvido, sprezzante: sarà per tutto questo, che il fascino di questo Autoritratto idealizzato e del suo motto, che riecheggia quella passione tutta cinquecentesca per le imprese, ha travalicato gli stretti confini della storia dell’arte e s’è riversato nella letteratura, nel giornalismo, nella saggistica. E forse questo solo dipinto sarebbe di per sé sufficiente a suggerire al riguardante un’idea, vaga ma fondata, dell’indole di Salvator Rosa, artista contro gli artisti (o almeno contro quelli ignoranti, contro quelli che “credon d’esser maestri, e non san nulla”), poeta sferzante, fustigatore della corruzione della Chiesa, dell’ignoranza e dell’ipocrisia della società, del servilismo di poeti, musicisti e pittori, della viltà di molti suoi colleghi.
A monte, la radice primigenia della modernità del genio di Salvator Rosa potrebbe esser individuata in quel suo continuo volersi rifare al principio oraziano dell’ut pictura poësis: “il parallelismo fra i versi e i dipinti”, ha scritto Luigi Salerno, tra i più eminenti studiosi ed esegeti del grande artista napoletano, “è dovuto allo stesso temperamento dell’uomo estroverso e passionale, che quando aveva un’idea nella mente sentiva il bisogno di esternarla con i diversi mezzi artistici che aveva a disposizione e nei quali si impegnava”. Pittura, poesia, aforismi, musica: varî sono i campi nei quali germoglia e fiorisce l’estro versatile di Salvator Rosa. Nella quinta delle sue Satire, i componimenti dai quali è più comodo far partire una ricostruzione del pensiero e delle convinzioni di Salvator Rosa, il protagonista, ovvero l’Autore, nel rispondere a una domanda dell’Invidia circa l’estensione dell’ingegno del pittore, tratteggia in pochi versi l’idea di ciò che a suo parere dovrebbe essere un artista: “s’i libri del Vasari osservi e noti / vedrai che de’ pittori i più discreti / son per la poesia celebri e noti. / E non solo i pittori eran poeti, / ma filosofi grandi, e fûr demonii / nel cercar di natura i gran segreti”. Risulta difficile cogliere appieno l’essenza degli strali di Salvator Rosa saltando questa premessa: la filosofia, la conoscenza, il desiderio d’imitar gli antichi nella loro ricerca dei “gran segreti” della natura compongono la cornice entro cui Salvator Rosa mira a costruire la sua esperienza di pittore, di poeta, di essere umano. Ed è nel solco tracciato dall’insanabile discrepanza tra le sue idee e l’indolenza colpevole dei suoi contemporanei (specie di quelli che avrebbero pur i mezzi, ma preferiscono incamminarsi sulla via della vana adulazione e della passiva pecoraggine) che si forma e si muove la sua critica feroce.
La prima delle sette satire, che se la prende coi musicisti, s’apre con una frustata che fin dal primo verso s’abbatte sulla società tutta: “Abbia il vero, o Priapo, il luogo suo: / se gli asini a te sol son dedicati / bisogna dir ch’il mondo d’oggi è tuo. / Crédemi che si son tanto avanzati / i tuoi vassalli, che d’un Serse al pari / tu potresti formar squadroni armati. [...] Il tempo d’Apuleio più non si nomini, / ché s’allora un sol uom sembrava un asino, / mill’asini a i miei dì rassembran uomini”. L’artista prosegue scagliando le sue frecciate contro gli obiettivi della sua travolgente polemica: l’indegnità della musica contemporanea (“è la musica odierna indegna e vile, / perché tratta è sol con arroganza / da gente viziosissima e servile”), l’inconsistenza dei musicisti (“sol di becchi e castrati Italia abbonda”) e, si potrebbe dire, della classe intellettuale tutta dacché oggetto delle sue mire sono anche i pittori e i poeti, oltre che i politici, e poi ancora l’assenza di buoni maestri (“io sgrido, io sgrido voi, maestri indegni / voi che il mondo insegnate a imputtanirsi”), la propensione, da parte dei mecenati, a circondarsi d’artisti indegni (“oggi nessun gli scaccia o gli rifiuta, / anzi in casa de’ principi e de’ reggi / questa genia è sol la ben veduta”), la sostanziale vacuità e inutilità dei ragionamenti dei poeti e, di conseguenza, il carattere disimpegnato e frivolo dei loro lavori (dalla Satira II: “invece di un mestier fertile e vivo, / dietro a la morta e steril poesia / imparate a cantar sempre in passivo”), gli sprechi d’una corte avvezza a spendere fortune per lussi e feste ma che non si cura dei poveri e dei bisognosi (“or questi abusi in vece di correggere, / voi fate canticchiar la re mi fa / e festini e comedie e danze eleggere. / Quanto di voi saria fama e bontà / se quello che spendete in simil fole / si desse in sovvenir la povertà!”), l’incontrollata diffusione del vizio, l’iniqua applicazione della giustizia.
 |
| Salvator Rosa, Autoritratto (1645; olio su tela, 116,3 x 94 cm; Londra, National Gallery) |
La curia romana, la corte pontificia di papa Alessandro VII, nei versi di Salvator Rosa diventa una nuova Babilonia contro la quale la sua penna scrive impietosa, nella sesta satira: Roma è la città dove “l’immonda setta del Vizio” non solo se ne va “fastosa e impune”, ma ben si cura di “colonie fondar per ogni sponda”, è il luogo dove gli animi grandi languono nel digiuno e dove le fortune vengono rovesciate in gran copia su chi non le merita, dov’è pieno d’arroganti e ignoranti che si spaccian per sapienti, di “berilli” che “passan per diamanti”, di adulatori, di simulatori ben accolti perché nella nuova Babilonia il “ben fingere si stima virtù”, dove la modestia è tenuta in disprezzo e non è in grado di garantir vantaggi a chi la pratichi, dove vengono additati ad alti esempî uomini che andrebbero ricordati “per l’infamie sol”. E affinché il dardo non si limiti a pungere, ma sia anche capace di penetrare vieppiù a fondo, l’artista pensa di sottolineare i concetti della satira con un dipinto, oggi al Getty Museum di Los Angeles: un’allegoria della Fortuna, dove la giovane dai capelli fulvi e scompigliati, a significare che la fortuna cambia secondo come si muove il vento, rovescia una cornucopia colma d’oro e di monete su bestie da basto e da macello, asini, pecore, capre, maiali, bovini assortiti, un avvoltoio. Che immancabilmente calpestano e distruggono i simboli delle arti e dei saperi: i libri, la tavolozza, i pennelli. E il porco, che grufola perplesso davanti a una manciata di perle, eloquente immagine del famoso detto, nel mentre straccia e disintegra la rosa che allude al cognome dell’artista. Su chi siano i dedicatarî del dipinto, non v’è dubbio alcuno: l’asino indossa la veste cardinalizia, e fa ombra al gufo, simbolo di saggezza, al quale niente tocca delle ricchezze rovesciate dalla Fortuna. Baldinucci racconta che Salvator Rosa ebbe l’idea d’esporre il quadro per la festa di San Giovanni decollato nel 1658, nella chiesa romana dedicata al santo: lo sconcerto negli ambienti pontifici fu tale che, racconta ancora lo storiografo fiorentino, l’artista rischiò d’essere incarcerato, se il fratello del papa, il principe Mario Chigi, non fosse accorso in sua difesa (probabilmente con uno scritto ch’edulcorava il contenuto dell’opera: Baldinucci parla d’una “molto dotta apologia” redatta a difesa di Salvator Rosa).
È la stessa cultura del dissenso che, hanno scritto di recente le studiose Stefania Macioce e Tania De Nile in un contributo per la monografia su Salvator Rosa e il suo tempo, alimenta i suoi mirabili e celeberrimi dipinti popolati di streghe, mostri e fantasmi: “la trattazione di tematiche stregonesche non denota convinzioni particolari, ma piuttosto l’interesse verso argomentazioni non convenzionali o addirittura censurate e per null’affatto comuni in Italia”. Non c’è forse un programma prestabilito né si possono rintracciare, nei quadri di stregoneria, dei precisi destinatarî, ma è evidente che qualche intento polemico corra a ravvivare le scene, e che la critica corrosiva di Salvator Rosa in qualche modo arrivi a permeare questi mostruosi sabba traboccanti di presenze demoniache. Ancora, è il forte anticlericalismo dell’artista il terreno sul quale crescono le sue diavolerie, un anticlericalismo da declinare secondo due ordini d’idee. A tutta prima, la presenza di monaci in certe composizioni stregonesche (in un disegno del Metropolitan vediamo un inequivocabile frate, con saio e tonsura, che partecipa a un rito magico dove s’evocano mostri d’ogni sorta) potrebbe essere motivata dalla smania di Salvator Rosa di denunciare le turpitudini della Chiesa e degli ordini monastici. Questi quadri vanno però anche legati al pensiero scientifico del tempo, e in particolare all’ambiente napoletano in cui l’artista si forma, un ambiente in cui, scrive ancora Luigi Salerno, s’avverte “fin dalla fine del Cinquecento, un fermento nuovo”: la “tendenza alla rivalutazione della fisica rispetto alla metafisica e l’esigenza moderna che si affacciava, sia pure sul piano della tradizionale erudizione, della ricerca sperimentale, riconducendo la ragione dell’universo in seno alla natura, favorivano il concetto del dotto-mago che per intuito, genio e divinazione scopre i segreti naturali: di conseguenza, nel nuovo orientamento filosofico, entravano largamente la magia, l’alchimia e l’astrologia che, in quanto pratiche sperimentali, dovevano contribuire alla nascita della scienza moderna assai più della astratta speculazione filosofica e teologica”. E com’è noto, il pensiero scientifico, nei primi decennî del Seicento, trova spesso ostacoli lungo il suo cammino, anche di natura ecclesiastica, come ben rammenta la vicenda di Galileo (e non si dimentichi che, negli anni Quaranta, Salvator Rosa soggiorna per qualche tempo a Firenze).
C’è poi una delle liriche del Libro di musica di Salvator Rosa, intitolata La strega, che potrebbe facilitare un ulteriore livello di lettura, anch’esso legato ai rimandi tra scienza e stregoneria, con quest’ultima che diviene deriva, corruzione, degenerazione della prima: con un ritmo che incalza rapido, Salvator Rosa, nel suo componimento, descrive la preparazione del rituale d’una fattucchiera (“mago circolo / onde gelide / pesci varii / acque chimiche / neri balsami / miste polveri / pietre mistiche / serpi e nottole / sangui putridi / molli viscere / secche mummie / ossa e vermini / suffumigi che anneriscano / voci orribili che spaventino / linfe torbide che avvelenino / stille fetide che corrompino / che offuscino / che gelino / che guastino / che ancidano / che vincano l’onde stigie”), che per il suo filtro, il cui fine è quello d’evocare una turba infernale, adopera strumenti che sono tipici anche dei preparati dello scienziato (le polveri, i balsami, le acque chimiche), familiari all’artista data anche la sua frequentazione con illustri uomini di scienza del suo tempo. Ed ecco quindi che nelle diavolerie, in quelle streghe che trafficano con libri, formule, pozioni, tinture, fumi, alambicchi, pentole, mortai, che riesumano cadaveri, che s’appartano in ambienti lontani da tutto e da tutti, non sarà arduo intravedere l’immagine distorta e corrotta dello scienziato secentesco.
 |
| Salvator Rosa, Allegoria della Fortuna (1658-1659; olio su tela, 200,7 x 133 cm; Los Angeles, Getty Museum) |
 |
| Salvator Rosa, Sabba di streghe (1640-1649 circa; penna e inchiostro marrone e acquarellature marroni su carta, 272 x 184 mm; New York, Metropolitan Museum) |
 |
| Salvator Rosa, Streghe e incantesimi (1646 circa; olio su tela, 72 x 132 cm; Londra, National Gallery) |
Macioce e De Nile, come detto, hanno voluto stabilire una relazione di causa ed effetto tra le diavolerie di Salvator Rosa e la sua attitudine al dissenso, il suo “profondo amore verso la libertà di coscienza e di pensiero”, quell’amore che muove la sua mano nella composizione delle Satire, che gli fa rischiare il carcere per aver dipinto la classe prelatizia romana in forma d’asini e maiali, che lo porta più volte a prender posizione e a condannare il malcostume del suo tempo, alimentato ed esaltato dagli artisti proni al cospetto del potere. A quella libertà, Salvator Rosa non avrebbe rinunciato neppure nei momenti più tribolati della sua vita. Una libertà che straripa impetuosa da una lettera del febbraio del 1656, inviata da Roma all’amico fraterno Giovanni Battista Ricciardi: in quel periodo s’addensano sul pittore maldicenze che coinvolgono la sfera di suoi affetti, dal momento che da tempo l’artista convive (si direbbe oggi) con la sua amata Lucrezia, una donna sposata che gli ha dato un figlio di cui va fiero, Rosalvo. Salvatore tenta invano di chiedere per lei l’annullamento del precedente matrimonio: non avendo ottenuto quanto sperava d’ottenere, si risolve col far trasferire lei e il figlio quindicenne a Napoli dacché, ritenendosi perseguitato dal Sant’Uffizio, l’artista spera di poter allontanare i suoi cari da pericoli incombenti. La vicenda ha però un epilogo tragico, dato che in quello stesso 1656 una terrificante epidemia di peste cade rovinosa su Napoli, portandosi via metà degli abitanti della città: tra questi, l’amatissimo Rosalvo, e poi ancora il fratello del pittore, sua sorella, il marito di lei, e i cinque figli della coppia. L’artista è rimasto ancor più solo. E in quel clima dipinge una delle sue opere più celebri, L’umana fragilità, un orrorifico memento mori, con protagonista uno spaventoso scheletro alato che sopraggiunge per cogliere una giovane col capo inghirlandato di rose che tiene a sé un bambinetto, e reso ancor più cupo dal fatto che scaturisce da un’esperienza diretta e luttuosa.
Ma la situazione non è certo rosea neppure al momento della separazione dalla compagna e dal figlio, in quel febbraio del 1656: una situazione che fa sprofondare l’artista in una fosca malinconia e in una tormentata solitudine, che lo lascia “solo, senza serva, senza servitù, non con altra compagnia che d’una gatta”. La lettera a Ricciardi, seppur velata di profonda tristezza, è stata da più parti indicata come un caposaldo della dignità dell’artista, come un palese manifesto della libertà di pensiero di Salvator Rosa. La commiserazione per la sua condizione diventa così una cruda invettiva contro gli inquisitori: “e tutto questo nasce per timore di non incorrere in qualche disgrazia di carcere, in qualche becco fottuto di spia di Sant’Offitio, che sia maledetta per mille volte l’anima di quello che l’inventò. [...] Hora, tant’è, già sono in Napoli accarezzati da mio fratello e da mia sorella, proveduti di comodi e di denari et io qui come un bellissimo viso di fava me ne sto insolidito in guisa che non so donde mi sia, rinegando e bestiemando chi ci introdusse nell’anima tanta paura, e chi trovò tante clausole e vincoli sopra le nostre conscienze, che maledetto sia per tutti i secoli de’ secoli. Vi prego dunque (se pure havete viscere, e tanto d’humanità di potervi vestire de’ miei panni) a compatirmi, e credere che in tutto il corso di mia vita non mi son trovo mai in maggior laberinto e necessità di sollievo e consiglio, e se questa volta non mi fo’ certosino non è che un miracolo della misericordia del Cielo, che non mi voglia più coglione di quello che mi confesso d’essere. O Signora Lucrezia, o Rosalvo, o pace, o quiete, o comodo, e dove sete andati. Cazzo, almeno sapessi che veramente fusse così come me la contano questi sbirri borricelli delle nostre coscienze, che, facendo loro quello che più l’agrada, vogliono che noi non facciamo quello che più ci piace. Per amor di Christo, di Idio, della tua bontà, consolami, consigliami, che mai mi ritroverò in maggior neccessità, e se non m’ammalo, confesso e crederò che son di bronzo. Non altro; vogliatemi bene, e ricordatevi che ho un’anima grata, che sa amare e conoscere il beneficio”. Sono le parole d’un artista che si sottopone a numerosi rischi pur di difendere i suoi convincimenti, d’un uomo libero che non tollera né sopporta l’idea d’un’autorità che instilli la paura nelle persone e dica loro come debbon pensare, né accetta il dilagare d’un’ipocrisia che lo colpisce nella sua intimità.
 |
| Salvator Rosa, L’Umana Fragilità (1656; olio su tela, 199 x 134 cm; Cambridge, Fitzwilliam Museum) |
Ci si potrebbe domandare quale sia la forza che anima Salvator Rosa e con quanta coerenza abbia portato avanti le sue battaglie, fermo restando il fatto che non sappiamo datare le Satire con certezza, e che ciò di cui s’è parlato copre un arco molto lungo della sua carriera, con tutto ciò che ne consegue. È però possibile provare a trarre degli assunti che possano valere per buona parte del suo percorso. Salvator Rosa non è un castigatore avulso dalla realtà, né un eremita che giudica senza scendere a compromessi. Detesta la società, ma non è un reietto né un antisociale, anzi nella società è ben inserito. Ama il successo e lo cerca: in una sua lettera si rallegra per una prestigiosa commissione ricevuta, intuendo che si tratta d’un’occasione da cogliere al volo e senza troppo pensarci, perché avrebbe potuto contribuire alla sua gloria personale (“vi giuro, amico, che mai non mi sono trovato in impegno maggiore: ma perché occasione più bella non era per sortir mai più, per non tradirla, ho questa volta arrisicato il tutto per confermarmi nel credito della fama”). Polemizza con gl’intellettuali del suo tempo ma frequenta le corti, le accademie, i circoli. Disprezza sinceramente il denaro, ma si vanta del valore dei suoi dipinti (“s’io vendessi tutte queste mie pitture che di presente mi trovo, vorrei avere in culo Creso”). Si scontra coi pittori che dipingon “bambocciate”, “accattatozzi e poveri”, “stuolo d’imbriaconi e genti ghiotte / zingari, tabaccari e barberie, / niregnacche, bracon, trentapagnotte: / chi si cerca i pidocchi e chi si gratta”, ma non disdegna le scene di genere, che anzi produce in quantità. Allora, forse la chiave per entrare nella visione del mondo di Salvator Rosa va cercata in un verso della seconda delle Satire, dove il pittore e poeta afferma che “violenza moral mi sprona e desta”.
La lotta di Salvator Rosa s’esprime dunque in quegli stessi ambienti che sono oggetto delle sue accuse, e l’artista agisce con le armi della pittura e della poesia, ribellandosi alle logiche del sistema dall’interno. La scelta di queste armi gli avrebbe causato forti inimicizie, denunciate nel sonetto d’apertura delle Satire (“più d’un Pietro mi nega e m’abbandona / e più d’un Giuda ognor mi vedo a lato”), ma era quanto gl’imponeva la forza della sua morale. In breve: Salvator Rosa non è un perbenista, è un ribelle. Sa di non essere perfetto, lo ribadisce financo nelle Satire, ma non smette di denunciare la realtà che vede attorno a sé. Sa che per fare questo occorre sporcarsi, e sa bene, scrive Salerno, che “soltanto la sua moralità, la sua serietà artistica sono davvero incorruttibili”. Ed è per questo che “la sua lotta si svolge in modo aperto, con la satira e con la polemica culturale, non con le manovre del cortigiano arrivista”.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Giornalista d'arte, nato a Massa nel 1986, laureato a Pisa nel 2010. Ho fondato Finestre sull'Arte con Ilaria Baratta. Oltre che su queste pagine, scrivo su Art e Dossier e su Left.
Leggi il profilo completo