Per ricordare il grande scrittore Raffaele La Capria, scomparso lo scorso 26 giugno a Roma all’età di 99 anni, pubblichiamo questa intervista a La Capria, rilasciata nel 2008 a Bruno Zanardi, a proposito della lunga amicizia che aveva unito La Capria a Giovanni Urbani. Ne emerge un importante ritratto di due grandi uomini e intellettuali, moderni e visionari, sullo sfondo delle vicende che interessarono l’Italia dei beni culturali tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta.
Incontro Raffaele La Capria nel suo labirintico appartamento di Palazzo Doria, dalle cui finestre Roma appare ancora più dolce e pigra in questa tepida giornata ottobrina. Iniziamo a ricordare Giovanni Urbani con affetto e malinconia. Ben presto però la conversazione prende forma d’un confronto di opinioni. Un confronto serrato, ma gentile, sul genere delle affettuose sfide intellettuali in cui spesso Raffaele si cimentava con Urbani. “Ti ricordi Giovanni come ci siamo divertiti insieme?”, questa la frase più volte da lui pronunciata nella struggente orazione che tenne al funerale di Urbani, alla chiesa di San Giacomo degli Incurabili, la mattina del 10 giugno 1994. E fu Raffaele a accompagnarne il corpo alla cremazione e “a vedere, uscendo all’aperto (...), un fumo denso, oleoso, che saliva dall’alta ciminiera e si disperdeva nell’azzurro terso del cielo. ‘Quel fumo è Giovanni che se ne va, pensai’”. Così ha raccontato nel suo L’estro quotidiano, un romanzo in gran parte scritto “per ricordare Giovanni”.

BZ. Quando hai incontrato per la prima volta Urbani?
RLC. A Roma, nella primavera del 1957. Soli italiani, eravamo stati invitati a uno degli International Seminars di Harvard su politica, economia e arte. Lui voleva conoscermi perché quei seminari durano alcuni mesi, quindi saremmo dovuti stare insieme parecchio tempo. Ci demmo appuntamento alla Rai, dove allora lavoravo. Lo andai a attendere sul pianerottolo della scala che conduceva al mio ufficio. Lui arrivò superando con un saltello gli ultimi scalini che ci separavano tendendomi insieme la mano in segno d’amicizia. Con quei due gesti di così immediata disinvoltura e energia mi si presentò davanti una specie di mio modello estetico di uomo. Un giovane alto, magro, dinoccolato, con una faccia simpatica e discretamente felice, elegantissimo in un abito di gabardine chiaro evidentemente tagliato da un grande sarto: da buon napoletano allora guardavo molto a abiti e sarti. E subito quello sconosciuto mi sembrò uno con cui fosse naturale fare amicizia. Come il Lord Jim di Conrad, “uno dei nostri”.
Senza allora poter immaginare quanto “l’acuta percezione dell’Intollerabile” di Jim fosse la stessa di Urbani. E senza ancora sapere che Lord Jim era uno dei suoi livres de chevet: quello che porta con sé quando se ne va a morire in una casa di cura romana per colpa d’un chirurgo disgraziato. La copia nella storica edizione Bompiani con la copertina celeste delle opere di Conrad, che tu stesso hai tenuto in suo ricordo, e che lui aveva lasciato aperta sul comodino con sottolineato un brevissimo ritratto di Jim in cui evidentemente si riconosceva: “Uno di quegli uomini di brillanti qualità, non tanto stupidi da covarsi il successo e che spesso concludono la loro carriera in disgrazia”. Ma chi fu a scegliervi per partecipare al seminario di Harvard?
Questo non lo so. Furono gli americani a decidere sulla base di loro considerazioni, di cui la principale credo fosse stata l’appartenere di Giovanni e mio al versante filo-occidentale dell’intellettualità italiana. La ben precisa società liberale che gravitava intorno a “Il Mondo” di Mario Panunzio o “Il Punto” di Vittorio Calef, due riviste su cui Giovanni molto scrisse tra la seconda metà degli anni Cinquanta e gli inizi del decennio successivo, assai più sulla seconda che sulla prima. La società intellettuale su cui ancora aleggiavano l’ombra di Benedetto Croce e l’impegno civile di Gaetano Salvemini, composta da figure come Ennio Flaiano, Alberto Moravia, Elsa Morante, Giorgio Bassani, Sandro De Feo, Vincenzo Talarico, Mino Maccari, Giovanni Russo, Paolo Milano e molti altri ancora. So invece chi ci propose per partecipare a quel seminario. Giovanni fu indicato da Cesare Brandi, io da Ernesto Rossi, pilastro de “Il Mondo” e autore di celebri libri-inchiesta come Settimo non rubare o I padroni del vapore, che già denunciavano quello scollamento tra politica e società civile oggi sotto gli occhi di tutti.
Brandi segnala Urbani per Harvard. Non erano ancora i tempi in cui tra loro sorse quella mai apertamente confessata diffidenza per le reciproche posizioni teoriche. Per dire solo del restauro, Brandi, che incentra il proprio pensiero sulla restituzione estetica delle singole opere. Urbani, che storicizza la posizione di Brandi per aprirsi al quesito essenziale di quale destino si vuole dare all’arte del passato e al suo rapporto con l’ambiente, in Italia indissolubile.
L’unica incrinatura tra Giovanni e Brandi che conosco non fu per una diversità di posizioni intellettuali, ma per un piccolo screzio di carattere mondano presto superato per la sua irrilevanza. L’affetto e la stima che li legava durò infatti per entrambe le loro vite. Vero è tuttavia che Brandi, disinvolto e incantevole nella conversazione e nei libri di viaggio, nei suoi testi di critica d’arte diveniva, almeno dal mio punto di vista, astratto e teorico; in modo rigoroso, ma a volte non facile da seguire.
Un giudizio, il tuo, non isolato se Giorgio Manganelli – me lo raccontò, sorridendo, lo stesso Urbani – aveva trasformato due neologismi filosofici brandiani, “l’attante” e “l’astanza”, in: “Il l’attante che piange nell’astanza”. Nella tarda primavera del 1957 partite per l’America.
Andammo per nave, la Indipendence, perché quello era il viaggio che Harvard ci pagava. Nei sette giorni che impiegammo per arrivare si cementò l’amicizia che poi rese inseparabili Giovanni e me. Fu un viaggio bellissimo. Divertentissimo. Avevamo incontrato due ragazze americane che corteggiavamo con scherzi, incroci, risate. Era la pienezza d’esistere d’una tarda giovinezza, ma anche un dimenticarsi delle difficili situazioni personali che entrambi avevamo lasciato in Italia.
Il crepuscolo della “bella giornata” del tuo Ferito a morte?
Forse la speranza che un’altra “bella giornata” potesse iniziare in America. La terra della libertà. La terra allora lontana della miscela di glamour, jazz, gangsters e tutto il resto che avevamo immaginato là esistesse dai loro film e dai loro romanzi. Quelli che il fascismo c’aveva impedito di leggere, gli scrittori promossi da Ford Madox Ford, Hemingway ad esempio, e gli altri di cui avevano avuto un assaggio nell’Americana di Vittorini: Scott Fitzgerald, Saroyan, Steinbeck o John Fante, fino ai più giovani, come Truman Capote, che tra il 1952 e il 1953 era venuto a Roma a fare cinema e aveva abitato per qualche mese vicino a me, in via Margutta. La stessa via Margutta dell’ultima casa di Giovanni.
Film e romanzi di cui Urbani ancora mi parlava quarant’anni dopo averli visti e letti. I gangsters, che ampliava e inventava un finale al brevissimo e misterioso e bellissimo racconto di Hemingway, The killers. Oppure Il grande sonno, la traduzione cinematografica del romanzo di Chandler interpretata da Humphrey Bogart e Lauren Bacall, che vide a Capri, così mi raccontò, una sera d’estate in un cinema all’aperto per soldati americani convalescenti. Ma cosa avete fatto una volta concluso l’International Seminar di Harvard, in cui vi trovaste a diretto contatto con personaggi tra i più diversi. Da Henry Kissinger, che lo dirigeva e che, come hai scritto, Urbani “aveva incantato con i suoi modi” a Lee Strasberg, Allen Tate e perfino Joseph McCarthy?
Ci fermammo a New York. Un amico del mio amico Bill Weaver ci aveva lasciato il suo appartamento. Era il colmo di un’estate particolamente torrida. Faceva un caldo insopportabile. Con Giovanni ci aggiravamo nelle strade infossate tra i grattacieli che brillavano con le loro facciate di vetri a specchio. Scoprivamo giorno per giorno i musei, le architetture, i parchi d’una città meravigliosa, allora dominata, nella parte intellettuale, dalla frenesia e dall’energia della ricerca di nuovi orizzonti per le arti figurative: l’Action Painting, ma già era il tempo di quel New Dada prossimo alla Pop Art.


Tornati in Italia, nel 1961, ti danno lo Strega per Ferito a morte e, come hai raccontato in L’estro quotidiano, quando t’arriva il voto della vittoria “fu Giovanni a sollevarmi in alto come si fa con i campioni”. Tre anni prima, nel 1958, Urbani è invece il fine arts director del neonato Festival di Spoleto, dove organizza una pionieristica mostra – Prima Selezione di Giovani Artisti Italiani e Americani – tuttavia confermando le perplessità sull’arte contemporanea che esprimeva su “Il Punto”. Non disposto a subire supinamente un nuovo a tutti i costi che sempre più tendeva a ideologizzarsi come valore estetico, esclude dall’esposizione un lavoro di Rauschenberg, Bed, giudicandolo non un’opera d’arte, bensì quel che è: l’inutile trovata di mettere in verticale un letto, inoltre schizzandogli sopra, a sentimento, del colore, nella moda del dripping di Pollock. Né, va detto, la decisione destò scandalo. Solo dopo anni la critica, cioè il mercato, fece divenire quell’inutile giaciglio verticale un capolavoro dell’arte contemporanea, oggi esposto con grande onore al MoMA. E anche questa vicenda illumina l’incompreso – allora e adesso – interrogarsi di Urbani se uno stesso valore veritativo collegava l’arte del passato e l’arte d’oggi. Una riflessione egli che condusse soprattutto a partire dal pensiero di Heidegger, sui cui saggi iniziò a meditare già negli anni Cinquanta. In traduzioni francesi, visto che non conosceva il tedesco e che, allora, in italiano c’era solo Essere e tempo e poco più.
Io però Heidegger non l’ho mai letto. Il problema di Giovanni era la sua invincibile attrazione per le idee astratte, le teorie, il pensiero alto. Anche Hegel era un suo pallino. Spesso me ne citava a memoria passi dell’Estetica per tentare di tacitarmi nelle nostre divertite tenzoni su arte e letteratura. Il fatto è che Giovanni aveva un rispetto sproporzionato per l’intelligenza. E questo lo bloccò. Divenne per lui una specie di prigione intellettuale. Gli fece scrivere cose brillanti, sofisticate, geniali, ma meno di quello che lui era. Sono sicuro che Giovanni aveva dentro di sé un altro Giovanni che pensava con lo stesso mio senso comune, ma lo riteneva inferiore agli studi che andava facendo. E secondo me lì sbagliava, perché la sua insicurezza rispetto ai modelli intellettuali che si era scelto gli impedì di scrivere come avrebbe potuto. Questo è però il mio punto di vista. Forse per te le cose non stanno così.
Invece credo tu abbia ragione. Ma resta un fatto che la sua conferenza del 1960, significativamente intitolata La parte del caso nell’arte d’oggi, sia una delle meditazioni più profonde, persuasive e raffinate finora condotte sul problema dell’arte contemporanea. “Un piccolo capolavoro”, come lo ha definito Giorgio Agamben.
Mi ricordo. Tenne la conferenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, a Roma. Cosa ti devo dire. Sul fatto che ci sia casualità nell’arte contemporanea, Giovanni può anche aver colto nel segno. Ma il suo resta comunque un azzardo. Ed è interessante il fatto che su questo azzardo lui abbia poi costruito una teoria. Anch’io del resto, nel mio La mosca nella bottiglia, dico cose azzardate sull’arte d’oggi. Non le do però come un giudizio assoluto. È il mio rapporto con l’arte contemporanea, un fatto personale.
Sarà anche un fatto personale, ma in quel tuo piccolo pamphlet razionalista hai sostenuto un argomento su cui anche Urbani molto ha insistito, cioè che l’arte d’oggi non è arte, ma “riflessione critica sull’arte”, cioè critica d’arte. Parlando della beffarda Merda d’artista di Piero Manzoni, scrivi: “questi strappi al senso comune hanno tutti a che fare con fragili e perituri concetti più che con opere e, quando muoiono i concetti, restano le opere”. Quindi, concludo io, ti resta un barattolo di merda.
L’arte contemporanea è un’imitazione dell’arte. È fondata su dei concetti che si sostengono finché sono vivi: come se ci fosse una fede che nasce in quel momento intorno ad un’opera. In tempi più o meno rapidi quei concetti però deperiscono e alla fine tutte quelle opere tornano a essere degli oggetti che banalmente rappresentano solo se stessi. Queste credo fossero anche le considerazioni che stavano dietro la decisione di Giovanni di non esporre il letto di Rauschenberg a Spoleto.
Come venivano accolti gli interventi sempre in controtendenza di Urbani sull’arte contemporanea? Ad esempio, solo lui criticò la mostra di sculture contemporanee dentro una città che il suo amico Giovanni Carandente aveva organizzato a Spoleto in occasione del Festival del 1962. La prima del genere, subito circondata da un unanime consenso. Urbani invece la vide foriera del pericolo che, nel nome d’un ideologico quanto effimero “nuovo”, s’andassero cancellando dalle città valori storici e ambientali formati in millenni. Foriera del pericolo che ciò accadesse senza prima condurre una ben meditata riflessione sul senso della presenza del passato nel nostro mondo. E così previde quasi mezzo secolo fa quel che oggi sta accadendo, non solo da noi, ma nel mondo intero: l’ “effetto domino” di un nuovo sempre più banale e brutto che scaccia le forme tràdite dell’antico.
Di Spoleto non ricordo nulla in particolare, anche se quello che tu dici mi pare purtroppo molto vero. Mentre per gli articoli di Giovanni sull’arte contemporanea bisogna tener conto che quelli erano anni in cui non eri alla moda se non parlavi della “morte dell’arte”. Gli anni di avanguardia permanente dove tutti fondavano dei “gruppi”, indipendentemente dalla loro propensione o dall’avversione per i nuovi movimenti artistici. In quell’aria, i saggi e gli articoli di Giovanni facevano l’impressione d’essere in sintonia con quelle idee. Ma di parlarne in modo più sofisticato. Una sofisticazione destinata a pochi. Credo però che nei dubbi di Giovanni sul senso dell’arte d’oggi, come diceva lui, “l’arte che tutti possono fare”, ci fosse un qualcosa di mistico. Chi crede in Dio, non l’ha trovato. Chi ne sente l’assenza, ci crede. Questo, secondo me, era il concetto che stava al fondo del pensiero di Giovanni sull’arte.
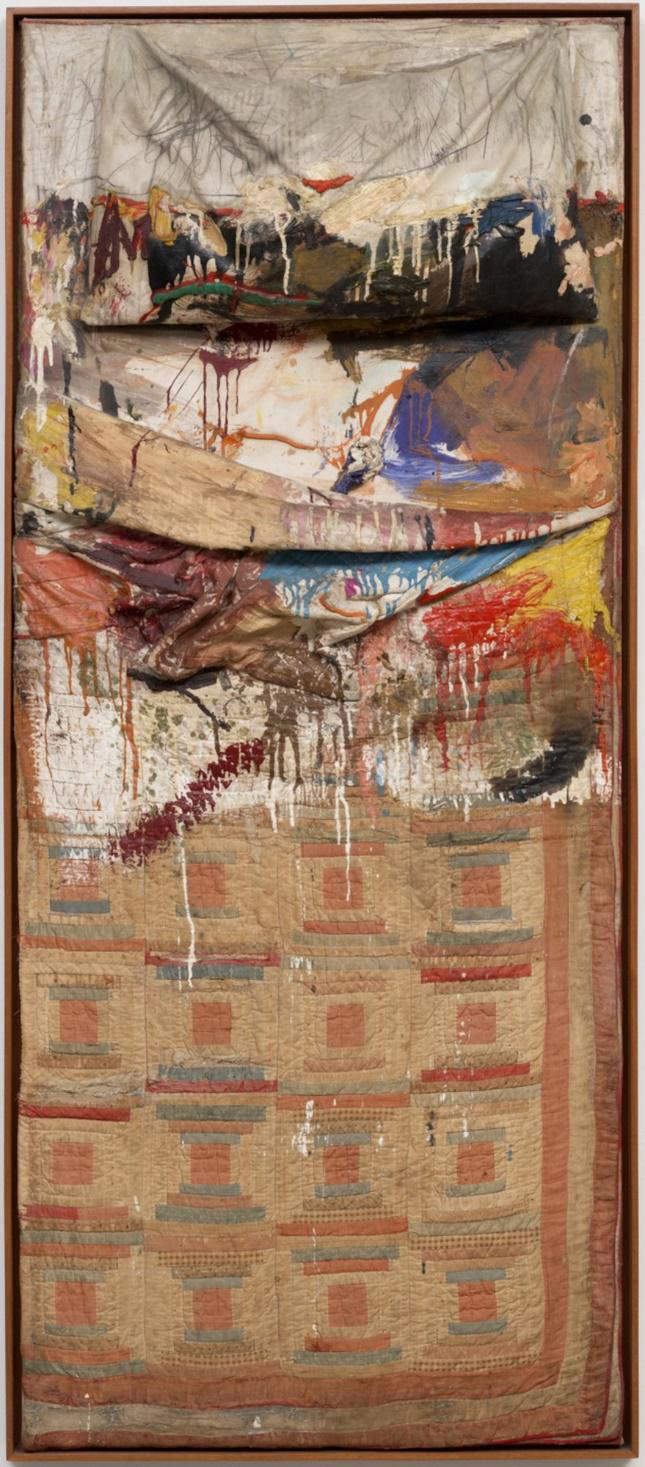


Mai però Urbani ha parlato di morte dell’arte, che per lui era, con Heidegger, “la messa in opera della verità”. Si era invece chiesto, sempre con Heidegger, se quel particolare tipo di “esperienza vissuta” in senso estetico che è l’arte contemporanea non sia “l’elemento in cui l’arte sta morendo”. Come dimostra il suo sempre più isterico insistere – complici mercato e critica – nel farsi critica di sé stessa, avvitandonsi in “provocazioni” ripetitive e eccessive. Un’arte inutile. Pura decorazione.
Certo, la verità dell’arte contemporanea non è la verità eterna dei Bronzi di Riace o della Cappella Sistina. È una verità peritura. La verità di quel momento. Ma la spinta è quella, altrimenti non ci sarebbe arte. E siamo di nuovo all’invincibile attrazione di Giovanni per il pensiero astratto. Quello che rendeva i suoi testi sempre molto complessi. Ma io dico che la sua scrittura era anche involuta. Ed era involuta perché certe volte s’attorcigliava nei periodi e nei pensieri come fa il gatto dentro al gomitolo di lana. Quando scriveva aveva questo difetto, secondo me. Di cui però non voleva sentir ragione, addebitando agli altri le difficoltà a seguire il suo pensiero. Anche con me era così. Quando parlavamo di filosofia, lo faceva con sorridente superiorità. Di me pensava che potevo essere collocato nel settore di quelli interessanti dal punto di vista della genuinità, come può essere interessante chi ti dice che “il re è nudo”. Era una sfida tra noi, una sfida affettuosa e sorridente in cui lui faceva la parte di Don Chisciotte, io di Sancho Panza.
Forse più che involuti i testi di Urbani erano esigenti. Esigevano da parte di chi li leggeva una forte assunzione di responsabilità verso i propri compiti civili, verso il dovere di prepararsi con molta serietà circa i problemi che il destino ci impone d’affrontare. Abbiamo però fissato troppo l’attenzione su Urbani critico dell’arte d’oggi, cioè su quella che fu solo una tappa del suo cammino verso la conservazione dell’arte del passato. Un cammino che, semplificando, può essere suddiviso in tre passaggi.
È assolutamente vero che Giovanni era un uomo molto esigente. Che faceva tutto con grandissima serietà e rigore. E che pretendeva dagli altri lo stesso rigore, o almeno se l’aspettava. Ma ti ho interrotto. Mi dicevi dei tre passaggi del percorso intellettuale di Giovanni verso la conservazione dell’arte del passato. Quali sono stati, secondo te?
Il primo va dal suo ingresso all’Icr nel 1945 e arriva all’incirca al periodo del vostro viaggio in America. In quella decina d’anni egli prende atto della sostanziale labilità – critica e conservativa – degli interventi di restauro, a partire da quelli condotti dall’Icr, quindi al massimo livello allora possibile. Tanto che in un saggio del 1967 che ritengo un altro suo “breve capolavoro”, Il restauro e la storia dell’arte, si chiede: “E allora, potremmo ancora pretendere di non star restaurando come si è sempre restaurato: cioè alterando o manomettendo?”. Il secondo passaggio va all’incirca dalla metà degli anni Cinquanta a quella del decennio successivo e coincide con la sua meditata riflessione sul senso dell’arte d’oggi in rapporto a quella del passato. Concludendo che la prima non ha alcuna continuità veritativa con la seconda. Da qui la conservazione dell’arte del passato come destino dell’uomo d’oggi. Il terzo e ultimo passaggio nasce con l’alluvione di Firenze del 1966. A seguito di quel così grave disastro, egli elabora un grande disegno organizzativo di conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale in rapporto all’ambiente. Da una parte, l’invenzione d’una inedita tecnica – ovviamente tecnica in senso heideggeriano – cui dà il nome di “conservazione programmata”. Dall’altra, la fondazione di una “ecologia culturale” che riconosce il patrimonio artistico come “componente ambientale antropica altrettanto necessaria, per il benessere della specie, dell’equilibrio ecologico tra le componenti ambientali naturali”.
Giovanni era davvero un uomo singolare. Raffinatissimo e complicatissimo nelle sue teorizzazioni, infinitamente pragmatico e puntuale nella soluzione dei problemi tecnici e organizzativi. Del resto: “erano le contraddizioni, a volte insostenibili e spesso incompatibili, ma sempre irresistibili, la vera originalità di Giovanni, che mai si chiudeva in una figura ben definita per una specie di insofferenza esistenziale”, come ho scritto in L’estro quotidiano.
Non direi che esisteva contraddizione tra quelle due facce di Urbani. Trait d’union era la convinzione che alle elaborazioni di pensiero sempre dovessero seguire concrete indicazioni applicative, essenziali per consentire, come lui ha scritto, “l’integrazione materiale del passato nel divenire dell’uomo”. Vero è invece che la figura di Urbani per molti versi somiglia a quella dell’“Anarca” di Jünger, l’uomo “che combatte le proprie guerre anche quando marcia tra le fila di un esercito”. Solo che la sua guerra era troppo superiore alle forze dell’esercito con cui aveva a che fare. I soprintendenti, che ancora oggi intendono la tutela come un esercizio ottocentesco di potere da condurre in forza di competenze burocratiche, quindi un affare di divieti e permessi, e mai in forza di scopi, quindi con azioni razionali e coerenti.
È stato veramente un crimine aver lasciato cadere nel nulla il lavoro di Giovanni per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. Quello per cui si era con tanta serietà preparato. Averlo abbandonato a sé stesso, fino a farlo decidere d’andarsene sbattendo la porta. Le sue dimissioni anticipate dalla carica di direttore dell’Icr, nel 1983. Giovanni ha creduto fermamente nello Stato che serviva con assoluto zelo. Ma lo Stato lo ha ricambiato tradendolo. La Patria per lui era l’insieme delle opere d’arte che i nostri avi ci hanno lasciato. Sentiva quindi l’obbligo e l’onore della loro difesa. Così concepiva la sua presenza all’Istituto del restauro. Ma le istituzioni preposte al governo di questa nostra Patria mai hanno riconosciuto l’importanza e l’utilità del suo lavoro. La sua dedizione. La storia di Giovanni è una storia di diversità intellettuale e morale. Quella che i colleghi percepivano come un pericolo.
Credo però ci fossero anche delle ben concrete ragioni d’interesse economico. L’idea di Urbani di fare della tutela del patrimonio artistico tutt’uno con la tutela dell’ambiente inevitabilmente collideva con la libera aggressione territoriale che avviene nel nostro Paese soprattutto da dopo la seconda guerra mondiale. Questa credo sia stata la decisiva causa dell’opposizione a Urbani della politica, nei fatti, sempre a favore della speculazione edilizia, indipendentemente dai partiti.
Ho sceneggiato nel 1963 Le mani sulla città di Francesco Rosi, quindi conosco bene le logiche del disastro urbanistico del nostro paese. Il fatto è che, allora, ci sembrava possibile che grazie al nostro impegno le cose potessero cambiare. Siamo stati davvero “gli zimbelli della Storia” come ho scritto, pur se in altro contesto. E anche Giovanni lo è stato pensando che nel nostro Paese ci fosse chi era davvero interessato alla custodia e alla cura del patrimonio artistico e del paesaggio.
Infatti, alla difesa degli interessi speculativi era palindromo il ritardo culturale del settore. Quello che nel 1976 originò asprissime polemiche contro il “Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria”, il progetto organizzativo per la tutela del patrimonio artistico in rapporto all’ambiente in cui Urbani aveva più creduto. Un piano che egli aveva steso chiedendo aiuto alla ricerca scientifica e tecnologica dell’industria, quella dell’Eni. Una modernizzazione del settore contro cui insorsero come un sol uomo tutti i suoi colleghi soprintendenti e molti professori universitari. Coinvolgendo le competenze d’una struttura industriale, appunto l’Eni, con ampia capacità tecnica e imprenditoriale e con veri mezzi per operare, Urbani portava una seria minaccia al burocratico immobilismo statalista, in Italia sempre vincente. Infatti soprintendenti e professori vinsero. E il settore è rimasto perfettamente immobile.
Fu un’aggressione stupida e violenta di cui Giovanni molto soffrì. Va però detto che in quegli anni erano ancora ben vive figure di grandi storici dell’arte certamente capaci di capire e apprezzare quello che lui stava facendo. Brandi era senz’altro in grado di capire il progetto di Giovanni. E lo stesso valeva per Argan o per Zeri. Tutti loro potevano comprendere il valore e l’utilità del lavoro di Giovanni per la conservazione dell’arte del passato. Perché non l’hanno difeso?
Appunto perché non erano in grado di capire quei progetti. Forse solo Brandi conosceva davvero i lavori di Urbani. Mentre Argan si dichiarò contrario al “Piano” umbro quasi certamente senza averlo guardato, ma capendo, da uomo di potere quale prima di tutto era, che dalla sua applicazione la corporazione degli storici dell’arte (la sua) ne sarebbe uscita fortemente ridimensionata. Inoltre tra Argan e Urbani esisteva una lontana e invincibile antipatia, prima di tutto caratteriale, ma anche probabilmente originata dalle diverse posizioni assunte sull’arte contemporanea tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Argan, comunista, tetramente ideologico e filomercantile. Urbani, liberale, indipendente e sicuro che un fregaccio tracciato a caso su una tela, un elefante di cartapesta con un lenzuolo in testa o un foglio di plastica bruciato non potevano avere alcun vero e durabile valore: in primis veritativo, ma anche economico. Invece Zeri, alla fine della sua vita, riconobbe proprio con me il suo errore nell’aver sottovalutato la profondità del pensiero di Urbani.
Bisogna dire che Giovanni non lo ha difeso nessuno? Nemmeno i suoi maestri? Nemmeno Brandi, che pure lo ha promosso in tante cose, ma non in questo suo così importante aspetto creativo e di passione civile? Serve alla memoria di Giovanni dire tutte queste cose?
Vorrei concludere questo dialogo tornando al tuo Ferito a morte. Anche di Urbani, del chiudersi per sempre della sua “bella giornata”, si può dire: “fanne un mistero, se vuoi, ma non un dramma”?
Purtroppo credo sia impossibile fare della “bella giornata” di Giovanni “un mistero e non un dramma”. Come Lord Jim, Giovanni si è portato appresso tutta la vita la macchia d’una colpa da riscattare. Una macchia che era condizione della mente d’un uomo d’onore, quale egli fu prima di tutto, e che volta a volta prendeva la forma del dolore per il suo unico figlio morto bambino, del suo snobismo, del fallimento del suo lavoro così assiduo e appassionato e di chissà cos’altro. Una macchia indelebile, perché irriducibile ombra del suo inconscio. Ma sai com’è difficile spiegare la vita? Com’è difficile spiegare l’insensato spreco di quell’uomo meraviglioso che è stato Giovanni? “Dón Gió/vanni/ Búrlador/, maître à pensèr/ e grànd charmèur... ”, come lo canzonavo in una filastrocca che avevo inventato per lui e a volte gli canticchiavo per gioco sull’aria di Escamillo, il “Toreador” della Carmen...
(ottobre 2008)
La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.