La prima mostra monografica dedicata a Bartolomeo Cesi (Bologna, 1556 - ivi, 1629), aperta dal 22 novembre 2025 al 22 febbraio 2026 nel Lapidario del Museo Civico Medievale di Bologna, propone una revisione ampia e documentata della figura del pittore bolognese, attivo tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. L’esposizione Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci, curata da Vera Fortunati e realizzata dal Comune di Bologna con i Musei Civici, la Biblioteca dell’Archiginnasio e l’Arcidiocesi di Bologna, si inserisce nel programma del Giubileo 2025, con la collaborazione dei Musei nazionali di Bologna e la main partnership di Gruppo Hera. Il percorso intende restituire il ruolo di Cesi all’interno della vivace geografia artistica cittadina in un’epoca segnata dal confronto serrato con la rivoluzione naturalistica dei Carracci. Il pittore, noto soprattutto per opere di destinazione religiosa, elaborò un linguaggio autonomo, distante dal naturalismo diretto dei tre cugini e orientato verso una dimensione meditativa, costruita attraverso figure immobili, cromie intense ma calibrate e paesaggi isolati. La critica ha spesso sottolineato come la sua produzione anticipi la ricerca di un ideale sovrasensibile che troverà pieno sviluppo nella pittura di Guido Reni, suggerendo una poetica in cui la contemplazione supera l’osservazione del reale.
“Ci sono perle del nostro patrimonio artistico che restano ancora oggi da scoprire. La mostra Bartolomeo Cesi (1556 – 1629)”, afferma Daniele Del Pozzo, Assessore alla Cultura Comune di Bologna. “Pittura del silenzio nell’età dei Carracci è la prima monografica dedicata al pittore e ha il merito indiscusso di portare in luce e restituire alla giusta attenzione un protagonista di assoluto rilievo della scena artistica bolognese della Controriforma. La mostra toccherà più luoghi e costituirà un percorso diffuso in città e costituisce di fatto un sistema virtuoso di lavoro comune, coordinato dal Comune di Bologna in stretta e pregevole collaborazione con la Curia Arcivescovile di Bologna, la Pinacoteca nazionale di Bologna, l’Università di Bologna, oltre a sponsor, istituti e organizzazioni pubbliche e private della città. Un deciso investimento di risorse – economiche certo, ma anche di fondamentali competenze professionali e di passione umana – che ha consentito anche di restaurare, in occasione della mostra, tre opere dell’artista; una vera e propria azione di cura del nostro comune patrimonio artistico”.
“Il genio artistico di Bartolomeo Cesi”, afferma Mons. Stefano Ottani, Arcidiocesi di Bologna, “la sua personale spiritualità e anche la docilità ai principi del cardinale Paleotti, lo rendono un modello di artista “riformato”, non “contro” altre proposte artistiche: una nuova sintesi capace di ricapitolare tempo e spazio nell’essenzialità. Occorre fermarsi in silenzio, meditando e pregando, davanti alle sue opere per esserne misteriosamente coinvolti, per essere attratti oltre il visibile e il presente”.


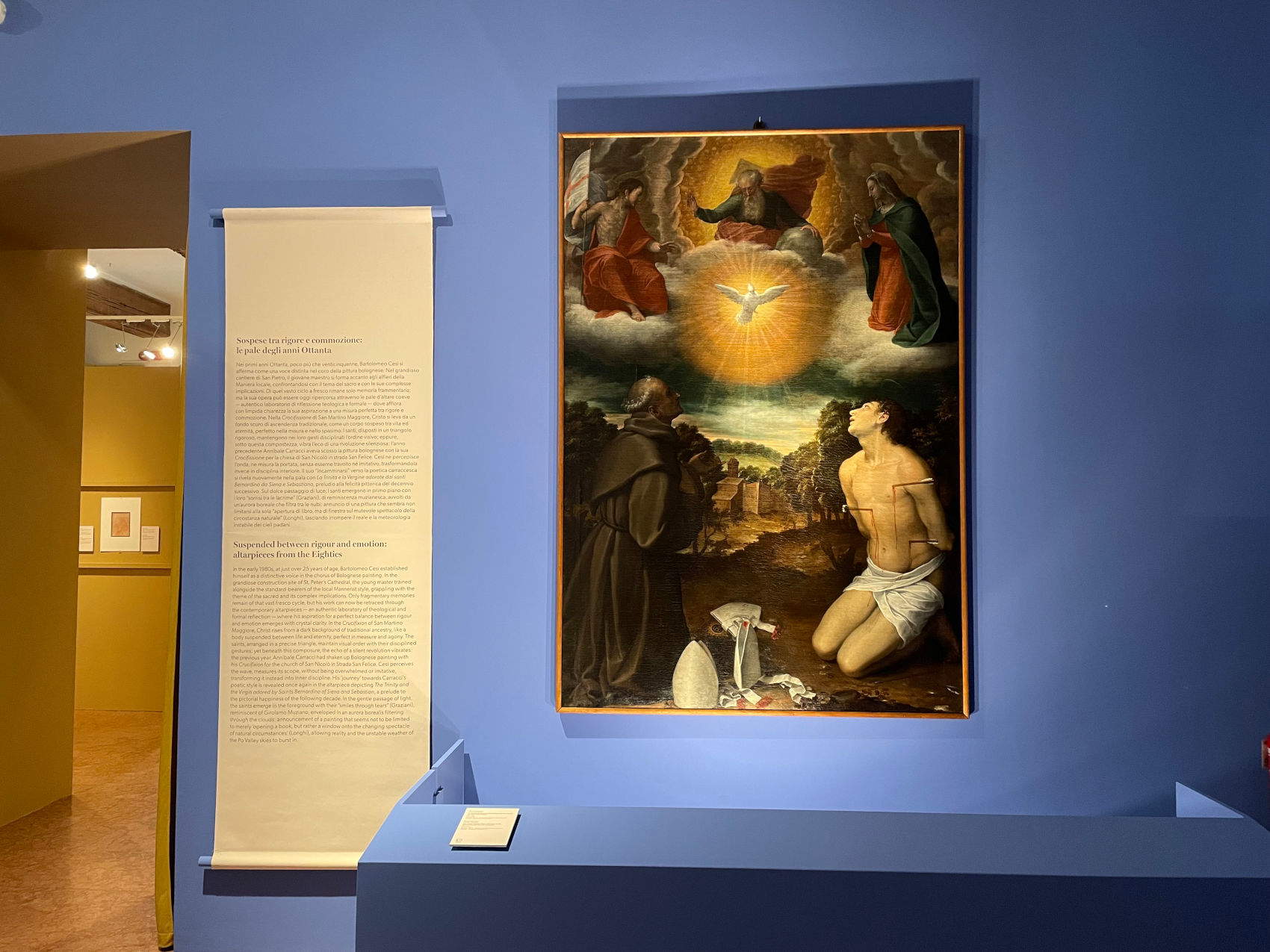

La mostra assume anche un ruolo operativo sul patrimonio cittadino grazie agli interventi di restauro promossi dal Comune di Bologna su quattro opere di difficile accessibilità. Rientrano in questa cornice la Trinità e Vergine adorate dai santi Bernardino da Siena e Sebastiano, proveniente dal Policlinico Sant’Orsola; la pala Madonna con il Bambino in gloria e i santi Benedetto, Giovanni Battista e Francesco dalla chiesa di San Giacomo Maggiore; San Benedetto seduto della Città metropolitana di Bologna e San Francesco in preghiera dei Frati Minori Cappuccini. Le operazioni costituiscono un apporto sostanziale alla valorizzazione del patrimonio religioso bolognese, tuttora radicato nei luoghi di origine. La ricezione critica di Cesi ha conosciuto diverse fasi. Storici come Malvasia e Lanzi lo considerarono una figura di raccordo tra manierismo e naturalismo, capace di conciliare modelli aggiornati con elementi ancora legati a un lessico precedente. Lanzi, nella Storia pittorica dell’Italia, riprese apprezzamenti già formulati da Malvasia, sottolineando la sua capacità di offrire un linguaggio misurato, nitido e incline alla verità del naturale. Nel Novecento, anche grazie al contributo di Alberto Graziani, si è consolidata l’idea di Cesi come interprete della Controriforma, attento alla chiarezza narrativa e alla capacità di coinvolgere emotivamente lo spettatore senza ricorrere a toni drammatici.
Il percorso espositivo prende in esame il periodo più fecondo dell’artista, compreso tra il 1585 e il 1597, quando Cesi si confrontò con le innovazioni introdotte dai Carracci elaborando una sintesi personale tra tradizione e nuovi orientamenti. Oltre trenta opere, tra dipinti, disegni e pale d’altare, compongono un itinerario articolato in cinque nuclei tematici: formazione, ritratti, disegni, pale d’altare e cicli certosini. La sezione dedicata alla formazione presenta il contesto culturale bolognese della fine del Cinquecento, segnato dall’azione riformatrice del cardinale Gabriele Paleotti e dal clima religioso promosso dal pontificato di papa Gregorio XIII, originario di Bologna. Il Discorso sulle immagini sacre e profane pubblicato da Paleotti nel 1582 influenzò profondamente l’ambiente artistico locale, promuovendo un’idea di immagine sacra come strumento di edificazione spirituale e mediazione didattica. Cesi, allievo del Nosadella (Giovanni Francesco Bezzi) e formatosi all’interno della tradizione bolognese, rispose a queste sollecitazioni con particolare attenzione, come dimostrano gli interventi nella cattedrale di San Pietro tra il 1579 e il 1585, purtroppo quasi del tutto perduti.
La sezione dei ritratti riunisce quattro delle dieci opere attribuite all’artista, evidenziando la sua capacità di indagare l’interiorità dei soggetti effigiati. Il Ritratto di gentiluomo venticinquenne con la spada del 1585, conservato a Imola, rappresenta un punto di riferimento nella definizione del suo stile ritrattistico. Accanto a questo dipinto è esposto il Ritratto di frate del 1592, caratterizzato da una maggiore aderenza al vero, e il Ritratto di certosino in veste di Dionisio Cartusiano, piccolo dipinto nel quale la figura appare immersa in una dimensione introspettiva che richiama l’ambiente monastico certosino, destinato a diventare centrale nel percorso di Cesi. Il disegno costituisce un ambito essenziale della sua attività: Cesi si dedicò allo studio dal vero, adottando un metodo di lavoro vicino a quello dei giovani Carracci. Le opere grafiche esposte testimoniano una progettazione articolata, nutrita da riferimenti eterogenei che spaziano da Raffaello e Correggio fino ai riformati toscani e ai senesi barocceschi. I ritratti di giovani colti dal vero, utilizzati poi come base per figure di santi o profeti, evidenziano l’intenzione di fondere osservazione e idealizzazione.
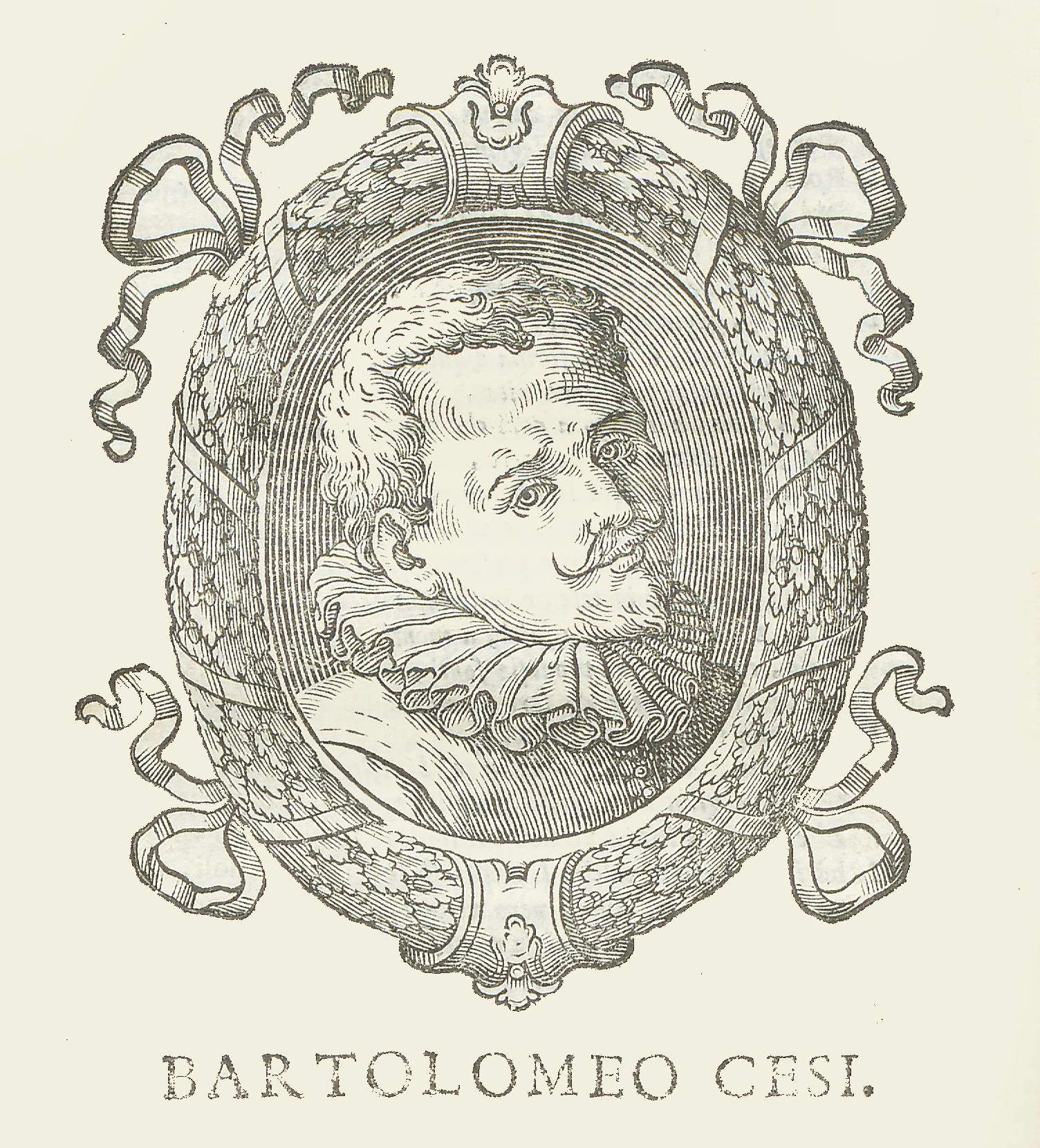




La sezione successiva raccoglie alcune tra le pale d’altare più rilevanti. In queste opere Cesi interpreta il naturalismo carraccesco rinunciando però agli aspetti più quotidiani della rappresentazione, privilegiando invece un registro contemplativo. Il confronto, implicito ma evidente, emerge rispetto alla pala dell’Annibale Carracci del 1583 in Santa Maria della Carità, considerata scandalo per il suo linguaggio diretto. Cesi, al contrario, nelle sue opere tende a un equilibrio fra tradizione accademica e adesione al vero, come nella pala con il Crocifisso con i Santi Andrea, Pietro, Toma e Paolo, realizzata tra il 1584 e il 1585 per la basilica di San Martino Maggiore.
Tra i lavori più importanti spiccano le opere eseguite per la chiesa di San Procolo, tra cui San Benedetto ascolta la celeste armonia e San Benedetto seduto, dipinti che uniscono monumentalità, attenzione al paesaggio e adesione al dettato post-tridentino. L’apice della maturità cesiana viene individuato nella pala della Madonna con il Bambino in gloria e i santi Benedetto, Giovanni Battista e Francesco, destinata alla cappella Paleotti in San Giacomo Maggiore, considerata dalla critica un esempio emblematico della pittura controriformata bolognese. Gli anni Novanta del Cinquecento segnano anche il profondo legame tra Cesi e l’Ordine certosino. Il ciclo per la cappella maggiore della chiesa di San Girolamo della Certosa, realizzato tra il 1593 e il 1597, rappresenta uno dei vertici della pittura bolognese del periodo. Le tre grandi tele dedicate ai momenti culminanti della Passione, collocate originariamente nel coro dei monaci, mostrano una costruzione visiva rigorosa, arricchita dalla presenza delle figure certosine collocate nelle nicchie dipinte.
Il complesso, oggi considerato un caposaldo della pittura post-tridentina, è presentato in mostra insieme alle due tele di Ludovico Carracci per le pareti opposte del coro, la Flagellazione e Gesù Cristo incoronato di spine, realizzate tra il 1597 e il 1599. Il confronto mette in luce due approcci divergenti: la crudezza realistica di Ludovico, non sempre gradita dai religiosi, e la scelta di Cesi per un linguaggio più composto e meditativo. Il percorso espositivo è affiancato da un’esperienza digitale accessibile tramite l’app MuseOn, che permette di approfondire 23 opere della mostra attraverso testi e contenuti audio in italiano e inglese. Una ricostruzione in realtà virtuale consente inoltre di rivedere le Storie della Vergine affrescate da Cesi nella cappella di Santa Maria dei Bulgari all’Archiginnasio, perdute nel bombardamento del 1944 e ora ricreate grazie alle fotografie di Felice Croci. L’intervento si inserisce nel progetto SIMBOLO - Il sistema digitale dei Musei Civici di Bologna verso il futuro, sostenuto dai fondi europei PR-FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.
“La mostra dedicata a Bartolomeo Cesi”, continua Costantino D’Orazio, Direttore ad interim Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, “ha visto subito la Pinacoteca nazionale di Bologna partecipare con grande entusiasmo, non solo perché l’iniziativa permette di valorizzare alcuni capolavori presenti all’interno del museo, che il pubblico potrà ammirare con ancora maggiore attenzione e consapevolezza, ma anche perché lo spirito di collaborazione tra le istituzioni bolognesi risponde perfettamente alla missione del nostro Istituto. Un museo nazionale è custode di un patrimonio che corrisponde all’identità culturale di un territorio, con il quale deve sempre connettersi e per il quale deve lavorare, al fine di contribuire allo sviluppo sociale del contesto in cui è inserito”.
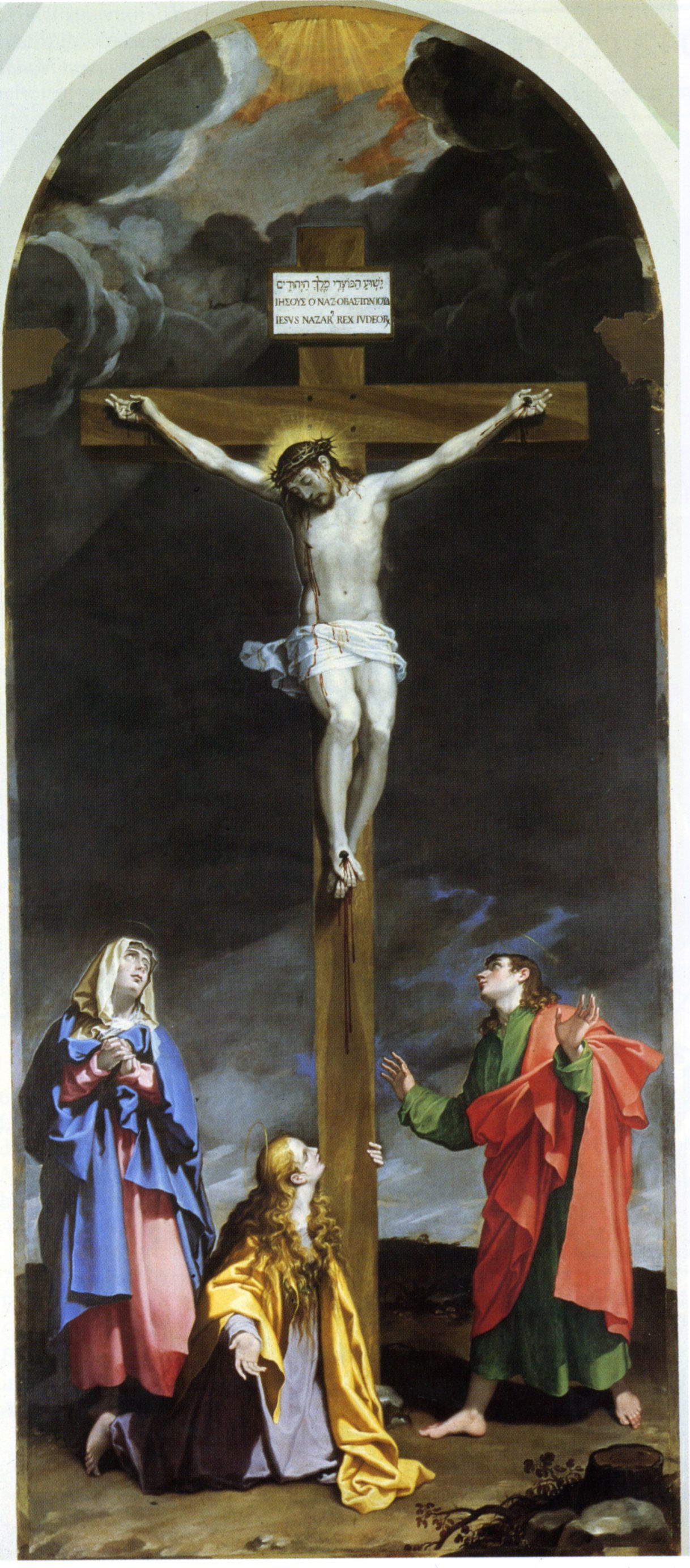



“Avevo vent’anni”, sostiene Vera Fortunati, già Professoressa Ordinaria di Storia dell’Arte Moderna Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e curatrice mostra, “quando, nel primo esame universitario di Storia dell’Arte medioevale e moderna, portando come programma anche il catalogo della mostra Maestri della pittura del Seicento emiliano (1959) ho conosciuto Bartolomeo Cesi attraverso le schede di alcuni suoi dipinti curate da Francesco Arcangeli. Sono rimasta affascinata dalla personalità di questo pittore che mi apparve profondamente diverso da tutti gli altri. Un amore giovanile che è cresciuto nel tempo tanto che, dopo la mostra su Lavinia Fontana del 1994, ho presentato un progetto dedicato a Cesi e al contesto storico artistico bolognese di maturo Cinquecento, progetto che non ha trovato il consenso e l’appoggio delle istituzioni cittadine. Infine è stata la conoscenza della bella tesi di dottorato sulle pitture di Bartolomeo Cesi della giovane studiosa Flavia Cristalli (Scuola Normale di Pisa) a convincermi che forse era giunto il momento per un dialogo fra studiosi diversi, per generazione e formazione, su questo straordinario artista. In questo contesto è nato il mio nuovo progetto che ha voluto privilegiare il periodo più felice della produzione di Cesi (1585-1597 circa) quando Bartolomeo, confrontandosi con l’innovativo sperimentalismo dei coetanei Carracci, approda ad un sublime classicismo naturalistico: un’alta qualità figurativa dove l’arte si inabissa in un percorso di silenzio e di preghiera proprio degli ordini monastici con cui il pittore ama lavorare”.
La rassegna trova un completamento naturale nelle sale della Pinacoteca nazionale di Bologna, dove il percorso espositivo recentemente rinnovato permette di confrontare direttamente le opere di Cesi con quelle dei Carracci e di Guido Reni. Qui, dalla Santa Cecilia di Raffaello fino alle grandi pale seicentesche, emerge l’intreccio tra tradizione manierista, riforma carraccesca e spiritualità post-tridentina, elementi fondamentali per comprendere l’opera del pittore bolognese. Il programma della mostra include visite guidate gratuite su prenotazione, attività per adulti e famiglie, e tre itinerari urbani organizzati da Fondazione Bologna Welcome, dedicati ai luoghi in cui Cesi lavorò. Le iniziative mirano a valorizzare il patrimonio cittadino e a favorire una conoscenza diretta delle opere ancora presenti sul territorio. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale, con saggi di numerosi studiosi. È inoltre disponibile una guida, curata da Giovanna Degli Esposti, che presenta le opere di Cesi conservate a Bologna attraverso un itinerario organizzato per tipologia di luogo. L’intero progetto espositivo è reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati impegnati nella tutela e promozione della storia artistica cittadina.
| Titolo mostra | Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci | Città | Bologna | Sede | Museo Civico Medievale | Date | Dal 22/11/2025 al 22/02/2026 | Artisti | Bartolomeo Cesi | Curatori | Vera Fortunati | Temi | Seicento, Cinquecento, Bologna, Arte antica |
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.