A Napoli, nel complesso di Santa Maria La Nova, un mistero di cinque secoli ha attirato l’attenzione di studiosi (e anche dei media): la possibile sepoltura di Vlad III di Valacchia, il principe che la leggenda ha trasformato in Dracula. L’indagine è guidata da Giuseppe Reale, direttore del complesso e consulente, che da oltre dieci anni coordina un gruppo di ricercatori tra archeologia, filologia e filosofia della memoria. Lo studio è partito da una lastra sepolcrale cinquecentesca con un drago, che ha suggerito legami con la famiglia Ferillo e con Maria Balsa, forse figlia o nipote del voivoda valacco. Nel 2014 è stato scoperto il Codice La Nova, un’iscrizione interpretata come possibile elogio funebre a “Vlad il Pio”. Santa Maria La Nova diventa dunque anche luogo di studio e riflessione sul mistero della storia. Qui l’intervista al direttore offre un’occasione per approfondire gli studi e le ricerche condotte all’interno del complesso.
NC. Direttore, davanti a una lastra che da cinque secoli custodisce il suo segreto, cosa significa oggi dichiarare che proprio a Napoli potrebbe trovarsi la sepoltura di Vlad III, il principe che il mito ha trasformato poi in Dracula?
GR. La lastra del monumento funebre di Matteo Ferillo non indica il luogo della sua sepoltura. Si tratta, piuttosto, di un elemento simbolico. Proprio nel 2014, l’immagine del grande drago scolpito su questo monumento marmoreo, collocato nel chiostro di San Giacomo, ha dato origine a un percorso di indagine che ha stimolato nuove riflessioni e ricerche. Abbiamo in ogni caso alcune certezze, acquisite ormai da diversi anni. Il sepolcro di Ferillo, come altri simili, non si trovava originariamente nel chiostro, ma all’interno della chiesa. Un documento recentemente consultato conferma infatti che la cappella Ferillo era situata ai lati dell’altare maggiore, dove rimase presumibilmente fino al 1588. È quindi necessario distinguere la dimensione simbolica e immaginifica della vicenda (che continua a esercitare grande fascino), dalle evidenze storiche che progressivamente stiamo consolidando. Le sepolture di Santa Maria La Nova, come in molte altre chiese fino all’inizio dell’Ottocento, erano per lo più collocate in camere sepolcrali sotterranee. Le cappelle gentilizie, i mausolei e i monumenti funebri rappresentavano un racconto figurativo per i fedeli, mentre i corpi venivano tumulati sotto la pavimentazione, secondo diverse tecniche di inumazione. Questo vale anche per Santa Maria La Nova, dove tale pratica è ormai documentata. Inoltre, il monumento di Matteo Ferillo ha consentito di tracciare legami importanti tra la chiesa di Santa Maria La Nova e la cripta di Giacomo Alfonso Ferillo e della moglie Maria Balscia, situata nella cattedrale di Acerenza. Da qui è stato possibile sviluppare connessioni più ampie tra Napoli, Acerenza e i territori della Valacchia, anche attraverso lo studio di altri sepolcri. Tra questi, uno dei più discussi è quello di Costantino Castriota Skanderbeg, oggi collocato anch’esso nel chiostro di San Giacomo, ma originariamente posto nella zona del coro inferiore. I monumenti, dunque evocano presenze e storie che la ricerca storica continua a interrogare. È su questo legame di simboli, documenti e ipotesi che si è sviluppato un lavoro decennale di studio, volto a ricostruire percorsi e relazioni ancora oggi avvolti nel mistero.

Quando e come è nata l’idea di approfondire scientificamente le sepolture e i frammenti che avete analizzato?
Proprio a partire dalle connessioni geografiche tra il Regno di Napoli, l’Ordine del Dragone e la penisola balcanica, ci siamo posti una serie di domande. Interrogativi che si sono uniti con l’analisi di una ricca simbologia, tipica dei monumenti che appartengono a una lunga tradizione storico-artistica. Una simbologia che, per chi vive in contesti culturali diversi, richiede un lavoro di decodifica complesso e affascinante. Durante le prime ispezioni, avviate nel 2014, osservai alcuni elementi che meritavano attenzione. Ricordo che mi colpì un’iscrizione collocata in una cappella attigua al monumento di Matteo Ferillo. Sapevo già che il sepolcro, per quanto suggestivo, non si trovava lì: lo indicava un’iscrizione sul monumento stesso, in cui si legge che era originariamente posto nel sacello dedicato alla Vergine Assunta. Avviai così una ricerca sulle possibili collocazioni e, nel corso di questo percorso, mi imbattei in un’altra iscrizione nella cappella Turbolo, una cappella gentilizia situata quasi alle spalle dell’attuale posizione del monumento Ferillo. Consultando la Guida di Santa Maria La Nova scritta nel 1927 da padre Gaetano Rocco, francescano, trovai che egli descriveva quell’iscrizione come una “lapide marmorea” che traduceva in greco una bolla papale latina di Gregorio XIII. L’affermazione mi spinse a riflettere. In primo luogo, l’iscrizione non era affatto marmorea, bensì dipinta; in secondo luogo, non si trattava di un testo greco vero e proprio, ma di una sequenza di segni discontinui, non riconducibili a un’unica grammatica o sintassi. Mi domandai quindi perché padre Gaetano l’avesse descritta in quel modo e perché studi successivi si fossero limitati a ripetere la sua interpretazione senza verificarla direttamente. Un semplice confronto visivo con la bolla papale di Gregorio XIII del 1576 mostrava chiaramente l’incongruenza: il testo latino della bolla era molto più esteso rispetto alle righe presenti sull’iscrizione della cappella. Quell’osservazione mi fece intuire che si nascondesse qualcosa di più complesso. Nacque così l’idea di quello che poi definimmo “codice La Nova”. Un aspetto curioso è che l’iscrizione sia sopravvissuta alle numerose trasformazioni della grande cappella dedicata a San Giacomo della Marca, all’interno della quale si trova la cappella Turbolo. Sul finire del Quattrocento, infatti, il viceré spagnolo trasformò una chiesa preesistente in un grande spazio di culto e di sepoltura dedicato a San Giacomo, morto nel 1476. Nonostante i mutamenti successivi, l’iscrizione rimase visibile, sebbene parzialmente imbrattata e, come si è visto nel restauro del 2018, mimetizzata nella cornice come fosse una lastra marmorea. Dopo il restauro, invitai l’ingegner Falcucci a esaminarla, e pur non appartenendo al nostro gruppo di studio, ipotizzò inizialmente che si trattasse di un’iscrizione tardo-ottocentesca. In ogni caso, le analisi successive portarono a conclusioni diverse. Non si riscontravano differenze di malta tra la parte iscritta, la cornice e gli affreschi circostanti, databili all’inizio del Cinquecento: ciò suggeriva una coeva realizzazione. Inoltre, l’esame dei pigmenti prelevati da cornice e lettere mostrò che il colore delle lettere era due o tre volte più spesso, segno di una datazione anteriore rispetto a quella ottocentesca ipotizzata in partenza. Si è quindi potuto retrodatare l’iscrizione, collocandola non nel XIX secolo, ma in un periodo più vicino al 1575, anno del sepolcro della famiglia Turbolo. Questo permetteva di escludere qualsiasi legame con la bolla papale del 1576 e di riconoscere nel codice La Nova un documento autonomo e più antico. In alcuni punti del testo appariva chiaramente il nome “Vlad”, circostanza che ha reso ancora più interessante la ricerca. Invitai quindi esperti di linguistica provenienti dall’Europa dell’Est a visionare l’iscrizione. Ognuno di loro riuscì a riconoscere frammenti, ma nessuno poté darne una lettura completa. Il potenziale narrativo e simbolico della figura di Dracula tende a oscurare la complessità storica di Vlad III, il personaggio reale. Il nostro obiettivo è stato proprio quello di separare la leggenda dal dato storico, liberando Vlad III dall’ombra letteraria di Dracula. Negli anni successivi, grazie al confronto con un team di studiosi rumeni, la ricerca ha compiuto un salto di qualità. Il loro contributo, radicato nella conoscenza della cultura e della simbologia nazionale, ha permesso di trasformare i nostri interrogativi in ipotesi storiche più solide, rafforzando le connessioni tra Napoli, la Valacchia e l’Ordine del Dragone.
L’elogio funebre cita un sovrano, Vlad il Pio, che è stato “ucciso due volte” e “onorat[o] come un martire”. Può spiegarmi meglio? In che modo il concetto menzionato rafforza l’identificazione con Vlad III rispetto ad altri possibili personaggi dell’epoca?
Attorno al tentativo di decifrare l’iscrizione si sono concentrati, nel corso di dieci anni, numerosi studiosi. Tutto è iniziato con una call internazionale del 2014: un confronto aperto da cui emerse un fatto curioso, ovvero che nessuno riusciva a riconoscere in quel testo i tratti di una lingua nota. Non apparteneva a nessuna lingua classica né a quelle “archeologiche” che tramandano la memoria delle civiltà antiche. Il lavoro, dunque, procedette per esclusione più che per affermazione. In quella fase furono coinvolti anche giovani ricercatori che sperimentarono tecniche di decodifica informatica. L’idea in verità non era nuova: in quegli stessi anni un ricercatore italiano negli Stati Uniti aveva utilizzato sistemi analoghi per decifrare un antico testo aragonese. Ci muovevamo quindi nella stessa direzione, alla ricerca di un metodo che potesse rivelare il senso nascosto di quel codice. Un punto di svolta arrivò con la collaborazione di Mircea Cosma, a capo della Società Storica di Ploiești, in Romania. Mircea lavorava insieme a Christian Tufan, esperto di greco bizantino, e già nei primi scambi Cosma mi aveva anticipato alcune ipotesi di lettura, seppur ancora frammentarie. La vera svolta avvenne il 28 giugno 2025, durante un incontro a Snagov, uno dei luoghi tradizionalmente legati alla figura di Vlad III. In quell’occasione, Tufan presentò pubblicamente una proposta di interpretazione completa dell’iscrizione, corredata da una traslitterazione in greco e da una traduzione in rumeno, che io successivamente ho tradotto in italiano. È lui a firmare e ad assumersi la responsabilità scientifica della lettura, che abbiamo pubblicato nel volume Vlad, dove sei? Indizi del Codice La Nova di Napoli, edito da La Valle del Tempo. Il libro raccoglie gli interventi di tutti i partecipanti al progetto e documenta la lunga ricerca culminata in questa proposta interpretativa. Secondo Christian Tufan, l’iscrizione è costruita su tre livelli linguistici sovrapposti. Il livello di senso compiuto, quello sottostante, è in greco bizantino e restituisce un testo di sorprendente coerenza: si tratta di un elogio funebre che termina con un’invocazione. Al suo interno compaiono riferimenti espliciti a Vlad, definito principe di Valacchi”, ma non identificato come Vlad Țepeș, l’impalatore, bensì come Vlad il Pio, “colui che è morto due volte”. La formula ha dunque un peso particolare: da un lato evoca la venerazione riservata a un martire, dall’altro allude a una duplice morte, suggerendo che le datazioni tradizionali, dicembre 1476 o gennaio 1477, debbano essere superate. È un fatto noto che le spoglie di Vlad III non siano mai state ritrovate. Le due tombe rumene di Snagov e Comana, entrambe a lui attribuite, non hanno restituito alcun reperto umano riconducibile al voivoda. Come ricorda la storica Carmen Bejanaru nel volume, la tomba di Snagov fu aperta nel 1933 e conteneva soltanto ossa di cavallo; lo stesso risultato si ebbe a Comana, monastero da lui stesso fondato. Oggi il nostro gruppo di ricerca è impegnato in ulteriori indagini, compresa una missione a Istanbul, dove contiamo di consultare documenti relativi alle campagne militari ottomane. Nessun archivio, finora, attesta l’esistenza del presunto scalpo di Vlad, che la tradizione vuole donato al sultano come trofeo di guerra. A rafforzare l’ipotesi di una sopravvivenza oltre il 1477, Mircea Cosma ha rinvenuto una lettera, pubblicata negli Annali romeni, in cui un cittadino di Krems, presso Vienna, riferisce di aver visto Vlad nel 1477, ancora alla guida di un esercito. L’iscrizione di Santa Maria La Nova, inoltre, indica una data di morte precisa: 20 novembre 1480. È una data importante, perché coincide con il periodo dell’assedio di Otranto, iniziato il 14 agosto di quello stesso anno e concluso con il massacro degli 800 martiri che si rifiutarono di abiurare la fede cristiana. Il 16 settembre 1480, papa Sisto IV e il re di Napoli invocarono una lega militare per respingere l’invasione turca. Ritengo che esistano connessioni dirette tra la campagna di Otranto e la presenza di Vlad III nel Regno di Napoli. Da qui è partito, nel 2014, il nostro studio sui rapporti tra Giacomo Alfonso Ferillo, figlio di Matteo, e la sua sposa Maria Balscia, sepolti ad Acerenza, dove la cripta è ornata da motivi di dragoni. Proprio quei draghi, simboli dell’Ordine del Dragone, rappresentano il filo che collega Vlad, la famiglia Ferillo e la chiesa di Santa Maria La Nova. L’iscrizione, interpretata oggi alla luce di queste connessioni, suggerisce che Vlad sia morto nel Regno di Napoli, in un contesto di battaglia, “ucciso due volte dai suoi nemici”, come recita il testo. A rafforzare l’ipotesi di una sepoltura a Santa Maria La Nova vi sono due ulteriori indizi artistici. Il primo riguarda la presenza, ai piedi dell’altare, di Giovanna III di Trastámara, luogotenente militare impegnata al fianco del marito e poi del figliastro, sepolta lì nel 1518. Il secondo indizio è di natura simbolica: nella stessa chiesa, infatti, riposa Hamida, figlio dell’ultimo sovrano di Tunisi, fatto prigioniero e poi convertitosi al cristianesimo sotto la guida spirituale di Giovanni d’Austria, il comandante della Lega Santa che sconfisse i Turchi a Lepanto nel 1571. Il grande soffitto ligneo della navata centrale, con le sue quarantasette tele di fine Cinquecento dedicate alla Vergine Assunta, fu proprio finanziato da questa famiglia islamica convertita. È rivelante che il ciclo pittorico omaggi il ruolo delle donne nella storia della salvezza e, al tempo stesso, la vittoria cristiana sull’Islam, simboleggiata da una mezzaluna capovolta nello stemma di Giovanni d’Austria. Come se Santa Maria La Nova avesse assunto, nei secoli, la funzione di un pantheon della cristianità militante, custode delle memorie di sovrani, condottieri e dinastie unite da un filo comune: la lotta contro l’espansione ottomana. In questa prospettiva, la presenza di Vlad III, cavaliere dell’Ordine del Dragone e principe impegnato nella difesa dell’Europa cristiana, trova un senso compiuto. La chiesa napoletana si presenta così come l’ultimo tassello di una narrazione che unisce Otranto e Lepanto, il 1480 e il 1571, in una lunga storia di fede, guerra e memoria.
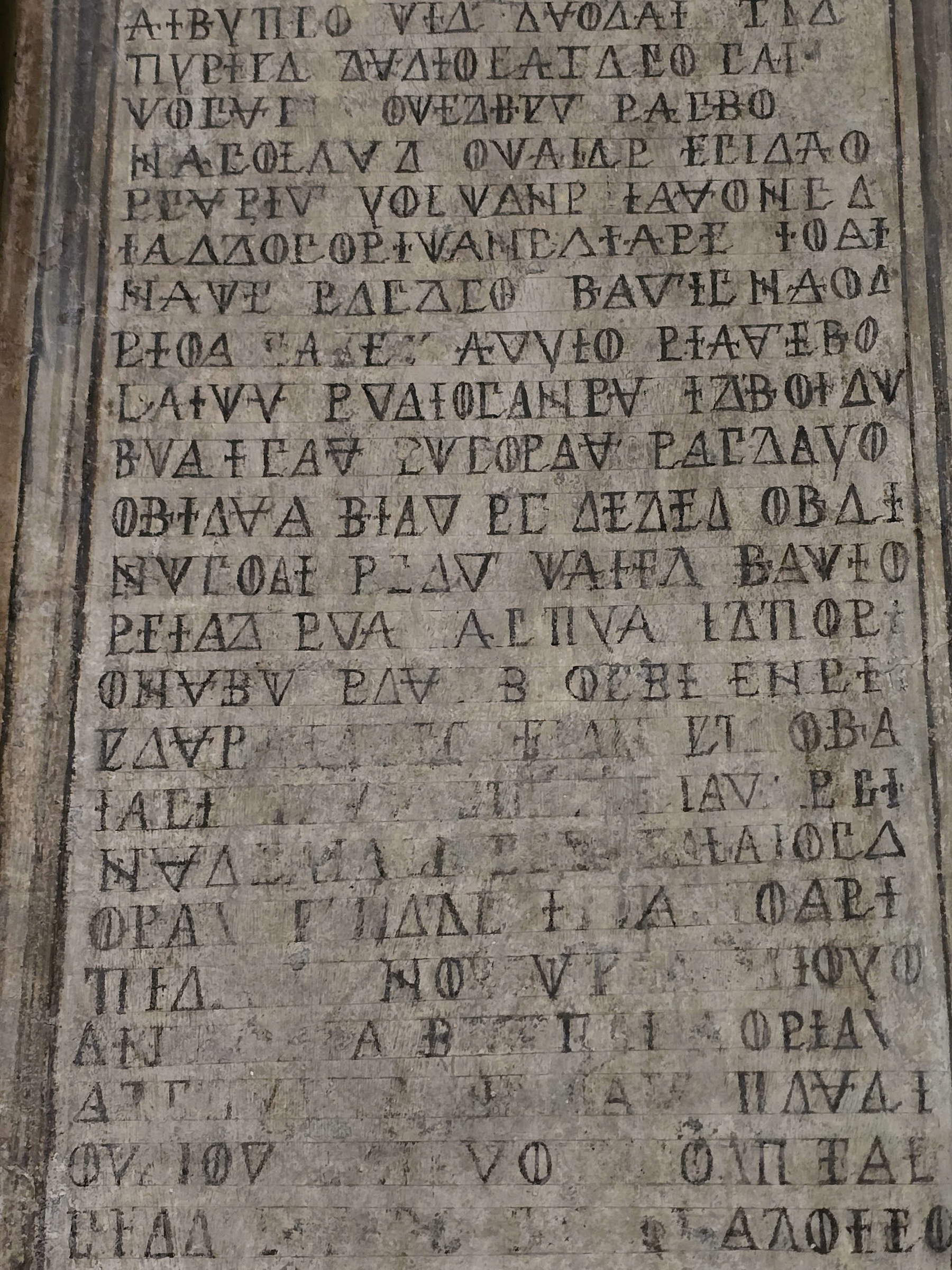

Un elemento trovo interessante è la datazione tra il 1480 e il 1490, legata alla figura di Maria Balsa, ritenuta figlia o nipote di Vlad. Quale importanza ha avuto la presenza femminile a Napoli nella ricostruzione del quadro storico?
Maria Balsa si configura come una figura che si muove su due livelli temporali. Il primo riguarda il suo legame con Giacomo Alfonso Ferillo, testimoniato dalla cripta di Acerenza. In questa dimensione l’arte assume una funzione conoscitiva e qui l’estetica diventa mezzo di comprensione. La cripta, con la sua simbologia di matrice draculiana, solleva interrogativi precisi: Maria era una nobildonna albanese secondo alcuni Balsic, oppure proveniva da un principato che oggi identificheremmo come rumeno? In tutto ciò, Maria Balsa fungeva da ponte tra la penisola balcanica, segnata dalle persecuzioni, e il Sud Italia, in particolare Acerenza e Napoli, dove giunge tramite il matrimonio con Giacomo Alfonso Ferillo. Le loro due figlie, Beatrice e Isabella, si inseriscono poi come ulteriori tasselli in questa ricostruzione storica, rendendola ancora più importante. Successivamente, la ricerca ha cercato di chiarire il suo ruolo attraverso una cronaca cinquecentesca, sebbene vi siano diverse interpretazioni alternative. Secondo una lettura, Maria sarebbe stata condotta a Napoli da Costantino Castriota Skanderbeg, futuro vescovo di Isernia, anch’egli sepolto a Santa Maria la Nova. Nel monumento funebre dedicato a lui da Andronica Comneno compare un’iscrizione enigmatica: “Maria”, senza alcun riferimento a Santa Maria. L’evidenza ha sollevato quindi delle perplessità. Come poteva un’orfana arrivata a Napoli sotto la tutela di Skanderbeg essere accolta alla corte dei Ferillo e poi sposare Giacomo Alfonso Ferillo? L’ipotesi iniziale considerava la possibilità che Maria avesse portato con sé le spoglie del padre, ma oggi l’interpretazione dell’iscrizione permette di comprendere autonomamente questi spostamenti, considerando le migrazioni indipendentemente dai luoghi di contatto. Pur restando evidente il legame con Santa Maria la Nova, dove si trovano le tombe dei Ferillo e di Costantino Castriota Skanderbeg, emergono affinità storiche che delineano un quadro interessante e complesso. Le ricerche attuali si concentrano sull’origine nobiliare di Maria Balsa: i colleghi storici rumeni stanno acquisendo documenti che approfondiscono sia la cripta di Acerenza sia i territori dell’attuale Romania, cercando di chiarire con precisione le origini di Maria Balsa.
Cosa vuol dire per Napoli poter esporre un documento epigrafico su Vlad l’Impalatore tanto esplicito quanto rilevante?
Napoli rimane capitale ancora oggi. È una capitale di snodi e di incroci, un crocevia dove realtà diverse si incontrano e si intrecciano. Il fatto stesso che un codice possa sopravvivere a se stesso, in un’epoca in cui grandi basiliche e cattedrali venivano abbattute per farne altre, dimostra la peculiarità della città. All’epoca non esisteva una scienza della conservazione come quella che abbiamo sviluppato in tempi più recenti. Un esempio rilevante è l’iscrizione in greco custodita a Napoli: benché codificata, resta un segno nativamente greco, testimone della capacità della città di mantenere insieme mondi e culture diverse, ibridandoli piuttosto che sopprimerli. La grammatica stessa di Napoli, stratificata come la sua storia, mostra questa attitudine: connettere piuttosto che escludere, raccordare piuttosto che colonizzare. La città ha esercitato la funzione anche come rifugio. La presenza di islamici ospitati nel quartiere ebraico e di nobili in fuga conferma questa capacità inclusiva. Napoli mostra, nelle sue contraddizioni e stratificazioni, non solo le tracce di una storia lunga e complessa, come avviene in molte capitali, ma anche una vocazione all’incontro e alla coesistenza. Santa Maria L’Aquila ne è un esempio concreto: conserva opere del Rinascimento napoletano accanto a capolavori del periodo barocco, incarnando perfettamente la stratificazione culturale e storica della città.
Santa Maria La Nova è un luogo che conserva opere del rinascimento e del periodo Barocco Napoletano. Che impatto turistico immagina avrà la nuova interpretazione della lastra, e che già ha avuto in questi mesi estivi?
Quando si affrontano temi come questi, è fondamentale distinguere l’attenzione culturale dall’offerta turistica. Il dibattito sul turismo ha significati specifici, e non credo che il Louvre debba scusarsi per il fatto che i visitatori vadano a vedere la Gioconda. È vero che opere molto conosciute possono oscurare altre creazioni, ma questo accade abitualmente. La differenza principale sta nel tempo e nell’approccio. Il turismo si misura spesso in quantità, in visite brevi e frettolose, mentre la cultura richiede attenzione, contemplazione e sedimentazione. Attraversando un grande museo capita di ricordare poco di ciò che si è visto: la capacità di fermarsi e approfondire è ciò che distingue l’esperienza culturale da quella turistica. Allo stesso tempo, i temi presentano un grande potenziale comunicativo. Prendiamo Vlad III di Valacchia ad esempio: molti visitatori di Santa Maria la Nova arrivano interessati al mito di Dracula. Analizzare il fascino immortale della figura significa interrogarsi sulla trasposizione del male: come simbolo, Dracula unisce crudeltà e fascino, e la sua fortuna narrativa, dai romanzi gotici fino a Twilight, mostra come il male possa essere rappresentato in forma laicizzata, permettendo di esplorare gli istinti più oscuri presenti in ciascuno di noi. L’interesse storico su Vlad III ha quindi una spiegazione, ma il suo impatto comunicativo va oltre. Anche se i visitatori giungono attratti dal mito, spesso ne escono con una comprensione più ampia, entrando nell’arte di fine Cinquecento e dell’evoluzione pittorica seicentesca a Napoli. Santa Maria la Nova ne è un esempio: inglobando la Torre Mastria e le antiche mura occidentali della città, custodisce storie e opere che vanno dal Rinascimento al Barocco napoletano. In questa cornice si inserisce anche la vicenda di Michelangelo Merisi. Durante i suoi soggiorni a Napoli, soggiornò alla locanda del Cerriglio, ai piedi della torre difensiva, e subì un attentato che quasi lo uccise. Nel contesto del soffitto di Santa Maria la Nova, completato nel 1609, e dei rapporti con Battistello Caracciolo, Caravaggio incontrò una città in cui l’innovazione realistica sposava visioni di fragilità umana e crudeltà, delineando la rivoluzione pittorica che Napoli contribuì a sviluppare. È quindi importante tenere insieme, senza confonderle, l’esperienza turistica e l’approfondimento culturale. Il turismo attraversa, distribuisce interesse, ma l’attenzione culturale si ferma, osserva e comprende.
A seguito della scoperta delle iscrizioni, sono già nati o si prevede possano nascere scambi culturali e collaborazioni con enti, musei o fondazioni della Romania al fine di rafforzare il legame storico tra Napoli e la terra d’origine di Vlad III?
Con la Romania esistono scambi di grande amicizia e collaborazione culturale. Non avevo approfondito i legami fino a quando ricevetti un invito da Mircea Cosma a tenere una conferenza in Romania. Sui temi mi sento molto sereno, perché le ipotesi ricostruttive che avanzo si basano in particolare sugli studi di due storici rumeni, tra cui Cristian Tufan. Il fatto che studiosi locali sostengano queste tesi con serietà e rigore è molto importante: per noi Vlad III è una figura storica da riscoprire tra le molte che caratterizzano l’Italia dei mille volti, mentre per la Romania rappresenta un personaggio nazionale di primo piano. Sono quindi profondamente grato e ammirato per la loro onestà intellettuale. Il percorso di ricerca che hanno intrapreso suscita discussione anche all’interno del loro stesso territorio e ha ricevuto ampia risonanza sui media e sulla televisione rumena. Vlad III, per loro fa parte di una riscoperta delle radici storiche e culturali che molti paesi dell’Europa dell’Est, liberatisi dall’esperienza del socialismo reale dopo la caduta del Muro di Berlino, stanno portando avanti come elemento centrale della propria identità nazionale. Che la Romania consideri e ponga in agenda indagini storiche di questo tipo rappresenta una forte capacità di riscrivere e reinterpretare la propria storia con rigore e consapevolezza.


Secondo lei come si può comunicare al grande pubblico la differenza tra la realtà artistica documentata e la leggenda gotica di Dracula, senza banalizzare la scoperta?
Non è una questione semplice. Questa estate, alla fine di giugno, mi trovavo ancora a Snagov e a Comana, quando ho chiesto ai miei colleghi di impegnarsi nella pubblicazione dello scritto. L’obiettivo era fornire strumenti di approfondimento, creando una piattaforma di riferimento e assumendoci la responsabilità delle nostre tesi. Il lavoro si è legato con altri contributi, come il testo di Susi Bladi e un documentario trasmesso su La7 (disponibile anche in modalità rewind). In queste produzioni, Bladi ci ha accompagnato nella ricerca della tomba di Vlad, integrando nelle ultime edizioni capitoli che riprendono e approfondiscono le nostre ipotesi. In sintesi, abbiamo realizzato due strumenti cartacei e un video, presentando un approfondimento storico-scientifico, una mediazione divulgativa e una prospettiva documentaria accessibile anche ai non specialisti. Una volta al mese organizziamo visite guidate gratuite a Santa Maria la Nova, durante le quali rispondo alle domande dei visitatori, dalle più comuni alle più articolate. Collaboro con le associazioni di guide turistiche per momenti di approfondimento, e spesso mi fermo a parlare con persone esperte o semplicemente curiose, dando dettagli che vanno oltre la semplice visita turistica. Siamo consapevoli del potenziale divulgativo del nostro approccio. Studiare e comunicare permette di capire meglio come proseguire nella ricerca storica e, allo stesso tempo, di offrire strumenti di comprensione al pubblico. A titolo di esempio, un video realizzato questa settimana da un noto tiktoker napoletano ha raggiunto quasi 600.000 visualizzazioni in poche ore, dimostrando un enorme potenziale di diffusione. Questo tipo di lavoro è un compito didattico delicato ma fondamentale. Attraverso esso si può costruire una vera scoperta della storia napoletana, unendo rigore storico e appeal comunicativo. Lo vivo come un’occasione per fare scuola, combinando ricerca e mediazione culturale.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia
Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.