Il collezionismo d’arte rappresenta da sempre la forza motrice silente e fondamentale che alimenta una parte consistente del sistema dell’arte. È attraverso le scelte dei collezionisti che il mercato prende forma, che gli artisti ricevono supporto vitale e che le istituzioni traggono ispirazione, contribuendo in modo spesso poco evidente alla costruzione della memoria visiva collettiva. Di fronte a un simile ruolo cardine, diventa cruciale comprendere cosa accade quando il testimone passa di mano, ovvero quando nuove generazioni entrano in campo portando con sé linguaggi, priorità e visioni del mondo radicalmente differenti.
Per tracciare una mappa di questa evoluzione, ArtVerona e il blog Collezione da Tiffany hanno collaborato in un’indagine specifica sul ricambio generazionale nel collezionismo italiano di arte contemporanea. L’obiettivo primario era decifrare come si modificano le prospettive, i valori fondamentali e le consuetudini di acquisto nel passaggio tra i collezionisti storici e i nuovi protagonisti della scena. I risultati delineano un settore che, pur mantenendo salde le sue radici, è in profonda trasformazione.
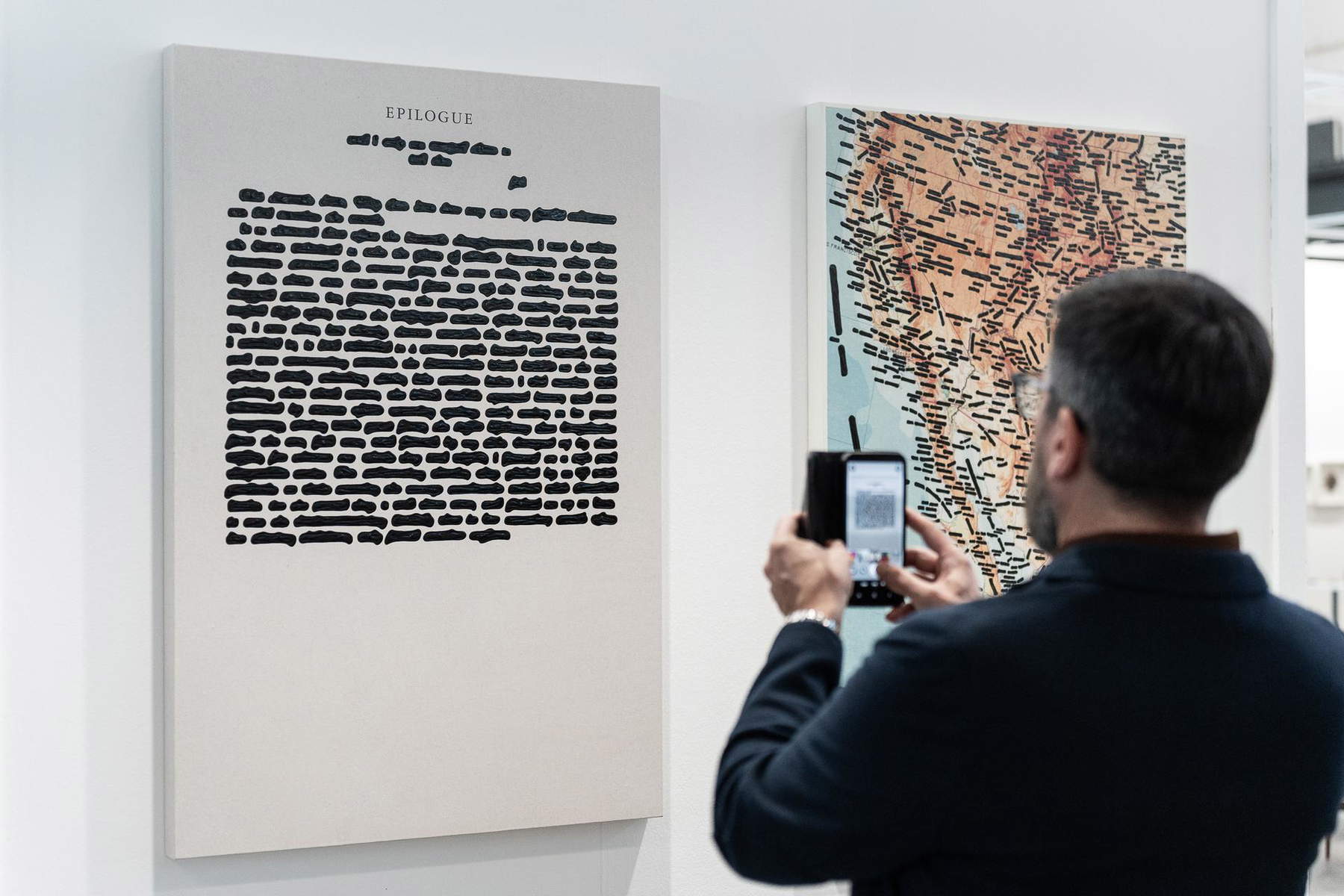
Dall’analisi emerge che il panorama attuale resta saldamente ancorato alle generazioni più mature: i Baby Boomer (nati tra il 1946 e il 1964) e la Generazione X (nati tra il 1964 e il 1979), sommate, costituiscono oltre l’85% degli intervistati. Nonostante la loro posizione ancora minoritaria, la Generazione Y (nati tra il 1980 e i1 1996, detti anche “Millennial”) e gli appartenenti alla Gen Z (nati tra il 1997 e il 2012) manifestano un interesse crescente verso il mondo del collezionismo. Queste nuove coorti introducono un approccio più dinamico, meno rigido e intrinsecamente globale, con una sensibilità notevolmente accentuata verso i temi di rilevanza sociale.
Un dato significativo sottolinea l’identità profondamente personale del collezionismo in Italia: l’86% dei partecipanti ha costruito la propria collezione in autonomia. Questo dato conferma che l’atto di collezionare non è primariamente guidato da fredde logiche di investimento, ma scaturisce piuttosto da un impulso individuale forte, spesso originato dal piacere della scoperta e da un coinvolgimento emotivo profondo. Come riferito da uno dei partecipanti all’indagine, l’inizio dell’attività collezionistica è spesso un “divertimento, un amore inaspettato” che, con il passare del tempo, si solidifica in passione e infine in una vera e propria collezione.
Nel contesto del trasferimento generazionale, la questione più sentita riguarda il futuro delle raccolte d’arte. L’indagine evidenzia una marcata tendenza alla trasmissione all’interno del nucleo familiare, con oltre il 60% dei collezionisti che dichiara di voler tramandare il proprio patrimonio artistico ai propri figli o congiunti. Circa un terzo degli intervistati, pur avendo raggiunto una certa maturità collezionistica, non ha ancora definito una strategia chiara per la gestione futura del proprio lascito.
Risulta minoritaria, rappresentando meno del 10% del campione, la prospettiva di una donazione a musei o istituzioni pubbliche. Questa statistica non è meramente logistica, ma riflette una realtà culturale più profonda e peculiare del contesto italiano: la trasmissione delle opere è un tema che viene raramente affrontato in modo strutturato e pianificato. La collezione è vista prevalentemente come un’estensione diretta e intima dell’identità personale del suo creatore, piuttosto che come un’eredità culturale destinata a essere condivisa con la comunità.
Per quanto concerne le preferenze artistiche, il collezionismo italiano si conferma tradizionale nella scelta dei linguaggi prediletti. La pittura e la scultura mantengono un dominio quasi assoluto, scelte da ben il 96% dei partecipanti. Seguono, con un distacco significativo, la fotografia (indicata dal 53% dei rispondenti), le installazioni e la performance (24%). I linguaggi più recenti, come il video e i new media, si attestano all’11%.
L’arte digitale e gli NFT (Non-Fungible Tokens), benché abbiano suscitato vasti dibattiti internazionali, non hanno ancora conquistato uno spazio centrale nel panorama collezionistico italiano, raccogliendo l’interesse di solo il 3% degli intervistati.
È interessante notare come la percezione del futuro del gusto diverga nettamente dalle abitudini di acquisto attuali. Oltre la metà dei collezionisti (51%) nutre la convinzione che le nuove leve del collezionismo saranno maggiormente orientate verso video, nuovi media e l’arte digitale. Solo un quarto (25%) ritiene che la pittura e la scultura conserveranno il loro ruolo di protagoniste indiscusso.
Tuttavia, i dati concreti raccolti direttamente tra Millennial e Gen Z sembrano ridimensionare questo preconcetto. Anche i collezionisti più giovani continuano a indicare la pittura, la scultura e la fotografia tra i linguaggi principali che li attraggono. A questi, tuttavia, affiancano un interesse crescente e più marcato per il video e i nuovi media. Questa preferenza non configura una sostituzione della tradizione artistica, ma piuttosto una sua innovazione e integrazione, proiettandola verso un orizzonte interpretativo più contemporaneo e decisamente più inclusivo.
Il confronto tra le diverse generazioni di collezionisti fornisce uno spaccato lampante di come il collezionismo stia evolvendo da pratica omogenea a specchio fedele delle trasformazioni culturali in atto nella società. Per la fascia dei collezionisti più maturi (Baby Boomer e Generazione X), i pilastri fondamentali che guidano le scelte rimangono l’innovazione e la ricerca artistica (valutate cruciali dal 64% di essi), seguite a ruota dal riconoscimento culturale dell’opera (52%) e, infine, dall’aspetto di investimento economico (38%).
Le generazioni più giovani (Millennial e Gen Z) hanno invece ridefinito la scala delle priorità, posizionando al centro valori che riflettono una nuova consapevolezza etica e ambientale. Essi privilegiano nettamente la sostenibilità e l’impatto sociale dell’opera o dell’artista (42%), seguiti dall’investimento consapevole (44%) e, leggermente distanziata, dall’innovazione (41%).
Questa significativa inversione di prospettiva segnala l’inizio di un vero e proprio cambio d’epoca nel mondo dell’arte. Per le nuove generazioni, collezionare non si limita al mero acquisto di un oggetto artistico. Diventa, piuttosto, un atto consapevole di “presa di posizione”, un modo per sostenere attivamente determinate visioni del mondo e per identificarsi in un sistema etico e culturale di valori condivisi.
Guardando alle proiezioni future, i collezionisti mostrano prospettive diversificate, ma tutte orientate verso una trasformazione dinamica del settore. Oltre quattro collezionisti su dieci (il 42%) prevedono un futuro caratterizzato da una maggiore digitalizzazione e da una spiccata globalità. Un’altra parte consistente (31%) immagina un sistema dell’arte che sarà sempre più orientato alla logica dell’investimento e della speculazione finanziaria. Infine, il 23% ritiene che l’attenzione si sposterà primariamente sul valore culturale e sociale che l’arte è in grado di generare.
Nonostante queste differenze nelle previsioni, l’indagine rivela una consapevolezza ampiamente condivisa: l’attività di collezionare continuerà a essere definita da un delicato equilibrio fra il godimento personale dell’opera, la responsabilità culturale che ne deriva e l’attenzione alle dinamiche del mercato.
L’indagine, realizzata congiuntamente da Collezione da Tiffany e ArtVerona, non intende semplicemente scattare una fotografia del mutamento in corso, ma si pone l’obiettivo più ambizioso di stimolare un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni di attori. Comprendere la direzione in cui evolve il collezionismo è essenziale, poiché significa comprendere, per estensione, la direzione che sta prendendo l’intero ecosistema dell’arte.
In questo scenario complesso, la vera sfida, come osservato da uno dei partecipanti, non ricade unicamente sulle spalle del collezionista. La responsabilità maggiore spetterà all’artista, il quale dovrà trovare il modo di salvaguardare e mantenere la propria autenticità creativa all’interno di un sistema che si preannuncia sempre più competitivo, interconnesso e globale.
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.