Dal 25 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026, le sale affrescate dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia ospitano Margaret Bourke-White. L’opera 1930-1960, una retrospettiva dedicata a Margaret Bourke-White (New York, 1904 – Stamford, 1971), una delle figure più rilevanti della fotografia del Novecento. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e curata da Monica Poggi. Il percorso espositivo presenta 150 immagini che attraversano tre decenni di attività dell’autrice, tra reportage industriali, scenari di guerra, trasformazioni sociali e conflitti geopolitici. Nata a New York nel 1904 e scomparsa nel 1971, Bourke-White ha saputo costruire una carriera internazionale distinguendosi per la capacità di affrontare contesti estremi, sia per difficoltà logistiche che per implicazioni politiche, affermandosi come testimone diretta degli eventi che hanno segnato il secolo. La mostra si articola in sei sezioni, seguendo un criterio cronologico e tematico.
“Negli anni in cui ad ossessionarmi era stata la bellezza delle architetture industriali, nelle mie foto le persone erano state presenze puramente casuali. [...] Ora invece, mi interessano solo le persone”, diceva Bourke-White raccontando dei reportage realizzati sulla vita americana negli anni successivi al collasso economico. “Vidi e fotografai pile di corpi nudi senza vita, i pezzi di pelle tatuata usata per i paralumi, gli scheletri umani nella fornace, gli scheletri viventi che di lì a poco sarebbero morti per aver atteso troppo a lungo la liberazione. In quei giorni la macchina fotografica era quasi un sollievo, inseriva una sottile barriera tra me e l’orrore che avevo di fronte”.

Il primo nucleo, intitolato I primi servizi di ‘Life’, ripercorre la collaborazione della fotografa con la rivista americanaLife, avviata nel 1936. Per il numero inaugurale, la redazione scelse come copertina una sua immagine della diga di Fort Peck, nel Montana. Fu l’inizio di una lunga collaborazione che l’avrebbe portata a raccontare grandi opere pubbliche, processi industriali e paesaggi urbani in trasformazione. Il periodo è approfondito nella sezione L’incanto delle fabbriche e dei grattacieli, dove emergono gli interessi modernisti dell’autrice e l’attrazione per le geometrie monumentali dei grandi complessi produttivi.
Un altro momento centrale è rappresentato da Ritrarre l’utopia in Russia, in cui vengono esposte le fotografie realizzate in Unione Sovietica: Bourke-White fu la prima fotografa americana ammessa nel Paese. Il suo lavoro in URSS coincide con una fase storica cruciale, segnata dalle ambizioni propagandistiche del regime e dall’interesse occidentale per i modelli economici alternativi. Le sue immagini cercano di restituire la portata di una trasformazione industriale e sociale ancora in corso, mantenendo uno sguardo sospeso tra documentazione e retorica visiva.

La sezione Cielo e fango, le fotografie della guerra raccoglie i reportage realizzati durante la Seconda Guerra Mondiale, sui fronti africani, europei e sovietici. Le immagini restituiscono la durezza del conflitto, ma anche la dimensione quotidiana della vita al fronte, ponendo particolare attenzione ai volti, ai corpi e agli spazi della resistenza civile. In questi contesti, l’autrice non rinuncia a un approccio tecnico esigente, continuando a utilizzare apparecchi medio e grande formato, nonostante le difficoltà ambientali. La scelta le consente di ottenere una nitidezza e una composizione che conferiscono monumentalità ai soggetti.
Il racconto prosegue con Il mondo senza confini: i reportage in India, Pakistan e Corea, che documenta le missioni svolte tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta. In India, la fotografa ritrae anche Mahatma Gandhi, testimoniando il processo di decolonizzazione e i primi conflitti legati alla nascita dei nuovi Stati-nazione. Anche in questi reportage, Bourke-White predilige la posa alla presa diretta, distinguendosi da altri fotoreporter coevi come Robert Capa o Henri Cartier-Bresson. La sua scelta stilistica mira a restituire dignità ai soggetti, spesso appartenenti a classi sociali emarginate, trasformati in emblemi universali delle sofferenze e delle trasformazioni in atto.
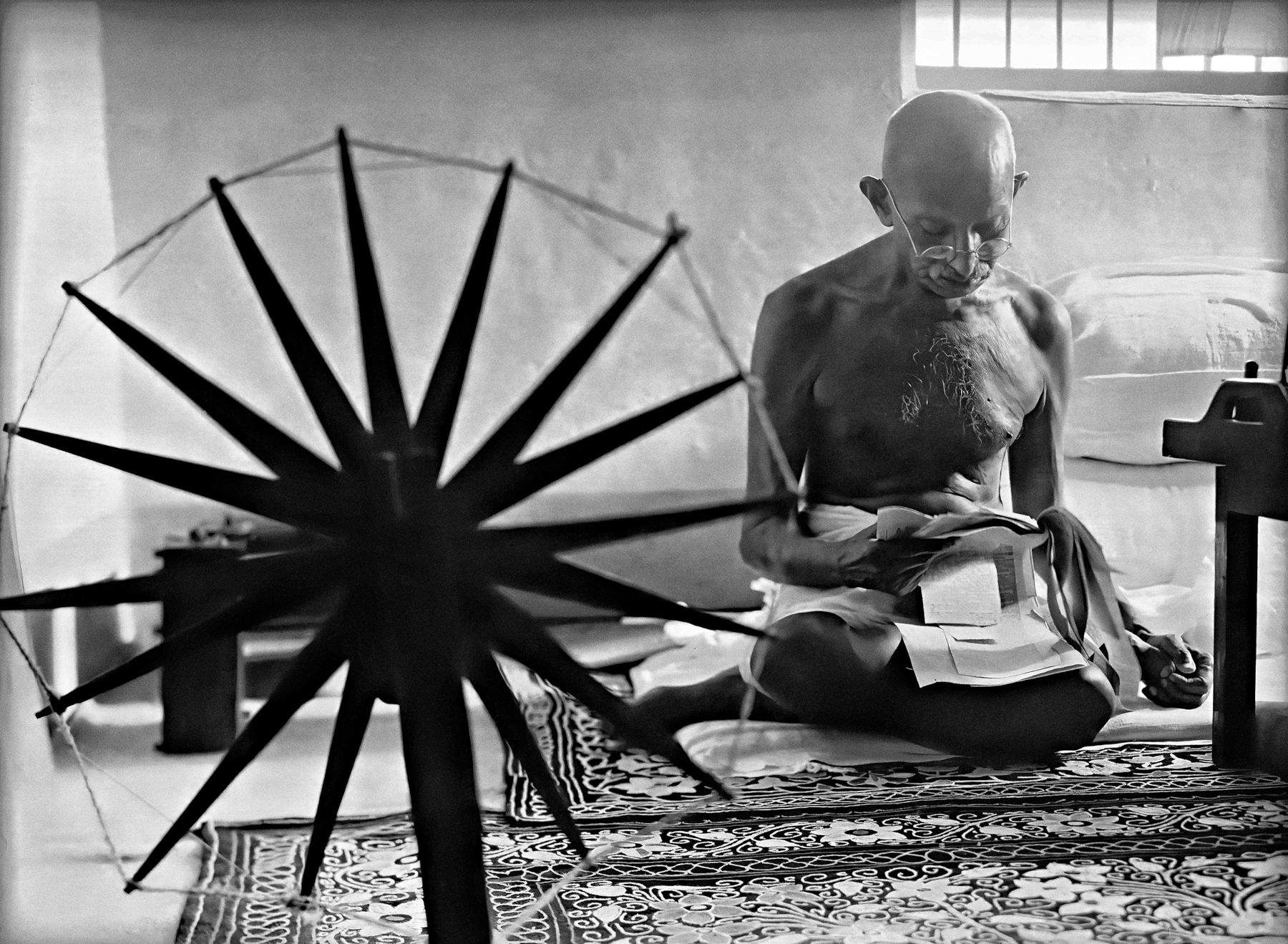
Margaret Bourke-White, Soldato americano chiacchiera con una ragazza tedesca che prende il sole nella Berlino del dopoguerra. Germania (1945; Margaret Bourke-White/The LIFE Picture Collection/Shutterstock)
L’ultima sezione, Oro, diamanti e Coca-Cola, affronta un tema ricorrente nel lavoro della fotografa: le disuguaglianze sociali. Il titolo allude alla coesistenza di ricchezze ostentate e condizioni di vita precarie che Bourke-White documenta durante i suoi viaggi in Africa e negli Stati Uniti. Le fotografie, realizzate in contesti urbani e rurali, evidenziano contrasti economici sempre più accentuati e pongono interrogativi ancora attuali sulle dinamiche della globalizzazione e sulla diffusione dei modelli consumistici. Oltre all’analisi del suo percorso professionale, la mostra dedica attenzione anche alla personalità della fotografa. Bourke-White emerge come figura anticonvenzionale e determinata, capace di superare le barriere di genere in un ambiente prevalentemente maschile. Negli anni Trenta raggiunge una fama tale da essere considerata tra le donne più influenti degli Stati Uniti. Tra gli aneddoti inclusi nell’esposizione, si ricorda la presenza di due alligatori nel suo studio al Chrysler Building, simbolo di un’esistenza fuori dagli schemi.
La sua carriera si sviluppa lungo due direttrici: dapprima come interprete delle politiche del New Deal, veicolate attraverso un linguaggio visivo vicino alla propaganda e alle istanze sociali; poi come fotoreporter orientata verso un realismo più asciutto, volto a raccontare individui e comunità coinvolti in crisi storiche. In entrambi i casi, la sua ricerca si distingue per la coerenza stilistica e per una continua attenzione ai dispositivi narrativi della fotografia. Un episodio del 1955 offre una chiave di lettura singolare della sua visione: colpita dal morbo di Parkinson, malattia che l’avrebbe accompagnata fino alla morte, scrisse al suo editore Henry Luce chiedendo di essere inviata sul primo volo spaziale con destinazione lunare. “Certo dovrei risolvere il problema del mezzo di trasporto”, osservava ironicamente nella lettera. “Forse tra qualche anno troverò la soluzione. Forse saltare la corda non significa che io sia in grado di andare sulla luna, ma la scienza corre così veloce, chissà”.

Nel corso della mostra, la Fondazione Palazzo Magnani propone un ciclo di incontri pubblici dedicati al cosiddetto “Secolo americano”, espressione che racchiude gli assetti storici, culturali, ideologici, economici e sociali che hanno caratterizzato il Novecento e che ancora oggi influiscono sulla contemporaneità. L’iniziativa intende approfondire il contesto in cui si è formata e affermata la figura di Bourke-White, offrendo strumenti per interpretare la sua opera alla luce delle trasformazioni del presente.
| Titolo mostra | Margaret Bourke-White. L’opera 1930-1960 | Città | Reggio Emilia | Sede | Chiostri di San Pietro | Date | Dal 25/10/2025 al 08/02/2026 | Artisti | Margaret Bourke-White | Curatori | Monica Poggi | Temi | Fotografia, Mostra fotografica |
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.