Semplice, impersonale, silenzioso, persino ovvio. Eppure dietro al titolo Senza titolo di moltissime opere d’arte – la maggior parte, essendo la titolazione un’invenzione abbastanza recente – sventola il vessillo di una ricerca che si è voluta orgogliosamente liberare dal dominio della parola, dal giogo della letteratura. Con schiere di pittori che hanno rinunciato a intitolare i loro singoli lavori in nome dell’arte per l’arte. E in ragione del desiderio di offrire al pubblico un’opera aperta alle possibili, altrui interpretazioni. In questi anni presenti di pianificazione programmata del prodotto artistico, di dominio del contenuto (meglio se impegnato) sulla forma, di affiancamento (quando non sovrapposizione) di esperti di marketing e della comunicazione alla figura dell’artista, spinto e/o costretto a brandizzare il proprio lavoro ai fini dell’identificazione merceologica del medesimo, può suonare come una stonatura la pratica asettica e ascetica di quanti – e sono stati tanti – nel Novecento hanno intitolato con un non titolo quanto usciva dall’atelier. A questa battaglia dell’immagine contro la parola che la sintetizza e ingabbia, è che ha visto impegnati pittori come Mirò e Picasso, ma soprattutto i protagonisti della cosiddetta Scuola di New York, quindi gli autori della epopea dell’Arte Povera (1967-1971), è dedicato il libro di Chiara Ianeselli Sulla necessità del Senza titolo. Il silenzio come linguaggio dell’arte (Postmedia, 2025, 133 pagine, 16 euro).
La giovane storica dell’arte e curatrice trentina, attualmente impegnata con un incarico al Maxxi di Roma, ha dato alle stampe il succo, e il meglio, della sua tesi di dottorato (di cui mantiene anche impostazione didattica e scaletta) dedicata ai titoli nelle opere d’arte. Diciamo subito che il suo libro spicca per la vasta bibliografia, ricca soprattutto di citazioni dalla saggistica statunitense, alla quale ha aggiunto testimonianze inedite raccolte dialogando con i superstiti di quella stagione, per molti versi, volutamente “afona” (interviste ai poveristi Anselmo, Paolini, Piacentino, Penone), soppiantata negli anni Ottanta del ritorno alla pittura (Transavanguardia, Pittura colta, anacronisti) dal revival della citazione dotta e letteraria nei titoli.
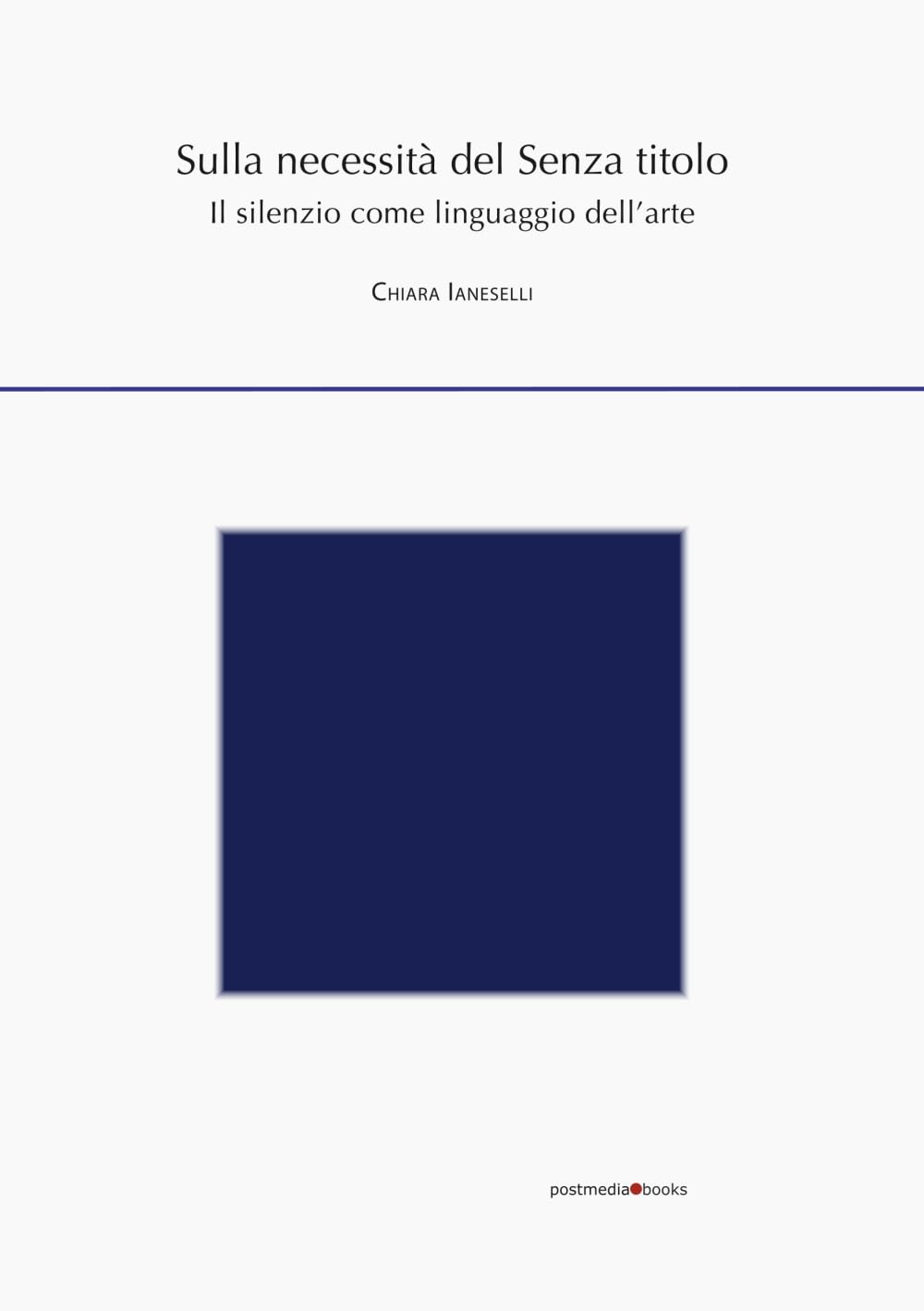
Eppure per secoli, l’opera d’arte ha fatto a meno del titolo. Era il soggetto, che si trattasse di un dipinto realizzato per una committenza religiosa o profana, a definire il singolo pezzo. E alla genericità o universalità del tema (Madonna con il Bambino e santi) si sopperiva, ai fini della identificazione, con una descrizione minuziosa. Basti riandare al Libro dei Conti di Lorenzo Lotto che, alla data 10 febbraio 1545, annotava l’incasso di 16 ducati come pagamento ricevuto per l’intensa Vesperbild, oggi alla Pinacoteca di Brera, che il pittore veneziano definiva esattamente (ma non sinteticamente) “pictura de una paleta […] fatta per una pietà, la Vergine tramortita in brazo de San Joanne et Jesu Cristo morto nel gremio de la matre, et due anzeleti da capo e piedi sustentar el nostro signore…”. Certo, invece il popolato e mitico dipinto del Perugino oggi al Louvre ha un suo titolo, Combattimento tra Amore e Castità, questo grazie al fatto che Isabelle d’Este, nel contratto del 1503 con il pittore per l’opera da collocare nel suo Studiolo mantovano, chiede, ossia fa chiedere a Vannucci, “una batagla (sic.) di Castità contro di Lascivia, cioè Pallade e Diana combattere virilmente contro Venere e Amore”. Ma pochi anni dopo Giorgione metteva mano, prima di morire nel 1510, al suo quadro probabilmente più famoso senza lasciare né firma né titolo: La tempesta, come Marcantonio Michiel definì molti anni dopo, nel 1530, il “paesetto” di “Zorzi de Castelfranco” visto in casa di Gabriele Vendramin, e come oggi l’ammiriamo alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
La nascita del collezionismo e la relativa necessità di redigere gli inventari delle raccolte hanno, soprattutto nei secoli XIX e XX, sotto la spinta dei mercanti interessati ad avere prodotti facilmente identificali e commerciabili, fatto fiorire titoli e letteratura intorno al discorso per (sole) immagini dei pittori. I titoli sono diventati così, sotto la spinta del Simbolismo e poi del Surrealismo, ma anche del Futurismo, ossia i movimenti con maggiore implicazione letteraria, “un vero e proprio nome che l’opera si porta con sé – annota in apertura Ianeselli – e che determina spesso l’identità e la comprensione di ciò che è rappresentato. Spesso addirittura iscritti, incisi a volte dall’artista stesso o inseriti nelle didascalie, i titoli accompagnano l’opera come veri e propri certificati di battesimo”. Come altro chiamare se non L’enigme dell’heure il quadro di De Chirico nella collezione Mattioli (Museo del Novecento) di Milano, visto che il pictor optimus l’ha intitolato così lasciandolo impresso sul telaio del suo capolavoro metafisico?




Eppure già nell’Ottocento c’era chi si ribellava al dominio della parola, alla epitome univoca. Ianeselli, in una lunga nota a pagina 36, riporta il fastidio manifestato da James Wistler davanti al fatto che al suo musicale Arrangement in Gray an Black, spedito nel 1872 all’Accademia, gli estensori del catalogo avessero ampliato il titolo originale dell’artista con l’aggiunta: Portrait of the Mother of the Painter. “Ma cosa può o deve importare al pubblico l’identità del ritratto?” si chiedeva in proposito il grande pittore inglese, che aggiungeva: “Come la musica è la poesia del suono, così la pittura è la poesia della vista, e il soggetto non ha nulla a che fare con l’armonia del suono e del colore”. A premere per un nome che rendesse l’opera unica e facilmente identificabile e commerciabile erano e sono, però, i galleristi e i mercanti. Ad esempio, nel caso di Picasso, i mitici Kahnweiler e Vollard, con la conseguente, ma tarda, ribellione del malagueño che nel 1946 dichiarò di non intitolare le sue opere, prendendosela “con la mania dei mercanti d’arte” e “dei critici”, ma anche “dei collezionisti, di battezzare i quadri”.
Ricco di citazioni dei protagonisti, e godibile anche da un pubblico di non addetti ai lavori, il libro di Ianeselli si concentra, nell’articolare e argomentare il discorso Sulla necessità del Senza titolo, sull’Espressionismo astratto e sul Minimalismo made in Usa, quindi sull’Arte povera italiana. Il più drastico e furioso nel difendere i propri quadri che “rimangono senza nome, come dovrebbero”, poiché “non riguardano la vita” ma “conducono una propria vita”, appare, tra gli espressionisti astratti americani, Clyfford Still. Vistosi appioppare da Peggy Guggenheim titoli come Sole sepolto e La Commedia della Deformazione Tragica ai quadri esposti e in vendita nel 1946 alla galleria Art of This Century, Still dal 1959 rimosse tutti i titoli non suoi dai vecchi lavori e smise di intitolare i nuovi, se non attraverso un sistema di lettere e numeri per renderli riconoscibili. Il numero era, del resto, il sistema adoperato, tra gli altri, da William Baziotes, Jackson Polloick e Mark Rothko che, a partire dal 1948, iniziò a intitolare i suoi quadri Senza titolo (quasi 150 le sue opere con questa definizione, annotava sconsolato il figlio Christopher alle prese con l’archivio del padre) per aggiungere nel decennio successivo, a partire dal 1955, i colori presenti nel quadro.
L’Arte per l’arte di un Ad Reinhardt contro l’arte come merce, ha portato con sé la scelta integralista del Minimalismo americano. Con Donald Judd, critico prima ancora che scultore (una qualifica però ostinatamente da lui rifutata), che, fautore di una produzione scollegata da qualsiasi riferimento al mondo reale, nelle Lamentele: Part I dichiarò: “Preferisco l’arte che non è associata a nulla”, arrivando a rinominare ironicamente i suoi Senza titolo con definizioni semplici come The Bleaches: più che titoli, dei soprannomi. E sulla stessa scia Robert Ryman che dichiarava: “Non astraggo da nulla […] non lavoro su una base rappresentativa […] Nessun simbolismo. No illusionism”, fino a divertirsi a chiamare i suoi quadri con le marche dei colori impiegati. “Quando la mostra di Ryman – nota Ianeselli – venne intitolata No Title Required, il disprezzo per i titoli raggiunse un punto critico”.



Il senza titolo con cui Francesco Stocchi (non) ha intitolato la sezione da lui curata, ma dagli artisti interpretata, alla 18esima Quadriennale d’arte nazionale di Roma attualmente in corso al Palazzo delle Esposizioni, ha insomma una lunga storia alle spalle. Che passa anche per l’esperienza dell’Arte Povera di Germano Celant e di artisti come Giovanni Anselmo e Jannis Kounellis che hanno sistematicamente usato il Senza titolo – in corsivo, perché dato dall’autore e da distinguere dalla stessa definizione impiegata da curatori ed estensori davanti ad opere senza nome – mentre Alighero Boetti si affidava, tra l’altro, alla tautologia elencando i materiali (Pietre e lastre di metallo, 1968). Laddove però un poverista doc come Giuseppe Penone ha invece titolato le sue sculture: “Ho continuato a usare il titolo per orientare la lettura dell’opera”, ha detto l’artista nel 2020 a Chiara Ianeselli, “e per chiarire che l’opera non è solo una ricerca formale ma c’è un pensiero, un’idea che viene identificata attraverso il titolo, come ad esempio Respirare l’ombra”. Nel 1969 in Arte povera, Germano Celant, teorico e anima di questa tendenza dell’arte italiana, era stato invece chiaro sulla poetica dell’artista dell’Arte povera, il poverista ideale: “Le sue opere sono spesso senza titolo, quasi a voler stabilire un certificato fisico-mnemonico dell’esperimento, e non un’analisi o lo sviluppo successivo di un’esperienza”. Del resto, i paladini della neovanguardia di Celant non sempre hanno condiviso, vedi Pistoletto, il marchio di fabbrica. E così le cose nude e crude della terra e dell’industria hanno comunque trovato un nome evocativo che le rendesse misteriose, mitiche, memorabili.
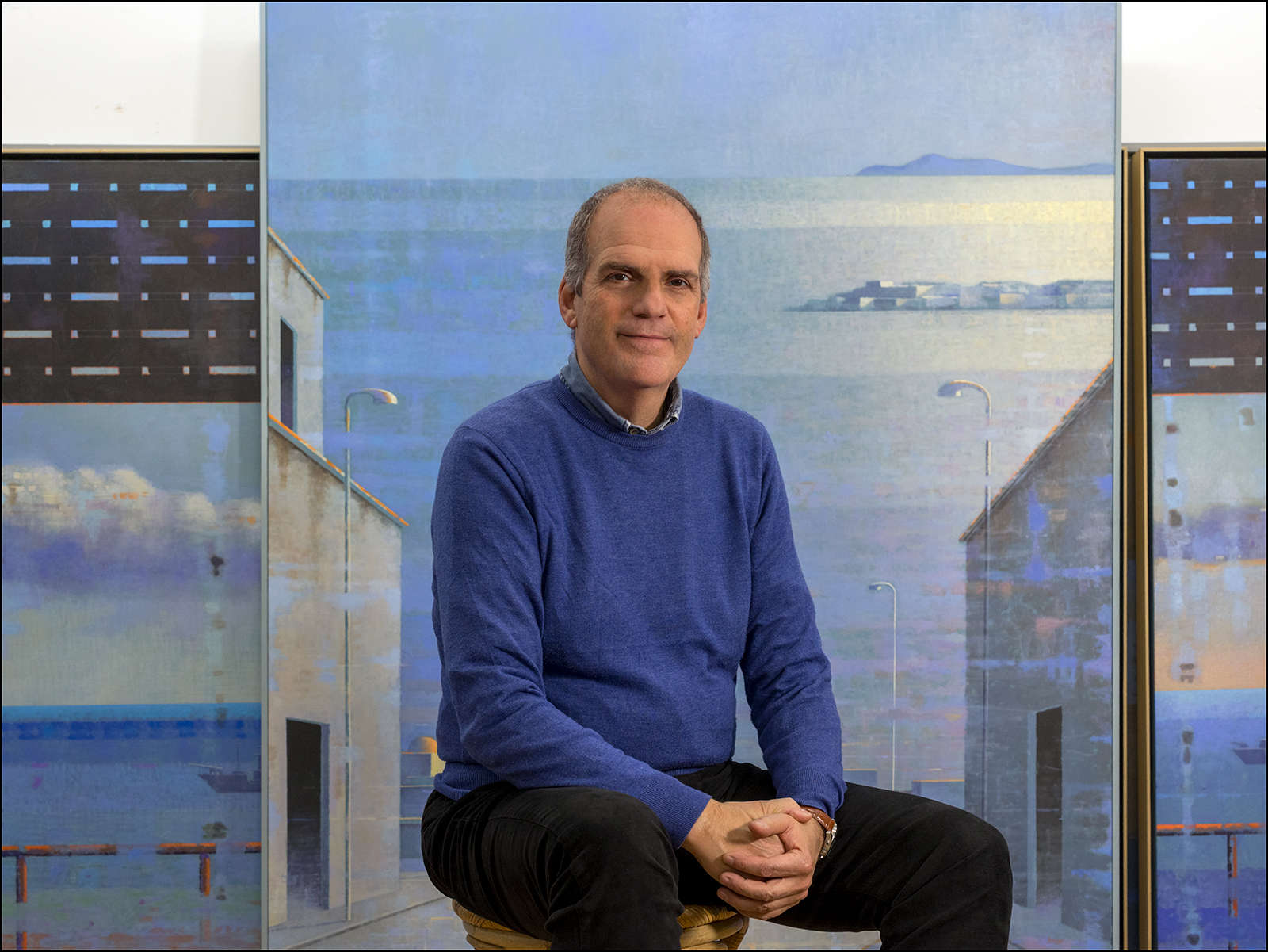
L'autore di questo articolo: Carlo Alberto Bucci
Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.