È forse uno dei sentimenti più antichi che esistano: l’invidia s’insidia nelle menti di chi desidera ma non possiede, che si tratti di qualità personali, successi, relazioni o beni materiali, e nasce dalla consapevolezza della propria mancanza o inferiorità. Un sentimento complesso che s’annida nell’interiorità più profonda di un individuo, con maggiore o minore intensità a seconda della sua indole, e che combina desiderio, frustrazione e anche risentimento verso chi appare più fortunato o realizzato, includendo anche il disagio o il fastidio provocato da quella differenza. Dante nella sua Commedia confina gli invidiosi nel secondo cerchio del Purgatorio: seduti con le spalle appoggiate contro la parete del monte, si reggono a vicenda, ascoltano voci che invitano alla carità, sono vestiti di cilicio del colore della pietra, e hanno gli occhi cuciti con fil di ferro per impedire loro, per contrappasso, di vedere, poiché da vivi hanno guardato gli altri con malevolenza a causa della presunta felicità altrui.
Si dice che l’invidia sia una brutta bestia, e in effetti anche l’arte, nei secoli, non l’ha raffigurata con un bell’aspetto. Nella sua Iconologia, pubblicata in prima edizione nel 1593, Cesare Ripa la descrive come una donna vecchia, magra, brutta e pallida, con gli occhi biechi, vestita del colore della ruggine e scapigliata; fra i capelli ha alcune serpi, a significare i “mali pensieri, essendo ella sempre in continua rivolutione de’ danni altrui e apparecchiata sempre a spargere il veleno negli animi di coloro con i quali senza mai quietare si riposa, divorandosi il cuore da se medesima”. E si dipinge vecchia perché “per dir poco, ha avuta lunga e antica inimicitia con la virtù”. Mentre è mal vestita perché questo vizio “ha luogo fra gli uomini bassi e con la plebe”. “Un veleno è l’Invidia”, si legge ancora nell’Iconologia di Ripa, “che divora le midolle, e il sangue tutto sugge, onde l’invido n’ha debita pena, perché mentre l’altrui sorte l’accora, sospira, freme e come leon rugge, mostrando ch’ha la misera alma piena d’odio crudel che’l mena a veder l’altrui ben con occhio torto; però dentro si fa ghiaccio, e furore, bagnasi di sudore, ch’altrui può far del suo dolor accorto, e con la lingua di veleno armata morde e biasima sempre ciò che guata”.
All’inizio del Trecento, Giotto (Colle di Vespignano, Vicchio, 1267 – Firenze, 1337) la raffigurò in un affresco della Cappella degli Scrovegni a Padova, nello zoccolo della parete sinistra, dedicata appunto ai Vizi, in contrapposizione alla parete destra dedicata alle Virtù. Dipinta a monocromo in un riquadro e sovrastata dal suo nome, l’invidia è rappresentata in modo diverso rispetto all’iconografia che sarebbe stata codificata da Ripa, o meglio, come una vecchia che non ha serpi tra i capelli, ma un serpente le esce dalla bocca che le si ritorce contro, a simboleggiare il male che ritorna su chi lo genera. Ha orecchie grandi e sproporzionate per carpire meglio le parole e le informazioni altrui, che la alimentano; dalla testa le spuntano delle corna ritorte ed è cieca. I piedi sono avvolti da alte fiamme che la bruciano come il desiderio di possedere le cose degli altri: è un sentimento infatti che brucia innanzitutto chi lo prova e che mai lo appaga. E anche la mano protesa in avanti come per rubare qualcosa rafforza il concetto di quel desiderio. Nell’altra mano invece stringe un sacchetto con i propri averi. La rappresentazione che ne fa Giotto è dunque di condanna morale e allo stesso tempo un monito che trova nel serpente e nel fuoco due simboli del male che la colpiscono in prima persona, essendo lei la prima vittima del suo vizio.

Sempre nell’Iconologia di Cesare Ripa si apprende che l’invidia viene raffigurata anche a seno nudo cadente: sarà allora una “donna vecchia, magra, brutta, di color livido, avrà la mammella sinistra nuda, e morsicata da una serpe, la qual sia ravvolta in molti giri sopra della detta mammella, et a canto vi sarà un’hidra, sopra della quale terrà appoggiata la mano. Invidia non è altro che allegrarsi del male altrui e attristarsi del bene con un tormento che strugge, e divora l’huomo in se stesso [...] La serpe che morsica la sinistra mammella nota il ramarico c’ha sempre al cuore l’invidioso del bene altrui, come disse Horatio nell’Epistole ”invidus alterius macrescit rebus opimis". L’invidioso si strugge per le ricchezze altrui, in altre parole.
È nuda e avvolta dalle serpi l’invidia rappresentata a terra al centro della Porta Virtutis di Federico Zuccari (Sant’Angelo in Vado, 1539 – Ancona, 1609), parte della collezione permanente della Galleria Nazionale delle Marche nel Palazzo Ducale di Urbino. L’opera del 1581 venne realizzata dall’artista in seguito a un torto subito, ovvero il rifiuto da parte del committente Paolo Ghiselli, scalco di papa Gregorio XIII, di un’opera per la cappella di famiglia nella chiesa di Santa Maria del Baraccano a Bologna sul tema della processione di Gregorio Magno, che non piacque né a lui né agli artisti bolognesi. Ghiselli si rivolse quindi a un altro artista, Cesare Aretusi. A questo punto, per rifarsi dell’umiliazione subita, Zuccari realizzò insieme al Passignano un enorme cartone, la Porta Virtutis, che venne esposto proprio nel giorno di san Luca (patrono dei pittori) sulla facciata della chiesa della corporazione dei pittori. E in quell’occasione Zuccari spiegò davanti a tutti l’opera. A Urbino è conservata una versione dipinta in scala ridotta del cartone originale, che l’artista donò al duca Francesco Maria II Della Rovere: si tratta di una grande allegoria della Virtù che trionfa sul Vizio. Minerva, al centro del grande arco che simboleggia la porta della virtù, non lascia passare le creature mostruose che si avvicinano, allegorie dei vizi. Il cinghiale e la volpe simboleggiano l’ignoranza, la donna con i seni cadenti avvolta da serpi è l’invidia, che si regge alla caviglia del re Mida riconoscibile dalle orecchie d’asino (chiaro riferimento al committente), mentre il satiro che sputa fuoco incarna il ministro dell’invidia. La personificazione della Presunzione mostra al re Mida proprio la pala di minor qualità, quella scelta da Ghiselli.

Ha i seni cadenti ed è accompagnata da serpenti anche la figura che sembra caderci addosso dal soffitto della Sala del Trionfo della Virtù nel Museo Casa Vasari di Arezzo affrescata dallo stesso Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 – Firenze, 1574) negli anni Quaranta del Cinquecento: “Ricordo come a dì 30 di luglio 1548 si cominciò il palco della sala di casa mia per colorillo a olio, dove sono quattro anguli drentovi i quattro tenpi o le quattro età et atorno otto quadri a tenpera con Giove, Saturno, Marte, Mercurio, Venere, Cupido et il Sole et la Luna et 4 quadri dove sono putti drento et in uno ottangulo nel mezzo a olio, dove la Virtù et la Fortuna et l’Invidia che conbattono insieme”, annotò l’artista nelle sue Ricordanze dei lavori che eseguì nella sua casa aretina in Borgo San Vito. Protagoniste dell’ottagono centrale della Sala sono infatti la Virtù che lotta con la Fortuna e l’Invidia: quest’ultima, rovesciata, scomposta e sgraziata, precipita verso il basso in antitesi alla Virtù che si slancia verso l’alto. Non c’è bellezza né armonia: i tratti sono contratti, quasi animaleschi, a sottolineare la perdita di umanità causata dall’invidia. Non guarda in alto, ma sembra ripiegata su se stessa, ed è vinta (un piede le schiaccia la nuca), incapace di elevarsi.
Al Museo e Real Bosco di Capodimonte è invece conservato il dipinto appartenente alla serie dei sette peccati capitali compiuta tra il 1570 e il 1575 dal pittore fiammingo Jacques de Backer (Anversa, 1555 circa – 1585 circa), dove i vizi sono rappresentati al centro di ogni opera della serie e sullo sfondo appaiono episodi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. L’Invidia di Backer è una donna dal corpo vigoroso e muscoloso ma allo stesso tempo innaturalmente deformato, e la prima cosa che colpisce è la testa: al posto dei capelli ha serpenti aggrovigliati, un richiamo diretto a Medusa, simbolo di veleno, pericolo e distruzione. Il volto è contratto in un’espressione torva, lo sguardo è laterale, diffidente, come se spiasse costantemente gli altri; con la bocca sta mordendo un cuore. Il corpo è quasi nudo, con i seni cadenti, e anche i colori dei tessuti che indossa sono significativi: il verde scuro della veste richiama il colore tradizionale dell’invidia, mentre il giallo spento del drappo allude alla malattia morale e alla corruzione interiore. Si vede infatti un corpo corrotto e nervoso. È raffigurata seduta su una roccia; il gesto della mano che scende verso il basso suggerisce un attaccamento a ciò che è meschino e terreno, mentre l’altra mano porta il cuore alla bocca, come se tutta la sua energia fosse rivolta a divorare piuttosto che a creare. Sullo sfondo appaiono in questo caso scene bibliche legate all’invidia: a sinistra, Giuseppe calato nel pozzo dai fratelli invidiosi, mentre a destra il diavolo che semina zizzania.
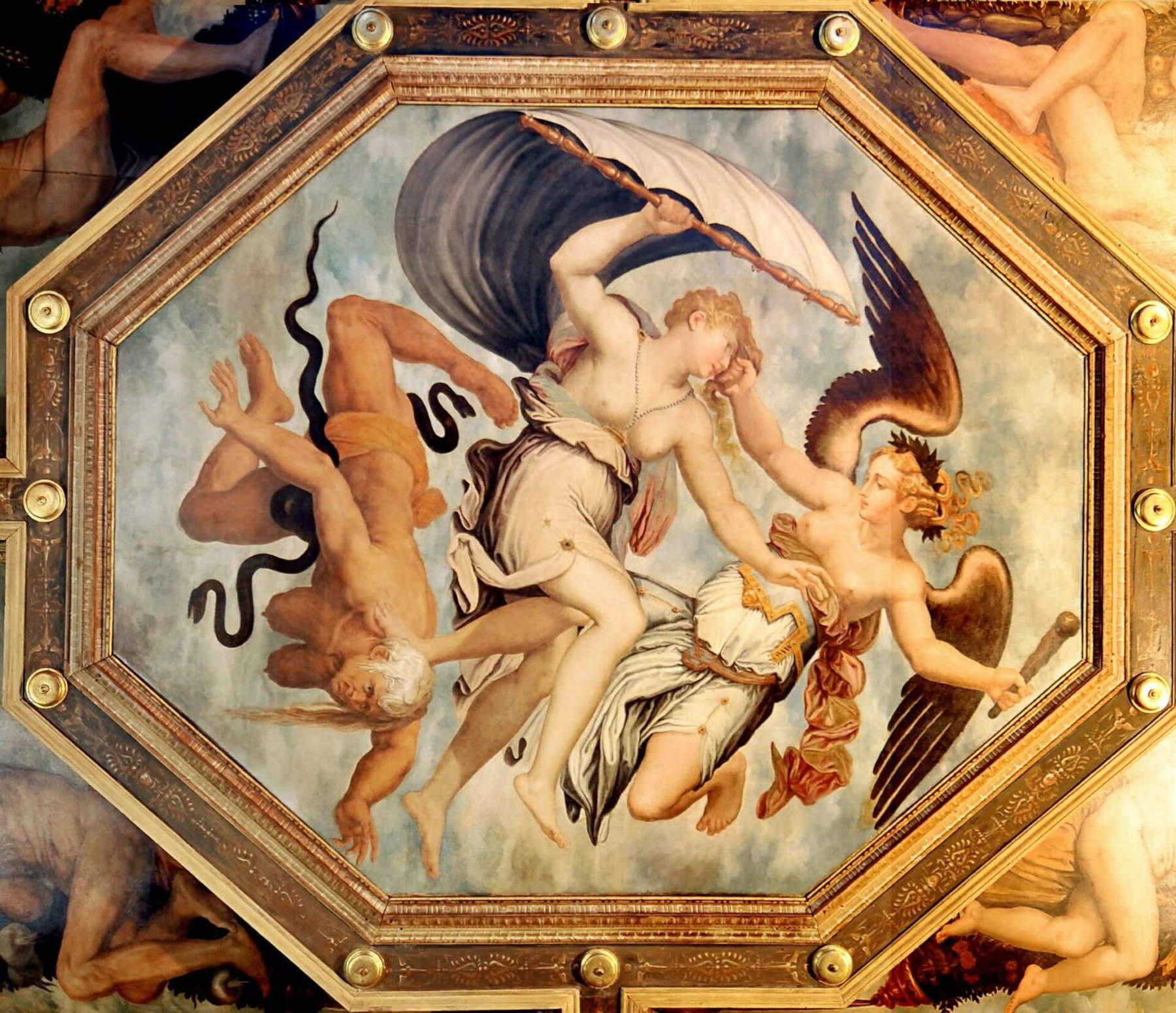




Più cruda e rappresentata con potente naturalismo è l’Invidia raffigurata da Giusto Le Court (Ypres, 1627 – Venezia, 1679), scultore fiammingo attivo a Venezia nel Seicento. Il busto in marmo che realizzò seguendo l’iconologia dell’invidia descritta da Cesare Ripa come una vecchia, brutta, e pallida, con il corpo asciutto, gli occhi biechi e scapigliata, e fra i capelli alcuni serpi, si trova oggi nel portego al primo piano di Ca’ Rezzonico (Museo del Settecento Veneziano), e il particolare che attira subito l’attenzione è l’urlo terrificante di dolore che pare uscire dalla bocca della donna a causa dei tanti serpenti che ha per capelli e che le mordono costantemente la testa e il corpo (da notare il realismo con cui i denti delle serpi si affossano nella pelle della vecchia per poi tirarla).
Ha serpi tra i capelli anche quella raffigurata da Nicolas Poussin (Les Andelys, 1594 – Roma, 1665) ne Il tempo protegge la Verità dagli attacchi dell’Invidia e della Discordia, oggi conservato al Louvre di Parigi. Commissionato nel 1641 dal cardinale Richelieu per il soffitto del Grand Cabinet del Palais-Cardinal, l’attuale Palais-Royal di Parigi, il dipinto raffigura il Tempo (i cui attributi, la falce e l’uroboro, sono retti da un putto accanto) che rapisce la Verità, rappresentata come una giovane donna nuda, mentre in primo piano sono sedute, sulla sinistra, la Discordia, e sulla destra l’Invidia; la prima caratterizzata da una torcia accesa e da un pugnale, la seconda dalla pelle livida, i serpenti al posto dei capelli e i colori giallo e verde dei panneggi che la ricoprono. L’opera sarebbe un’allegoria politica in onore del cardinale Richelieu per aver assicurato pace e concordia al regno, sfuggito nel tempo agli attacchi della discordia e dell’invidia.
Da queste opere emerge chiaramente quanto l’invidia non sia mai qualcosa di neutro o innocuo, ma una forza distruttiva che lascia segni visibili, come un veleno che corrode chi lo porta dentro. Quindi, quando pensiamo a quanto sia brutta l’invidia nei rapporti interpersonali... possiamo dire che anche l’arte ha espresso bene per immagini il suo concetto.

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta
Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.