Da giovane di belle speranze, capace di infondere umanità e purezza formale nel pur crudo realismo, a grande dimenticato dell’arte italiana, tra le due guerre e nella seconda metà del secolo scorso. Francesco Ciusa (Nuoro, 1883 – Cagliari, 1949), da Nuoro, formato a Firenze, esordiva 24enne nel 1907 addirittura a Venezia con La madre dell’ucciso ricevendo le immediate lodi di critici come Ugo Ojetti e Margherita Sarfatti, tanto da venire annoverato, secondo il ricordo dell’amico Lorenzo Viani, come il “giovane trionfatore della Biennale di quell’anno”. Poi una lunga attività, tra Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano e infine Orgosolo. Ma sempre e solo nei confini dell’amata, reinterpretata Sardegna. Con la difficoltà, tanto più per uno scultore e per giunta di opere di grandi dimensioni, a restare in contatto con il mercato (non ebbe mai un gallerista) e con le mostre del continente. Senza dimenticare i bombardamenti del 1943 in cui andò distrutto il suo atelier di Cagliari zeppo di opere, ma anche il suo capolavoro, in chiave Secessione viennese, ossia la decorazione della Sala dei consiglieri nel Palazzo civico. Da qui, il sostanziale disinteresse da parte dell’establishment storico artistico italiano per Francesco Ciusa, celebrato quasi solo nella sua isola. Ora a Nuoro è allestita (si è inaugurata il 13 settembre e resterà aperta fino al 5 aprile 2026) la più grande mostra mai realizzata sull’artista che a soli 24 anni, con la vecchia barbaricina chiusa nel suo dignitoso dolore per l’assassinio del figlio, si impose alla mostra di Venezia (subito dopo il 1907 il bronzo venne acquistato per la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, dove si conserva).
Francesco Ciusa, la forma del mito (questo il titolo) è stata organizzata dalla Fondazione Ilisso dell’omonima casa editrice nuorese che – a un anno dalla pubblicazione della più recente monografia su Ciusa, affidata alla penna di Elena Pontiggia dopo le precedenti curate da Rossana Bossaglia e Giuliana Altea (1990 e 2004, stessa casa editrice) – ha riunito novanta opere del maestro: soprattutto sculture, ceramiche, arredi e disegni, ma anche un solo e sorprendente dipinto di squisita fattura divisionista: La cena dei morti (collezione privata, restaurato per la mostra) del 1910 circa, con il desco preparato per i defunti secondo il rito della tradizione meridionale. In quarant’anni di lavoro, ma la parabola si chiuse sostanzialmente e malinconicamente negli anni Trenta, Ciusa tenne uniti il grande formato delle opere per gli spazi pubblici (come lo sfortunato monumento a Sebastiano Satta a Nuoro o quelli ai caduti di Iglesias e Cabras) alla dimensione più intima degli affetti privati familiari; coniugò realismo, simbolismo e purismo; accostò il bronzo allo stucco a marmo, ma anche la ceramica agli arredi realizzati in legno e ferro battuto (una sala della mostra è tutta per sedie, comodini e lampade mentre un gigantesco lampadario trova posto nel bookshop della Ilisso); plasmò nella creta le sue sculture prima di affidarle alla colata di gesso o di spingerle nel forno per trasformarle in terrecotte; e così fece con le scatole o le bomboniere nella stessa materia, ma vivacizzate con i colori, dati a freddo, degli abiti tradizionali sardi. Insomma, un approccio orizzontale al mondo della creatività da parte di questo figlio di un modesto ebanista di Nuoro che, anche grazie alla società Spica (1919-1924) e alla scuola di arti applicate di Oristano (1925-1929) da lui create, è stato partecipe tra Otto e Novecento del grande movimento internazionale – dall’Arts and Crafts alla Bauhaus, alle Case d’arte futuriste – di riscoperta del mestiere applicato alla produzione artigianale o industriale.




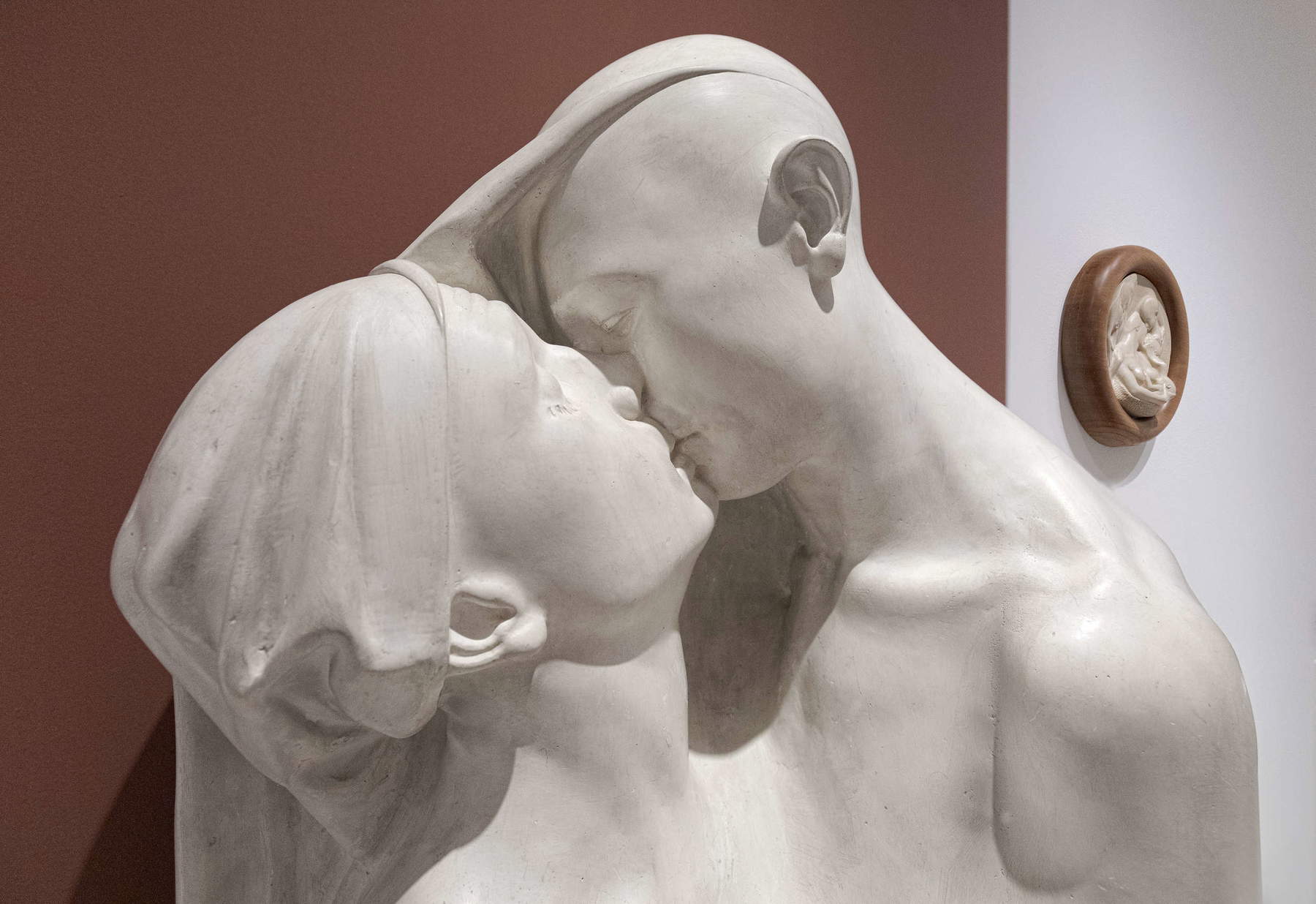




Proprio il focus sulla produzione ceramica seriale è l’aspetto distintivo di questa antologica, a mezzo secolo da quella del nuorese del 1974. Elena Pontiggia, grande esperta dell’arte del Novecento italiano, vi ha raccolto quanto scritto nell’ampia monografia del 2024 – ricca di pregnanti collegamenti alle opere di Rodin, d’Orsi, Meštrović, Wildt – e sintetizzato adesso nell’agile catalogo della mostra. Nel volumetto (155 pagine, 10 euro) si riporta la notizia dell’invito arrivato a Ciusa da un industriale americano, all’indomani del successo del 1907 con la Madre dell’ucciso alla kermesse internazionale di Venezia, di recarsi a New York “per dirigere una bottega d’arte applicata”. Ciò sembrerebbe significare che l’impegno dello scultore sardo nelle arti applicate vada retrodatato di più di dieci anni rispetto alla fondazione nel 1919 della manifattura Spica, acronimo della “Società per l’industria ceramica artistica”, chiusa dopo solo cinque anni per difficoltà economiche nonostante avesse come logo proprio il simbolo beneaugurale di abbondanza della spiga di grano.
Altro elemento che conferma la precoce attenzione alle arti applicate da parte dell’artista che, con la scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura nel 1926, e con il poeta e suo amico Sebastiano Satta, ha fatto conoscere la cultura sarda oltre i confini dell’isola e dell’Italia, viene dalla gigantografia della foto in cui Ciusa tiene in mano il piatto Il Golfo degli Angeli del 1910-1911 (in mostra sono esposte due versioni). Nello scatto (le immagini d’epoca ingrandite sono una caratteristica significativa dell’allestimento firmato dall’architetto Antonello Cuccu, poiché quasi sempre legate alle opere esposte) gli è accanto Sebastiano Satta, colpito successivamente, nel 1908, da un ictus che gli paralizzò la mano destra (morirà a 47 anni nel 1914): nella foto, che quasi certamente precede la malattia del poeta, si intravedono infatti, sulla destra, proprio quelle testine infantili che caratterizzano le ceramiche policrome di Ciusa. Un mondo, il suo, fatto di bambini sorridenti o disperati e di madri ragazzine la cui innocenza è impreziosita dalla cuffia variopinta dell’abito di Desulo, fino alla delicata figura della Sposina di Nuoro (in mostra la troviamo in tre esemplari) costretta a slacciarsi il corpetto troppo stretto perché ormai in dolce attesa.
Quale che sia la data di queste sue sculture in terracotta o in stucco di marmo (il marmorino della tradizione romana), resta il fatto che Ciusa infonde negli abiti della tradizione popolare sarda, in particolare barbaricina, gli echi della grande arte del Rinascimento che ha avuto modo di conoscere durante la frequentazione, tra il 1899 e il 1903, grazie a una borsa di studio del Comune di Nuoro, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. In riva all’Arno il ragazzo, che una foto del tempo raffigura scapigliato, scanzonato e bohémien, frequentò i corsi di Plastica d’ornato e la Scuola libera del nudo ed ebbe giovani, valenti amici in Libero Andreotti, Lorenzo Viani, Plinio Nomellini, Galileo Chini (forse anche Amedeo Modigliani). Nella città del Giglio, Ciusa apprese l’importanza fondante del disegno fiorentino e vide, tra l’altro, le terrecotte invetriate dei Della Robbia il cui candore delle carni riecheggia nella Fanciulla di Desulo solitamente esposta – come diverse altre opere, soprattutto in stucco a marmo, ma anche l’eccezionale bronzo con la donna seduta che fa Il pane (1907) – allo Spazio Ilisso della fondazione che ospita la mostra.
La principale collezione che ha prestato i pezzi è però la Regione Sardegna. Dai suoi depositi sono usciti i gessi di grandi dimensioni (tristemente chiuso ormai da otto anni per lavori il Museo Comunale Tribu di Nuoro, dedicato a Ciusa, che li aveva in comodato) che stanno a scandire le partecipazioni dell’artista alla Biennale veneziana: nel 1909, ad esempio, quando espose la leggiadra Filatrice e il possente Nomade (il viandante sardo, quasi l’Efix ridottosi a mendicante di Canne al vento, ha le labbra socchiuse e mostra i denti, secondo quello spirito vitale della scultura inventato dal genio barocco di Bernini); o nel 1914, allorché presentò in Laguna il Cainita (Cagliari, Galleria Comunale) dove l’epigono dell’assassino biblico tiene sospesa la testa mozzata della sua vittima (il volto, quasi un calco, è un ritratto dell’allievo Federico Melis, valente ceramista, mentre un grosso cane si abbevera del sangue come fa il cagnolino nell’Apollo e Marsia di Tiziano) e appare racchiuso in un mantello la cui forma non può non ricordare i volumi di Giotto o la plastica di Donatello (il volto dell’assassino rimanda allo Zuccone).







Un altro grande di Firenze, il sommo Michelangelo, è esplicitamente citato, ad esempio, nell’altra vittima di Ciusa della violenza barbaricina, la Dolorante anima sarda (oggi della Regione, il gesso partecipò nel 1911 all’Esposizione internazionale di Roma): nel bambino tra le gambe della donna implorante vendetta, riecheggia infatti il Figlio nella Madonna di Bruges di Buonarroti. Di gesso è anche l’Anfora sarda, sempre della Regione, del 1926-28, scelto come copertina della mostra per l’avvenenza del nudo, per l’imponenza della figura della madre (la scultura è alta quasi due metri) che si disseta mentre allatta il bambino attaccato al seno, per la spinta dal basso che porta la forma a liberarsi degli abiti déco e dalle pieghe del panneggio greco, per assumere una postura in linea con i canoni classici del ritorno all’ordine (l’opera fu accolta freddamente dalla critica nel 1928 alle Biennale di Venezia, dove Ciusa non metterà più piede).
Ma se, girando tra le sale della palazzina borghese che ospita lo Spazio Ilisso in cui le opere di Ciusa sono raggruppate non in ordine cronologico bensì tematico e tipologico, dovessimo segnalare un gruppo di lavori che meglio rispecchiano lo spirito profondo dell’artista, allora ci soffermeremo nella stanza dei baci. Il soggetto, klimtiano per antonomasia, trova espressione in tondi, bassorilievi, figure intere, gruppi compositi, in cui le labbra si dischiudono in gesti sensuali (il bacio di Sardegna pacificata del 1927; collezione della Regione), oppure di amore verso i figli da parte della madre (La famiglia protetta del 1922-1923 di collezione privata) ma anche del padre (La Campana, 1922-1923; Spazio Ilisso). Nel Ritorno del 1920-1923 (due le versioni esposte, una in terracotta l’altra in stucco marmorino) la forma si scioglie in commozione davanti alla figura del pastore che avvolge nell’orbace la compagna ritrovata e sorretta come fosse un Cristo deposto. Il ricongiungimento degli sposi è infatti nel dolore per la perdita del figlio: “La morte del piccolo”, scrive Elena Pontiggia, “è resa poeticamente dall’artista attraverso il corpicino che precipita in avanti e che i genitori non riescono a trattenere”. E qui probabilmente Ciusa “traspone il doloroso lutto” per la morte dell’ultimo dei sette figli avuti da Vittoria Cocco, il piccolo e amatissimo Giangiacomo.
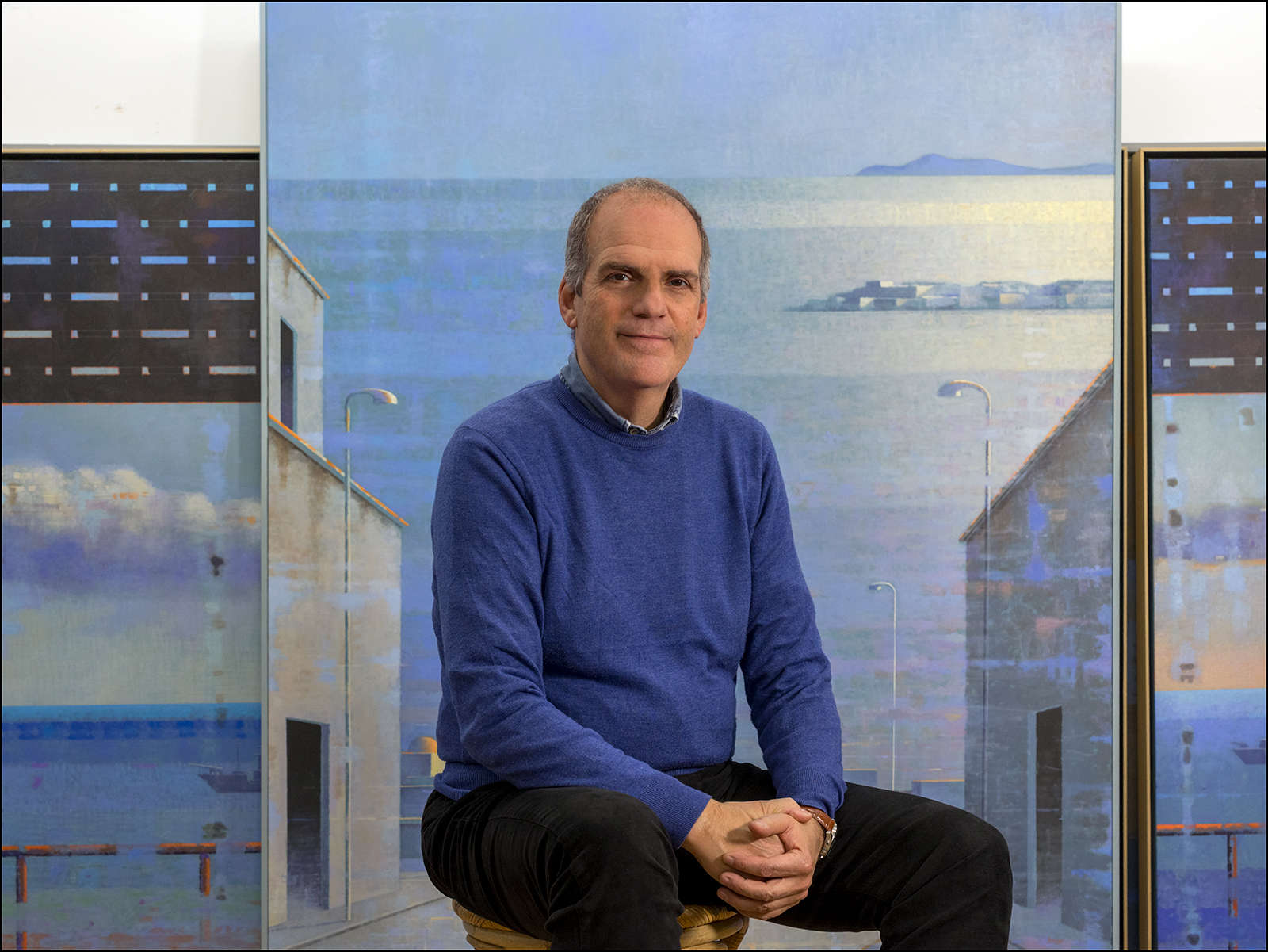
L'autore di questo articolo: Carlo Alberto Bucci
Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.