Da qualche anno, nel florilegio di temporanee capitali che, sul modello della Capitale Europea della Cultura, punteggiano la penisola, c’è anche il riconoscimento di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, istituito nel 2024. Le candidature per il 2027 sono state presentate nello scorso giugno: tra le città che ambiscono al titolo figurano due cittadine umbre, che hanno unito le forze nella speranza di centrare l’obiettivo. Due centri, Spoleto e Foligno, che come tante altre località dell’Umbria presentano straordinarie testimonianze artistiche del passato, in particolare medievali e rinascimentali: pensiamo solo, per Spoleto, al Duomo e alle vestigia longobarde, a cominciare dall’impressionante ‘classicismo’ della chiesa di San Salvatore, o, nel caso di Foligno, a quella gemma tardogotica che è Palazzo Trinci, con i suoi affreschi.
Il ruolo che Spoleto ha svolto nelle vicende artistiche del Novecento, tuttavia, non è meno significativo: la rassegna Sculture nella città, del 1962, ha rappresentato un momento fondamentale nella storia della scultura monumentale e nella riflessione sull’arte pubblica, di cui rimangono ancora segni ben evidenti in città, a cominciare dalla creazione più grandiosa ed emblematica di quell’iniziativa, il Teodelapio di Alexander Calder che accoglie il viaggiatore in arrivo alla stazione spoletina; dal 1958 il Festival dei Due Mondi (nell’ambito del quale, peraltro, Sculture nella città vide la luce) rappresenta un appuntamento di livello internazionale dedicato al teatro e alla musica del nostro tempo. Foligno, a sua volta, ha rafforzato il suo profilo di centro aperto alla contemporaneità a partire dal 2010, quando la gigantesca Calamita Cosmica di Gino de Dominicis, acquistata sei anni prima dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ha trovato la sua ultima dimora nella ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, secondo spazio espositivo del CIAC (Centro Italiano di Arte Contemporanea).

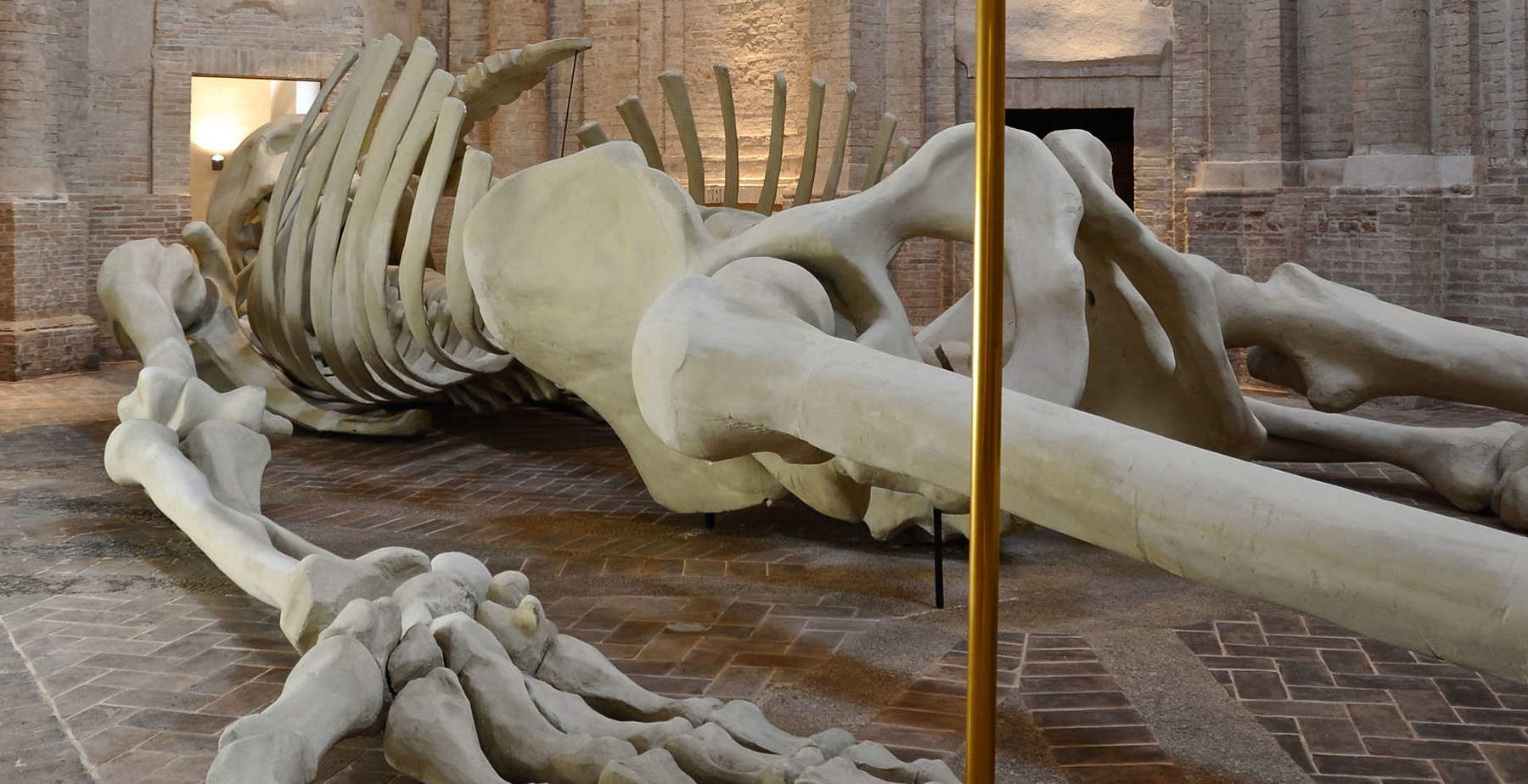


Lo ‘scheletrone’ dell’artista anconetano si trova pertanto racchiuso, quasi al millimetro, entro un reliquiario antico: una chiesa che, innalzata tra il 1760 e il 1765 su disegno dell’architetto Carlo Murena, rimase incompiuta, priva delle decorazioni previste e dunque con i mattoni a vista. L’esposizione della Calamita ci guadagna: sicuramente l’opera è meglio leggibile nel contesto dell’attuale rivestimento in laterizio, che non avvolta dagli intonaci chiari e dagli stucchi che avrebbero dovuto rivestire l’interno della chiesa. Siamo di fronte a un esempio riuscito di riuso a fini espositivi di uno spazio del passato che aveva perso la propria funzione e ne chiedeva un’altra, per inserirsi di nuovo a pieno titolo nel tessuto cittadino. Una riuscita convivenza tra antico e contemporaneo: termine forse da preferire all’ormai abusato «dialogo» tra epoche diverse, dietro il quale si nascondono spesso operazioni pretestuose e accostamenti poco più che casuali.
Un discorso analogo può essere fatto per Palazzo Collicola a Spoleto. Palazzo nobiliare tra i principali della città, eretto tra il 1717 e il 1734 su disegno dell’architetto senese Sebastiano Cipriani, l’edificio ospita al secondo piano la Galleria d’Arte Moderna “Giovanni Carandente”, il museo di arte contemporanea più importante della regione, assieme alla Fondazione Burri di Città di Castello, che vanta nelle sue raccolte, in particolare, le opere acquisite dal comune di Spoleto attraverso le edizioni del Premio Spoleto, svoltosi tra il 1953 e il 1968, dipinti del cosiddetto “Gruppo dei sei”, creazioni di Calder e di altri illustri partecipanti alla mitica mostra del 1962, lavori di Leoncillo e Sol LeWitt. Se il secondo piano di Palazzo Collicola non presenta elementi storici di rilievo, il piano nobile sfoggia ancora interni riccamente decorati (a cominciare dalla splendida galleria) e una compagine di dipinti antichi in molti casi di notevole interesse (un nome per tutti: la nota Spezieria di ambito guerciniano).




La vivace attività espositiva della Galleria d’Arte Moderna si dispiega, attraverso le mostre temporanee, anche in questa porzione del palazzo di maggior pregio storico e artistico: come avviene con la bella mostra dedicata a William Kentridge, Pensieri fuggitivi, curata da Saverio Verini, direttore dei Musei Civici spoletini. Nella rassegna, aperta fino al 2 novembre 2025, viene presentata un’ampia selezione di opere realizzate negli ultimi venticinque anni dall’artista sudafricano, tra disegni, sculture, video, stampe e taccuini. I lavori di Kentridge si posizionano negli spazi storici senza soffocarli, anzi instaurando in diversi casi rapporti con i dipinti antichi affissi alle pareti: relazioni che rendono più articolata l’esperienza della visita e invitano lo spettatore a considerare in maniera più complessa sia la tela del Sei-Settecento che il lavoro dell’artista contemporaneo (la cui ricerca, d’altra parte, ha e mostra senza reticenze salde radici nell’arte del passato, dall’antichità classica alle avanguardie storiche).
Ma prima del 2027, in cui Spoleto e Foligno potrebbero rivestire il ruolo di capitali italiane della contemporaneità, c’è il 2026, anno in cui cade il centenario della nascita di Dario Fo, personaggio che fu molto legato all’Umbria: lui e Franca Rame frequentarono assiduamente la Libera Università di Alcatraz messa in piedi dal figlio Jacopo nel 1982 sulle colline tra Gubbio e Perugia, e ancora oggi laboratorio di importanti progetti artistici e sociali (vi è tra l’altro anche una bella pittura murale realizzata da Dario, che fu anche, o forse prima di tutto, pittore, dedicata all’amato San Francesco). In programma per il 2026 una ricca serie di iniziative, che si terranno in Umbria, ma non solo, e anzi in tutto il mondo (dove le opere di Fo sono tradotte e messe in scena): rappresentazioni teatrali, mostre, proiezioni, giornate di studio. Centrale tra le manifestazioni previste sarà il progetto «100 anni per 100 Paesi», a cura della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, che si articola in una serie di eventi che avranno luogo in ben cento Stati diversi e, nel contempo, in cento eventi diffusi sull’intero territorio nazionale. A Perugia, il Museo Civico di Palazzo della Penna sarà interamente occupato da una rassegna dedicata al Fo pittore e in particolare alle sue opere incentrate sulla figura di San Francesco, di cui peraltro nel 2026 ricorrono gli ottocento anni dalla morte.

L'autore di questo articolo: Fabrizio Federici
Fabrizio Federici ha compiuto studi di storia dell’arte all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore. I suoi interessi comprendono temi di storia sociale dell’arte (mecenatismo, collezionismo), l’arte a Roma e in Toscana nel XVII secolo, la storia dell’erudizione e dell’antiquaria, la fortuna del Medioevo, l’antico e i luoghi dell’archeologia nella società contemporanea. È autore, con J. Garms, del volume "Tombs of illustrious italians at Rome". L’album di disegni RCIN 970334 della Royal Library di Windsor (“Bollettino d’Arte”, volume speciale), Firenze, Olschki 2010. Dal 2008 al 2012 è stato coordinatore del progetto “Osservatorio Mostre e Musei” della Scuola Normale e dal 2016 al 2018 borsista post-doc presso la Bibliotheca Hertziana, Roma. È inoltre amministratore della pagina Mo(n)stre.Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.