Musei italiani con oltre 60 milioni di visitatori, introiti arrivati quasi a toccare i 400 milioni di euro: numeri che, per i musei statali, mai s’erano visti prima di quest’anno. Il ministro della cultura Alessandro Giuli non ha dunque esitato a parlare di “miglior risultato di sempre dei musei e dei parchi archeologici statali”, ritenendo che l’indiscutibile successo sia “segno di quanto il governo stia ben operando e di come la cultura e la bellezza italiane siano riconosciute e apprezzate nel mondo, generando in milioni di persone il desiderio di goderne appieno visitando il nostro paese”. Cosa si cela dietro ai dati? È la domanda che ci facciamo ogni anno. Intanto, c’è da rilevare una tendenza singolare: gli introiti sono cresciuti cinque volte quanto sono cresciuti i visitatori. Nel 2024, i visitatori dei musei sono stati 60.850.091, contro i 57.730.502 del 2023 (un incremento del 5,3%), mentre gli introiti sono cresciuti del 23%, passando dai 313.888.163 del 2023 ai 382.004.344 del 2024. In termini assoluti, è un aumento di circa 69 milioni di euro che è da attribuire per lo più a un numero ristretto di musei: il Parco Archeologico del Colosseo (22 milioni in più rispetto al 2023), gli Uffizi (13 milioni), la Galleria dell’Accademia di Firenze (9 milioni), il Pantheon (8 milioni), il Parco Archeologico di Pompei (3 milioni).
Sorprendono, in particolare, i dati degli Uffizi (che, va sottolineato, nel calcolo complessivo includono anche i visitatori di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli, gestiti dallo stesso istituto) e della Galleria dell’Accademia, con gli introiti che sono esplosi a fronte di aumenti tiepidi nel numero dei visitatori (agli Uffizi poco meno di 160mila visitatori in più, ovvero 5.294.968 contro i 5.196.106 del 2023, mentre all’Accademia aumenti paragonabili, con un totale di 2.189.103 visitatori contro i 2.013.914 dell’anno scorso). È l’effetto del cambio delle politiche tariffarie dei due musei: all’Accademia il biglietto ha subito un rincaro del 35% circa rispetto al 2023 (è passato da 12 a 16 euro), e il pubblico non pagante ha conosciuto una leggera flessione in confronto all’anno prima, mentre gli Uffizi, che fino a prima del 2025 basavano la propria bigliettazione su tariffe differenziate in base alla stagione, hanno tenuto invariato il prezzo del biglietto base, ma nel 2024 hanno drasticamente ridotto la bassa stagione che dava diritto a entrare pagando solo 12 euro (dal 10 gennaio al 20 febbraio e dal 10 novembre al 20 dicembre, mentre nel 2023 la bassa stagione andava dal 1° novembre al 28 febbraio: nel 2025 non risulta invece più esistere una distinzione tra alta e bassa stagione, si paga 25 euro sempre).

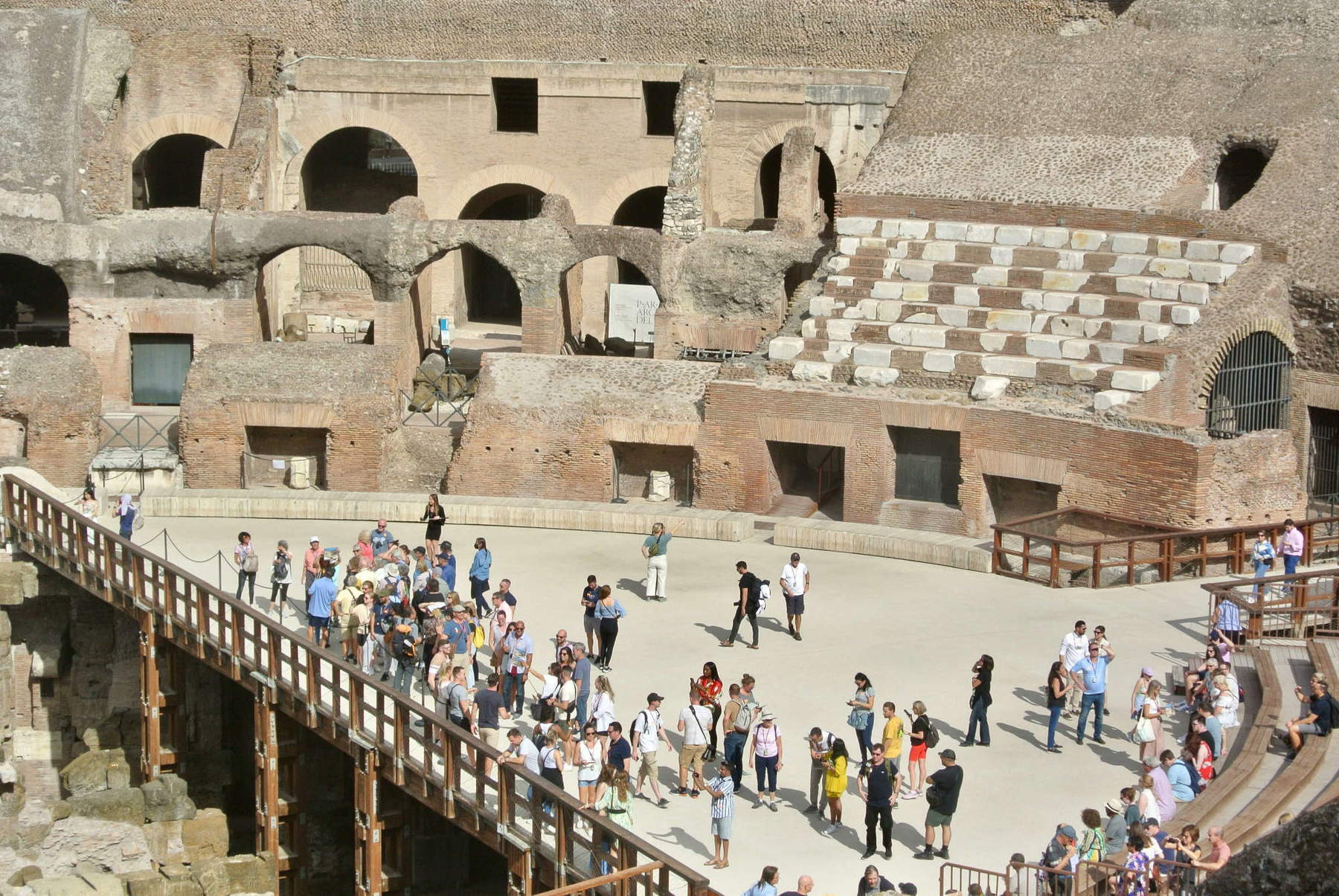

In generale gli effetti di questo aumento degli introiti si vedono su un gran numero dei musei, anche negli istituti che hanno conosciuto cali di visitatori: è il caso del Museo Egizio di Torino, 25mila visitatori in meno rispetto al 2023, ma quasi un milione e mezzo di incassi in più e senza variazioni del biglietto d’ingresso (il museo è stato in grado d’attirare più pubblico pagante tariffa piena), oppure di Castel Sant’Angelo (10mila visitatori in meno, quasi un milione in più), o ancora della Reggia di Caserta (30mila visitatori in meno, mezzo milione in più) e via dicendo. Il risultato è il biglietto medio più alto di sempre: 12,01 euro contro gli 11,37 dello scorso anno (e la media dello scorso anno era a sua volta la più alta di sempre). L’aumento è stato comunque più contenuto rispetto all’anno passato: un 5,6% di aumento tra 2023 e 2024 rispetto al 7,6% del 2023 sul 2022 e al 13,36% (il secondo aumento più alto di sempre) del 2022 rispetto al 2021. È una tendenza, quello dell’aumento medio del biglietto, che per un certo periodo, soprattutto nei primi anni Duemila, rifletteva grosso modo l’andamento dell’inflazione, e che però negli ultimi anni è notevolmente aumentata, con aumenti molto marcati che hanno conosciuto una pausa soltanto nel primo anno del Covid. È ancora un effetto della riforma Franceschini e della naturale propensione degli istituti, raggiunta l’autonomia nelle politiche tariffarie, a cercare di ottimizzare gli introiti, soprattutto laddove il museo sia meta particolarmente gettonata dai turisti. Ancora nel 2016, dunque, il costo medio del biglietto era abbondantemente inferiore agli 8 euro, e il ritocco medio raramente superava il 3%. Dall’epoca della piena applicazione della riforma Franceschini, lo scenario ha conosciuto modifiche radicali, e da allora le tariffe sono sempre cresciute a ritmo sostenuto. C’è poi un altro elemento da rilevare: nel 2024 è stato pressoché dimezzato il numero dei musei sempre gratuiti: erano 45 nel 2023, sono rimasti in 27 nel 2024. Non ci sono mai stati così pochi musei gratuiti (prima della riforma erano abbondantemente sopra i 60, contro i circa 130 a pagamento: adesso siamo a 176 contro 27). Questa riduzione ha riguardato, seppur in misura minore, anche i siti archeologici: 127 sempre gratuiti contro i 134 dello scorso anno (ma erano 165 nel 2017). Si tratta, certo, di musei che difficilmente fanno segnare grandi numeri, ma è comunque un indicatore significativo. Infine, i visitatori paganti nei musei sono aumentati molto di più rispetto ai non paganti: 31.784.116 contro i 27.590.303 paganti del 2023 (i gratuiti sono stati 19.848.707, contro i 18.072.240 dello scorso anno). La tendenza, insomma, è sempre quella di massimizzare i profitti, e non c’è ragione di ritenere che il Ministero smetta di seguire questa logica, specialmente alla luce dei continui aumenti di turisti in arrivo in Italia. E poi, finché il pubblico pagante è in aumento, significa che la disponibilità alla spesa da parte dei visitatori non è frenata dagli aumenti dei biglietti. Si ritiene, sostanzialmente, che i musei valgano ancora tutto ciò che si spende per visitarli.
Nonostante gli aumenti record di quest’anno, sono comunque diversi i musei che hanno perso visitatori. La flessione più significativa è quella del Pantheon, che ha perso per strada oltre un milione di visitatori, e il perché è presto detto: fino a luglio 2023 il Pantheon era gratuito. Dei primi 30 musei del 2023, hanno perso visitatori 13 istituti: Castel Sant’Angelo, il Museo Egizio, la Reggia di Caserta, le Ville di Tivoli, il Parco Archeologico di Ercolano, il MANN di Napoli, il Parco di Paestum, il Palazzo Reale di Napoli, il Museo Archeologico di Venezia, il Museo Nazionale Romano, il Palazzo Ducale di Mantova, le Terme di Caracalla e la GNAM di Roma. Cos’è accaduto? Normali fluttuazioni, verrebbe da dire, anche alla luce del fatto che il record dei visitatori, pure considerando il vistoso calo del Pantheon (un milione di visitatori in meno per effetto della fine della gratuità), è da ascrivere soprattutto a due musei: il Parco Archeologico del Colosseo, che da solo ha registrato circa 2,5 milioni di ingressi in più rispetto all’anno scorso, e il complesso Vittoriano-Palazzo Venezia, che è a ingresso gratuito e che ha fatto circa un milione di ingressi in più rispetto all’anno scorso, compensando dunque il calo del Pantheon. Proprio il calo dei visitatori del Pantheon da quando è stato introdotto il biglietto a pagamento (occorrerà rammentare che prima di questo provvedimento, il Pantheon superava agilmente i 9 milioni di visitatori l’anno) è stata probabilmente la causa per cui dal 2023, nel calcolo dei visitatori del Parco Archeologico del Colosseo, sono stati conteggiati anche i rientri: un metodo davvero singolare, che tiene conto dei visitatori che acquistano il biglietto per il giro completo di Colosseo e Foro Romano e per i quali vengono considerati due ingressi. In sostanza, chi visita il Colosseo e con lo stesso biglietto entra poi al Foro Romano, viene contato due volte, la seconda come visitatore non pagante: è la ragione per cui dal 2023 è esploso il numero dei visitatori totali non paganti, aumentato di circa 4 milioni di visitatori da un anno all’altro (l’analisi che avevamo fatto lo scorso anno fornisce dati più precisi).
Un dato che dovrebbe far riflettere il ministero è l’aumento dello squilibrio tra i 30 musei più visitati e tutti gli altri. Com’è noto, il grosso dei visitatori si concentra nei musei più grandi: nel 2023, i primi 30 musei richiamavano 44.908.182 visitatori, il 77,78% del totale. Il divario l’anno successivo è aumentato, ed è arrivato al 78,45%: 47.740.967 visitatori si sono concentrati nei primi 30 musei. Significa che tutti gli altri 423 musei attirano appena il 21,55% dei visitatori, una delle cifre più basse di sempre: sarà opportuno ricordare che, prima della riforma Franceschini, questo dato toccava grosso modo il 30%. E significa anche, di rimando, che la crescita del 5,3% sul totale dei visitatori non aiuta a comprenderne la distribuzione: i primi 30 musei della classifica hanno conosciuto un incremento che in termini percentuali si assesta poco sotto il 6%, mentre tutti gli altri musei, i musei “minori” per utilizzare un aggettivo orribile (perché fuori dai primi 30 più visitati figurano alcuni tra i musei più importanti d’Italia), sono cresciuti di appena il 2,1%.
C’è da dire che il ministro Giuli centra perfettamente il punto quando afferma che “la cultura e la bellezza italiane siano riconosciute e apprezzate nel mondo”, perché gli incrementi dei visitatori dei musei riflettono gli aumenti delle presenze turistiche nel nostro paese, in particolare di quelle straniere, che rispetto all’anno precedente sono cresciute di poco meno del 7%: è normale che un turista che non sia mai stato a Roma o a Firenze difficilmente se ne andrà prima d’aver visto il Colosseo o gli Uffizi. Sull’interrelazione tra visitatori dei musei e andamento dei flussi turistici occorrerà tornare con un ulteriore approfondimento: per il momento sarà sufficiente rimarcare che i visitatori dei musei nel 2024 sembrano essere aumentati soprattutto per inerzia, per effetto d’una crescita spontanea nei riguardi della quale la passata gestione Sangiuliano (il ministro, ricorderà il lettore, è rimasto in carica fino ai primi di settembre 2024) parrebbe non avere meriti particolari. Affinché, specialmente su tutti i musei che rimangono fuori dai primi 30, l’inerzia si trasformi in crescita guidata, è necessario ragionare soprattutto in termini di politiche rivolte alla cittadinanza, sia a livello “macro”, per così dire (dunque campagne da parte del Ministero centrate soprattutto sul patrimonio periferico), sia a livello “micro”, con incentivi alla visita (gratuità per i residenti e incoraggiamenti vari che ci indirizzino verso una progressiva abolizione delle domeniche gratuite, convenzioni con altri istituti del territorio, biglietti a tempo, iniziative particolari, ovvero azioni su cui chi scrive insiste da tempo e a proposito delle quali su queste pagine s’è parlato a lungo).

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.