I mosaici di Piazza Armerina, il Satiro danzante di Mazara del Vallo e la Dea di Morgantina sono alcuni tra i più noti tesori archeologici conservati in Sicilia. L’isola, nel corso del tempo, ha restituito ritrovamenti straordinari, delineando una geografia inusuale e un itinerario imprevedibile, che si snoda anche attraverso località non tradizionalmente interessate da grandi flussi turistici. In questa rotta, costellata di capolavori ancestrali, è necessario annoverare anche Centuripe, piccolo comune incastonato su una formazione montuosa, a metà strada tra Enna e Catania. Non solo perché, al pari dei luoghi citati, anche Centuripe conserva la sua icona archeologica, una magnifica testa dell’imperatore Augusto, che l’archeologo Nicola Bonacasa definì “il miglior ritratto di età augustea conservato in Sicilia”, ma anche perché il suo territorio, di straordinario valore storico, custodisce testimonianze di rilievo, tra cui tombe imperiali e numerosi altri reperti, in parte visibili presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe.
La visita alla cittadina rappresenta una meta imprescindibile per gli appassionati di archeologia che viaggiano in Sicilia. Centuripe e i suoi immediati dintorni costituiscono infatti un vero sito archeologico diffuso, frutto della sedimentazione di secoli e civiltà, che attestano una presenza umana quasi ininterrotta sin dal 5000 a.C., favorita dalla presenza di numerosi corsi d’acqua, tra cui il fiume Simeto, che in passato erano navigabili.
I ritrovamenti effettuati in questa area sono incalcolabili, ma si tratta di un ricco patrimonio che storicamente è stato afflitto da un’emorragia continua: un incessante depauperamento che ha portato molti di questi tesori lontano dal loro luogo di origine, prima per iniziativa di archeologi francesi e inglesi, e successivamente vittima di tombaroli che, nottetempo, hanno soddisfatto la famelica richiesta di un collezionismo senza scrupoli. Ciononostante, ancora molte cose sono rimaste in loco: reperti fortunatamente inamovibili, come il sito di Riparo Cassataro, un complesso roccioso in cui sono state scoperte pitture rupestri risalenti al Neolitico, raffiguranti figure animali e antropomorfe, alcune delle quali riconosciute come ballerine, forse legate a qualche rito propiziatorio rivolto alla terra.
Grazie alla ricca presenza di acque, Centuripe divenne un centro abitato dai Siculi, un’antica popolazione ancora avvolta nel mistero, poiché ha lasciato rarissime testimonianze scritte. Gli studiosi credono che i Siculi si siano spostati dal Lazio, ma che originariamente provenissero dall’Europa dell’Est. Proprio da Centuripe proviene un reperto ritenuto fondamentale per la ricostruzione linguistica di questo popolo, oggi custodito a Karlsruhe, in Germania: si tratta di un askos, un vaso risalente al V secolo a.C., corredato dalla più lunga iscrizione in grafia sicula oggi nota.






I Siculi erano una popolazione con un’economia fondata sull’agricoltura e la pastorizia, che si insediò in particolar modo nell’entroterra siciliano e che ben presto entrò in conflitto con le colonie greche, tanto che Centuripe fu distrutta due volte all’epoca in cui la tirannide governava su Siracusa. Più tardi, la città di Centuripe entrò sempre di più nell’orbita greca, di fatto ellenizzandosi. Infatti, adottò il greco come lingua e diede vita a un fiorente commercio di terrecotte, che venivano esportate in tutto il bacino del Mediterraneo. Ma è forse in epoca romana che Centuripe visse il periodo di massimo splendore, a partire dal 263 a.C., quando durante la campagna contro i Cartaginesi si sottomise spontaneamente, ottenendo in cambio l’esenzione dalle imposte e accrescendo la sua influenza, fino a toccare l’apice sotto Augusto prima e Adriano poi, quando la città si ammantò di costruzioni e arredi monumentali, arrivando a sfiorare le 12.000 persone, più del doppio di quante vi abitino oggi.
Ed è proprio il Museo Archeologico presente nel piccolo borgo siciliano che permette di rivivere questa storia, tra reperti d’eccezione. Per la verità, si tratta di un museo dalla storia piuttosto travagliata: nato negli anni Venti del Novecento per accogliere alcuni ritrovamenti, si decise di dotarlo di una nuova sede a partire dagli anni Cinquanta, ma i lavori si protrassero a lungo. Anche trent’anni dopo, quando intervenne l’importante architetto museologo Franco Minissi, che ripensò la struttura dotandola di elementi di grande fascino ancora presenti, come le scale e la sala conferenze, il museo continuava a rimanere chiuso. Per la sua riapertura si dovette attendere il 2000, ma già dieci anni dopo fu nuovamente chiuso per ulteriori lavori di messa in sicurezza. Finalmente, nel 2024, il museo è stato reinaugurato con un allestimento più ricco.
Al suo interno sono oggi custoditi alcuni preziosi reperti di scavo che testimoniano un lungo tragitto della storia centuripina. Tra i più antichi si annoverano frammenti di vaso, selci dell’età neolitica e un volto a rilievo, databile tra i 5000 e i 4500 anni fa, che originariamente decorava una grande anfora: si tratta di una delle più antiche raffigurazioni plastiche antropomorfe rinvenute in Italia.
La produzione vascolare di età arcaica esposta tradisce i contatti del mondo siculo con quello greco e la conseguente adozione di prodotti e tecniche tipici di quest’ultimo, come alcuni vasi a decorazione geometrica, che mostrano uno stile e una tecnica di cui sono stati trovati corrispettivi nelle isole di Cipro e di Creta.
Dalle pendici nordorientali di Centuripe provengono invece reperti trovati in una necropoli in uso tra il IV e il II secolo a.C., tra cui una coppa con iscrizione graffita che cita un certo Artemonos, e una brocchetta al cui interno è stata rilevata la presenza di camomilla. Il suo uso non è attestato nei rituali funerari, bensì per finalità mediche e probabilmente veniva utilizzata dal defunto in vita, motivo per cui si è deciso di accompagnarla alla sua sepoltura. Una piccola statuetta in terracotta raffigurante la dea dei raccolti, Demetra, proviene invece da un abitato di età ellenistica.


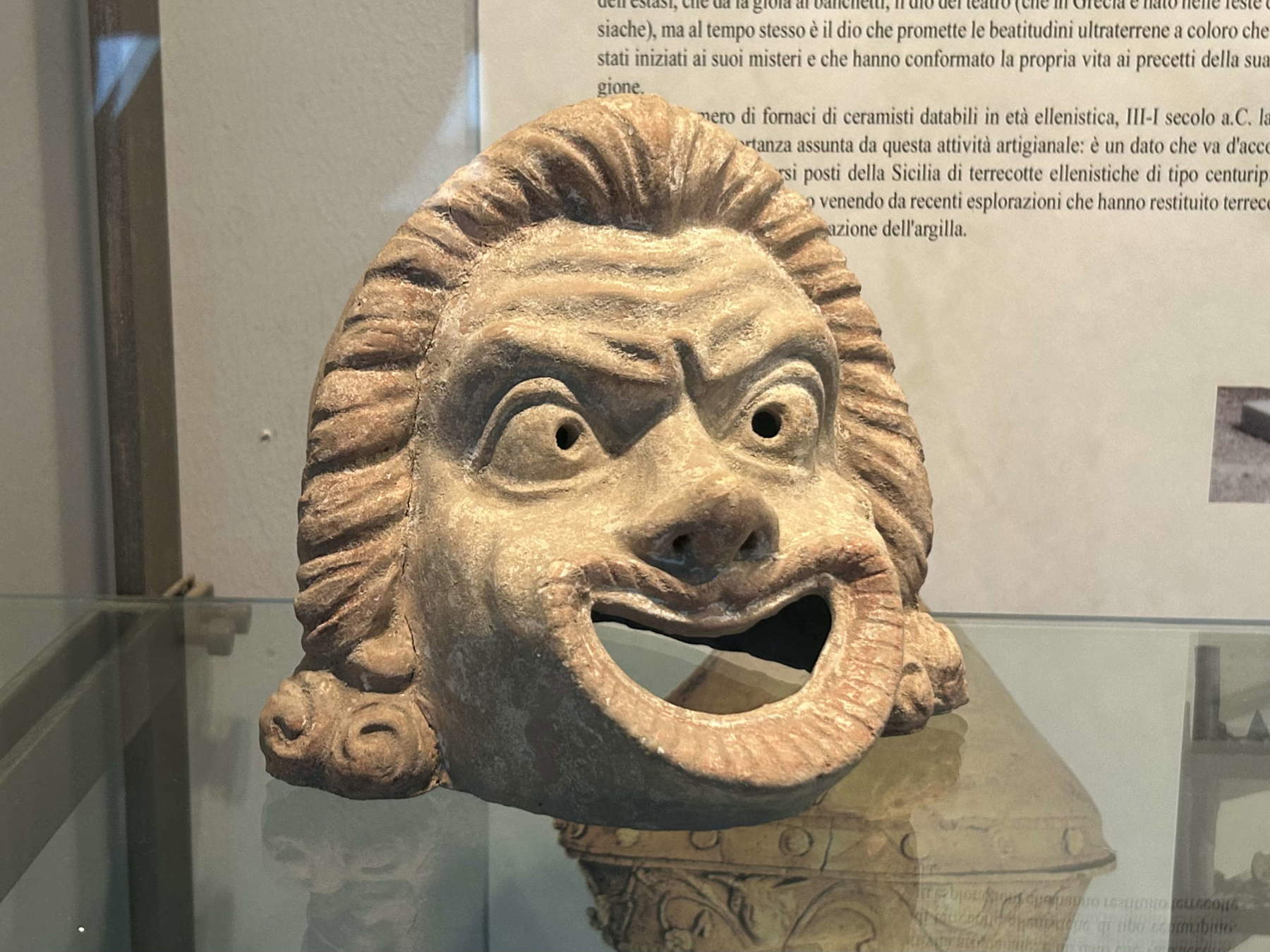

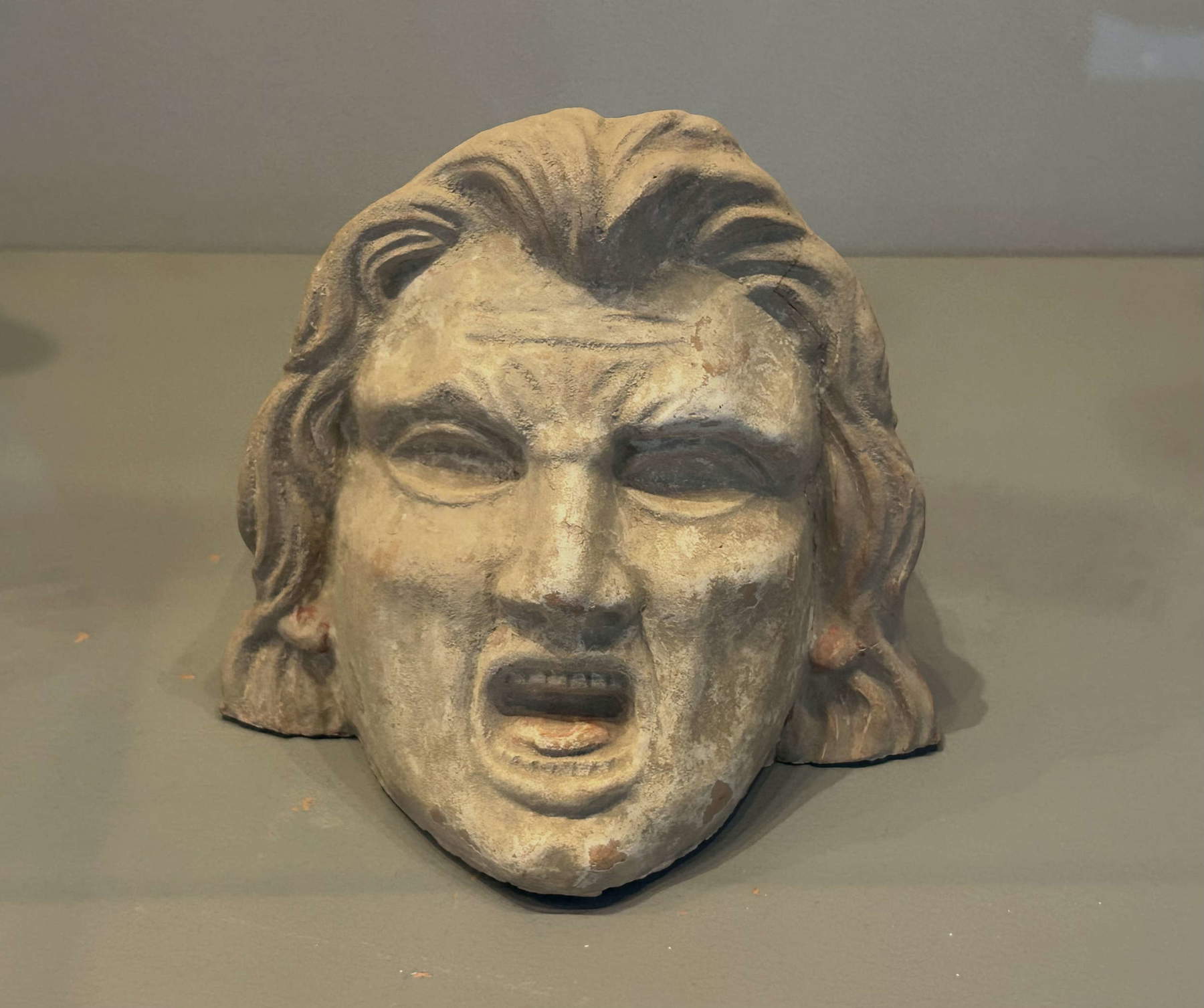

Di grandissimo interesse sono le maschere centuripine, numerose delle quali furono rinvenute nel primo decennio del Novecento dal celebre archeologo Paolo Orsi. È stato ipotizzato che queste maschere teatrali, che Centuripe ha restituito in gran numero (in Sicilia inferiori solo a quelle di Lipari), avessero una funzione probabilmente apotropaica, ovvero dovevano spaventare gli spiriti maligni, ma avevano anche valenze simboliche che le facevano impiegare nei riti funebri, come confermerebbe il fatto che sono state soventemente rinvenute all’interno di sepolcri. È stato inoltre ipotizzato che gli artigiani se ne avvalessero come modelli per la realizzazione di maschere reali usate nelle recite. Queste maschere tragiche e comiche si denotano per una ritrattistica di grande freschezza espressiva, alcune delle quali parrebbero avere tratti fisiognomici africani e perfino orientali.
La coroplastica centuripina raggiunse livelli qualitativi altissimi, con sculture fittili a tutto tondo, tanto da farle meritare l’appellativo di “Tanagra di Sicilia”, in riferimento alla città della Beozia famosa per la sua produzione di statuaria in terracotta. Queste figure mostrano donne con ricchi panneggi in pose movimentate, ma anche figure maschili eternate in momenti di quotidianità, personaggi tratti dal mito e divinità.
Altra specificità del territorio sono i celebri vasi centuripini, oggi sparsi nei musei di mezzo mondo. Le basi per il loro studio furono poste da Paolo Orsi, ma ancora oggi la loro conoscenza è piuttosto intricata e resa complessa da ritrovamenti spesso disorganici, a seguito di scavi clandestini, e anche dalla grande produzione di falsi. Si tratta comunque di vasi realizzati tra il III e il II secolo a.C., caratterizzati da decorazioni a rilievo con motivi floreali o architettonici e da pittura figurativa realizzata a tempera dopo la cottura del vaso, spesso legata a scene dionisiache o femminili. Erano vasi frequentemente impiegati come doti nuziali e come corredi funebri, oggetti che denotavano un grande prestigio sociale. E benché siano stati prodotti per non più di tre generazioni, la loro qualità è tale da renderli particolarmente noti, tanto che se ne trova perfino uno esposto nel percorso permanente del Met di New York.
Ma forse la parte più sbalorditiva del museo è quella legata alla città imperiale, che ha restituito una statuaria eccezionale, testimoniando l’importanza assunta da Centuripe in questo periodo. La città, in questa fase, dovette ammantarsi di costruzioni monumentali tra tombe, un foro e gli Augustali, un complesso architettonico con funzioni civico-sacrali che promuoveva il culto della dinastia imperiale, e che sorgeva a poche decine di metri dalla sede del museo. Da qui provengono numerose sculture di grande interesse, tra cui i ritratti di Germanico e di Druso Minore, membri della famiglia imperiale.
Di grande raffinatezza sono anche una statua ellenistica di Musa, una colossale testa dell’imperatore Adriano, e una coppia di statue acefale appartenenti a una ricca famiglia di mecenati, i Pompeii Falcones, caratterizzate da un ricco panneggio. Ma l’autentico capolavoro del museo è senza dubbio la testa di Augusto, ritrovata nel 1938 durante le celebrazioni del bimillenario augusteo, da un operaio coinvolto nei lavori di fondazione dei piloni destinati a sorreggere un tratto di strada.
L’opera, che deriva probabilmente dal modello della statua di Augusto rinvenuta a Roma a Prima Porta, fu esposta per un solo anno presso l’Antiquarium locale. Successivamente, la Soprintendenza decise di destinarla “temporaneamente” al Museo Archeologico di Siracusa, in attesa che Centuripe si dotasse di una struttura più adeguata ad accoglierla, ma forse anche per punire l’atteggiamento piuttosto sfrontato del Comune di allora che autorizzò i lavori stradali in area archeologica senza aver avvertito gli enti competenti. Inoltre, nel breve periodo in cui la statua rimase a Centuripe fu maneggiata da non addetti ai lavori, che ricavarono dei calchi per replicarne la testa. Il trasferimento si rivelò provvidenziale, poiché lo spazio museale di allora subì alcuni furti.
Nel 2021, dopo 83 anni di assenza dalla città, la statua ha lasciato il Museo Paolo Orsi di Siracusa per essere qui esposta fino al 2026, ma la speranza è che possa tornare definitivamente nel suo contesto originale. A differenza dell’altra statuaria romana, anche quella presente nel museo e caratterizzata da un realismo venato di grande veridicità, l’effige di Augusto mostra caratteri neoattici, con una resa idealizzante tipica dell’arte ellenistica, come se fosse uscita dallo scalpello di Antonio Canova. Questo stile doveva probabilmente marcare la distanza tra i comuni mortali e un’entità divina come l’imperatore.



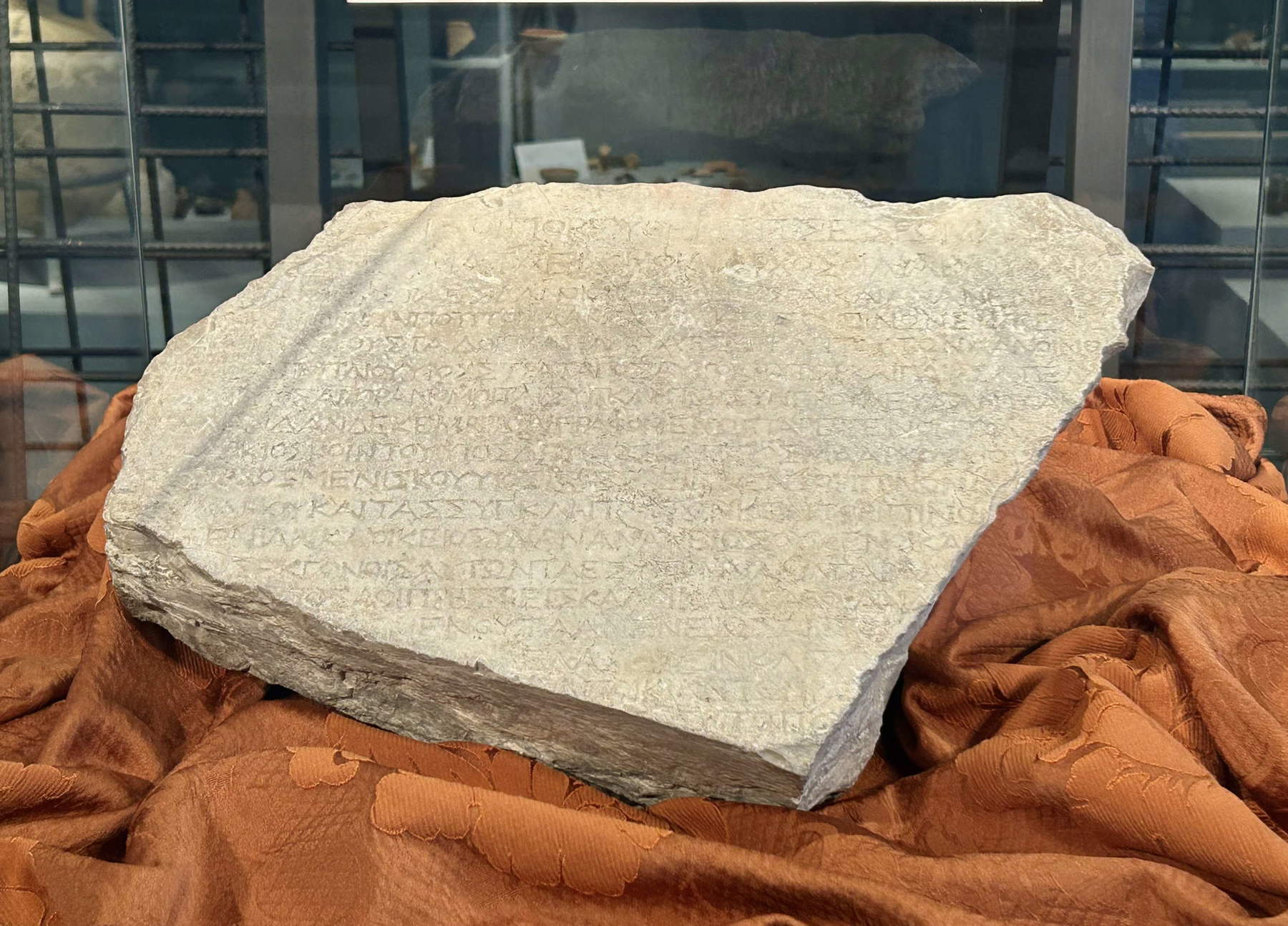

Altro pezzo di recente acquisizione, o meglio riacquisizione, è un’epigrafe rinvenuta sessant’anni fa da un tombarolo nella casa di una signora che la usava per schiacciare le olive. Una volta acquistata, l’uomo voleva rimetterla sul mercato, e per questo motivo fu sequestrata. Il testo, mutilo, dell’iscrizione ricorda un viaggio diplomatico di tre ambasciatori di Centuripe, prima a Roma e poi a Lanuvio, nel Lazio, per rinnovare un trattato di amicizia fondato sul rapporto di consanguineità. Il reperto è stato infine dissequestrato dopo cinquant’anni e testimonia quello che, con ogni probabilità, è il gemellaggio più antico tra città ancora esistente. Infatti, l’epigrafe è stata esposta anche a Lanuvio, e il rapporto tra le due città viene rinnovato ogni anno con una cerimonia.
Il museo conserva ancora numerosi reperti di sicuro interesse, tra statuaria e vasi, e anche due teche con un focus su due attività, certamente non meritorie, ma in passato profondamente radicate sul territorio: la pratica degli scavi clandestini e la redditizia produzione di falsi, portata avanti da vere e proprie dinastie di falsari, che oggi hanno riconvertito la propria attività in botteghe artigianali altamente specializzate.
Insomma, il Museo Archeologico di Centuripe è sicuramente una meta imperdibile per gli amanti dell’archeologia e dell’arte in generale, con una collezione ricchissima, che si caratterizza, in maniera piuttosto inconsueta rispetto ad altre istituzioni archeologiche, per la raccolta di reperti rinvenuti esclusivamente sul territorio. E sebbene persistano alcune debolezze nell’allestimento, in alcuni tratti piuttosto datato, e nel corredo esplicativo, con didascalie e pannelli non sempre all’altezza dell’esposizione, il grande lavoro svolto in questi ultimi anni per riportare pezzi importanti ed esporre altri che giacevano dimenticati nei depositi non è passato inosservato. Dall’inizio dell’anno fino a giugno si contavano già 2.000 visitatori, un risultato che fino a pochi anni fa sembrava impensabile, e che dimostra come la cura del patrimonio paghi sempre.

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi
Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio. Cresciuto giornalisticamente dentro Finestre sull'Arte, nel 2025 ha vinto il Premio Margutta54 come miglior giornalista d'arte under 40 in Italia.La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.