Lo Studio d’Arte Raffaelli, storica galleria d’arte contemporanea di Trento, ha da poco compiuto quarant’anni d’età: veniva fondata nel 1984 da Giordano Raffaelli, che ancor oggi guida la galleria diventata nel tempo un importante punto di riferimento per gli appassionati d’arte, soprattutto per l’arte africana, l’arte americana degli anni Ottanta e il figurativo italiano dalla Transavanguardia in poi. Focalizzato sulla pittura, con incursioni anche sulla fotografia e sulla scultura, lo Studio Raffaelli si è distinto negli anni per esser stato la prima galleria italiana ad aver organizzato una mostra di un artista africano, per aver lanciato in Italia gli artisti della New York degli anni Ottanta come Donald Baechler, Ross Bleckner, Philip Taaffe, Peter Schuyff e altri, per le sue lunghe collaborazioni con gli artisti africani, a cominciare da Zanele Muholi, lanciata in Italia proprio dalla galleria trentina. In occasione di questo importante traguardo abbiamo raggiunto Giordano Raffaelli per farci raccontare alcuni retroscena sulla storia della galleria, sulle sue ricerche, e anche per parlare brevemente dell’attuale situazione della giovane arte contemporanea italiana. L’intervista è di Federico Giannini.

FG. La sua galleria è stata aperta nel 1984, quindi ha da poco compiuto quarant’anni di attività. In realtà però sappiamo che Lei lavora nel settore dell’arte contemporanea da molto prima di quella data... vuole raccontarci i suoi esordi come mercante d’arte e come gallerista?
GR. Il primo input che ho avuto verso questo lavoro è stato quando ero ragazzino: mio padre conosceva un artista istriano che era sfollato qui nel Trentino dopo la guerra (Romano Conversano, un artista del gruppo di Migneco, Guttuso e dei figurativi della loro cerchia). Si erano conosciuti proprio qui in Trentino finita la guerra. Poi, negli anni Cinquanta, Conversano aveva comperato il castello di Peschici, in cima alla rocca, a picco sul mare: ci invitò più volte d’estate come suoi ospiti, e lì vedevo arrivare delle macchine da Milano con certi personaggi che prendevano i suoi quadri, contrattavano, poi li avvolgevano nelle coperte e ripartivano per Milano. Mi avevano affascinato le vicende di queste persone che si sobbarcavano due giorni di viaggio per prendere due o tre quadri e poi rientrare e venderli a Milano. Ecco, è lì che ho avuto il primo input verso il lavoro di mercante d’arte. Poi nel primo periodo della mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare un paio di personaggi importanti nel mondo dell’arte. Il primo è stato un collezionista, Carlo Cattelani, un contadino di Modena che viveva in un casolare in campagna e che ha ospitato a casa sua tantissimi artisti importanti acquistando le loro opere. È stato il primo a trattare Salvo, Gianmarco Montesano, Gino De Dominicis, Hermann Nitsch, tutto il gruppo di Fluxus e tanti altri. Con la fortuna di avere questa conoscenza e di entrare nelle sue simpatie sono riuscito a entrare nel giro che contava un po’, perché poi da Trento non era per niente facile. Il secondo è stato Luciano Pistoi, che ho conosciuto col tramite di Cattelani e col quale ho collaborato più volte negli anni per la sua manifestazione che faceva al Castello di Volpaia. Da lì è poi cominciata la storia della mia galleria.
Quali sono le principali linee di ricerca che hanno guidato la galleria in quegli anni e che la guidano adesso?
Una sola: quella della pittura. Una pittura con, magari, a volte qualche apertura di origine concettuale, però noi trattiamo pittura, anche quando cerchiamo i giovani. Capita che possa esserci anche la fotografia, però sempre dove c’è un’immagine pittorica. In fotografia, per esempio, abbiamo trattato per primi gli artisti africani degli anni Sessanta e Settanta, come Malick Sidibé, Seydou Keïta, Jane Alexander, e molti altri che praticavano quel tipo di fotografia dove non ci sono riferimenti alla pittura occidentale, ma c’è una ricerca sulle proprie tradizioni, sulle proprie origini.


Del resto, quando si ricostruisce la storia dello Studio Raffaelli, tutti sottolineano che Lei è stato il primo gallerista italiano ad aver organizzato una mostra di un artista africano: era, se non ricordo male, il 1991 e Lei aveva portato in Italia per la prima volta Chéri Samba. Oggi l’arte africana è diventata una sorta di moda, ma in quegli anni cosa significava lavorare con l’Africa e con gli artisti africani?
Non tutti se lo ricordano, prima del 1989, e in particolare prima della mostra Magiciens de la Terre fatta al Pompidou di Parigi, l’arte contemporanea era praticamente solo occidentale: non esisteva né arte cinese, né arte orientale, né arte africana di nessun tipo. Con l’esplosione di quella mostra, l’attenzione si è spostata anche verso altri continenti. Io ho preso la palla al balzo, ho conosciuto il mercante di Chéri Samba a Parigi e con lui ho organizzato la prima mostra, un po’ anche grazie alla spinta di mia moglie che era entusiasta di questo artista. Mostra che fu difficile, perché i quadri costavano già allora, e per i primi sei mesi non vendemmo niente, per cui dovetti comprare io tutti i quadri della mostra. Però poi ebbi comunque una grande soddisfazione, perché un museo canadese e un museo giapponese mi comprarono due quadri ciascuno, e a partire da quell’episodio la fortuna cominciò a ingranare.
Poi c’è un altro filone importante che è quello dell’arte americana, perché Lei ha lavorato e continua a lavorare con artisti importanti della New York degli anni Ottanta, come Baechler, Taaffe, Schuyff e molti altri. Che tipo di arte cercava e cerca tuttora la Sua galleria in America?
L’arte che sentivo di più. Che era l’arte dirompente in quegli anni, ovvero gli anni Ottanta. E poi un po’ tutti gli allievi di quel movimento... che poi non esisteva come movimento in sé, come, per esempio, una Transavanguardia. Esisteva però un sentimento comune che viaggiava nel mondo dell’arte, della letteratura, della musica a New York in quegli anni. Sfortunatamente non ho potuto contattare i due che poi sono diventati forse i più importanti, ovvero Keith Haring e Basquiat: ho sbagliato di un paio di anni, perché poi, in seguito, sono diventato molto amico di Annina Nosei, e con lei abbiamo poi collaborato più volte. Io compravo gli artisti suoi e facevo le mostre di artisti suoi, e lei seguiva le mie indicazioni, facendo delle mostre di Gianmarco Montesano, di Daniele Galliano e altri artisti italiani che trattavo al tempo. Poi ho lavorato anche con artisti che erano allievi di Donald Baechler, come Brian Belott, Taylor McKimens ed altri che conoscevano bene l’arte di quel periodo e seguivano quel tipo di sentimento rinnovandolo.
Nel catalogo di una mostra che la Sua galleria ospitò qualche anno fa (9 New York del 2018), in una conversazione con Alan Jones, Lei ha detto che il suo approccio nei riguardi di questi artisti è quello dell’editore che segue l’autore libro dopo libro. Quindi, in sostanza, Lei ha preso questi artisti che erano giovani e li ha seguiti fino all’affermazione, fino a che non sono diventati maestri, sostanzialmente.
Sì, e tengo a dire che li ho seguiti nella buona e nella cattiva sorte, perché anche nei momenti di difficoltà ho sempre sempre cercato di sostenerli, anche economicamente quando magari erano in difficoltà. Se mi innamoro di un artista, allora mi piace seguirlo per sempre.
E oggi non sono tanti i galleristi che ragionano così.
No, infatti tengo anche a dire che il più bel complimento che mi sia stato fatto da un artista, è stato dire che sono un “gallerista old style”. Mi ha fatto felice. Perché penso sia giusto così. Non siamo venditori di carne in scatola: vendiamo arte, quindi dobbiamo cercare di comportarci in un certo modo.




Lei oggi continua a cercare artisti giovani oppure preferisce seguire gli artisti che si sono affermati nel tempo assieme alla galleria?
Cerchiamo di seguire entrambe le linee: anche adesso stiamo partendo per New York e stiamo organizzando una mostra, per ottobre, di un giovane artista americano di 35 anni, Silas Borsos, non conosciuto in Italia. Sarà una mostra veramente interessante: è un artista di origine ungherese e fa dei piccoli quadri che rappresentano la realtà che si trova nelle strade di New York, nei teatri di New York, nei cinema di New York. Contemporaneamente verrà fatta una mostra del fratello Angus, che è un fotografo, e fotografa le stesse situazioni. È interessante sapere che il nonno era un importante pittore ungherese, molto famoso, che a un certo punto della carriera si trasformò da pittore in fotografo. Infatti ci sono delle fotografie sue che, per esempio, immortalano Franz Liszt che suona al piano e altre situazioni di questo genere. È interessante vedere come i due nipoti si siano dedicati uno all’arte pittorica e l’altro all’arte fotografica, e come questa famiglia che era coinvolta nel mondo nella cultura dell’Impero austro-ungarico vada avanti negli anni e con buoni risultati. Sarà una mostra molto bella, secondo me.
Dato che allora lo Studio Raffaelli continua anche a cercare di scoprire giovani nuovi, Le chiedo come si riconosce secondo Lei un artista, un giovane di talento. Poiché, diceva, Lei s’innamora degli artisti, qual è la scintilla che fa scattare questo innamoramento?
Per me è l’istinto. Per altri può essere lo studio, la ricerca... per me, ripeto, è l’istinto: mi bastano pochi secondi quando vedo un artista per la prima volta. E se in quei cinque secondi scatta qualcosa bene, altrimenti è difficile che fra due mesi, rivedendo le stesse cose, io mi innamori.
Un approccio emotivo dunque.
Sì. Solamente emotivo. Senz’altro.
Prima abbiamo citato Annina Nosei e la Vostra collaborazione: ecco, quando Annina Nosei portava in America la Transavanguardia, Lei invece portava in Italia gli artisti americani. Come lavoravate insieme?
Quando io andavo a New York andavo a scoprire le ultime mostre che aveva fatto, mi faceva vedere anche le cose rimaste in magazzino dalle mostre precedenti, e se un artista mi piaceva, allora organizzavamo la mostra da me. Abbiamo fatto per esempio una mostra di Jenny Watson, che nel 1993 ebbe l’intero Padiglione dell’Australia alla Biennale di Venezia: con lei Annina Nosei aveva fatto più mostre. Dopodiché io proponevo a lei qualche artista italiano che pensavo potesse interessarle. Ricordo sempre il viaggio che ho fatto con Montesano d’estate ad Ansedonia nella casa di Annina Nosei, e quando gliel’ho presentato lei è rimasta entusiasta, infatti poi ha fatto due mostre sue. Era una collaborazione di conoscenze che ci scambiavamo per fare cose nuove, per inventare cose nuove e promuovere artisti nuovi.
Parliamo naturalmente di trenta, quarant’anni fa. Oggi invece c’è ancora, secondo Lei, questo rapporto di scambio tra galleristi italiani e galleristi americani oppure è andato perdendosi nel tempo?
È andato perdendosi, senz’altro, perché con le grandi gallerie oggi è impossibile parlare, avere un rapporto personale. Io conoscevo bene Barbara Gladstone che però è mancata un anno fa. Con i galleristi della nuova generazione è difficile dialogare perché adesso negli Stati Uniti vige altro un altro sistema di lavoro. Vige un altro sistema di vita. Quindi è più complicato. Però proprio di recente mi sono ripromesso, anche con mia figlia Virginia che adesso collabora con me in galleria, di riallacciare i rapporti con alcune gallerie, per cercare magari di promuovere i nostri artisti negli Stati Uniti e di promuovere i loro artisti da noi. Per un periodo forse ho un po’ lasciato perdere anch’io ma, come dicevo, mi sono ripromesso di riprovarci, anche se non è facile, perché ci sono altre dinamiche rispetto a un tempo.
E che cosa è cambiato in peggio rispetto agli anni Ottanta?
Abbiamo a che fare con delle multinazionali: mi riferisco alle grandi gallerie che fanno un po’ il bello e il cattivo tempo nel mondo dell’arte. Mettersi a lavorare con loro è praticamente impossibile. È difficile riuscire anche soltanto a contattarli.
Quindi, naturalmente, questa situazione ha provocato anche dei danni all’arte italiana, nel senso che l’arte italiana oggi non riesce più ad affermarsi in America come riusciva invece un tempo.
Sì, anche perché per affermarsi in America bisogna vivere lì. Non c’è niente da fare. E qua in Italia non è che ci siano molti artisti giovani che abbiano voglia di sbattersi più di tanto. Ci vuole grinta per farsi strada in una città dove ci sono magari diecimila artisti e duemila gallerie, e non è semplice. Ci vuole veramente una forza enorme e non sono tanti al momento, secondo me, gli artisti che riescono ad averla.
Comunque, a proposito di artisti italiani, Lei ne ha diversi che lavorano con lo Studio Raffaelli. Si è chiusa da poche ore la mostra di Willy Verginer, per esempio, però la Sua galleria lavora anche con artisti più giovani. Sulla base di che cosa Lei sceglie gli artisti italiani? E secondo Lei oggi come è messa l’arte italiana?
Sugli artisti italiani lavora soprattutto mio figlio Davide, che collabora con parecchi artisti giovani italiani. Ce ne sono tanti bravi, ma secondo me manca quello che ha lo spunto, quello che può arrivare fino in fondo. In Italia oggi ci sono tanti artisti bravi, ma manca il campione. Vale per tanti altri campi, nello sport per esempio, dove c’è una media molto alta di ottimi atleti, ma si sente la mancanza di un grande campione. L’unica eccezione forse è il nostro Jannik Sinner, l’unico che può essere paragonato ai campioni di una volta. Anche nella pittura in Italia ci sono tanti bravi autori, tanti bravi pittori, però manca quello che ha lo scatto in più. Ma forse è così il mondo d’oggi. Anche nella musica mi riesce difficile pensare ai Beatles di oggi o ai Rolling Stones di oggi.
Ha citato Suo figlio, Davide, che in collaborazione con Camilla Nacci Zanetti ha aperto la galleria Cellar Contemporary che promuove, appunto, il lavoro di giovani italiani e internazionali. E naturalmente collabora con Lei. Com’è lavorare con suo figlio?
Mi trovo bene. Con entrambi i miei figli ho un ottimo rapporto di collaborazione. Ci sono poi naturalmente lotte e discussioni, però adesso Davide gestisce la sua galleria da quasi otto anni e collaboriamo sempre bene assieme, il rapporto tra le due gallerie è molto aperto e molto collaborativo. Di recente, per esempio, ha partecipato a una fiera in Sudafrica con la sua galleria, però portando anche alcune delle cose nostre.
Su che cosa avete le discussioni più accese?
Non sulla scelta degli artisti: su questo punto siamo quasi sempre d’accordo. Ugualmente sulle scelte lavorative. Ci troviamo invece a discutere sulle... piccole cose quotidiane.


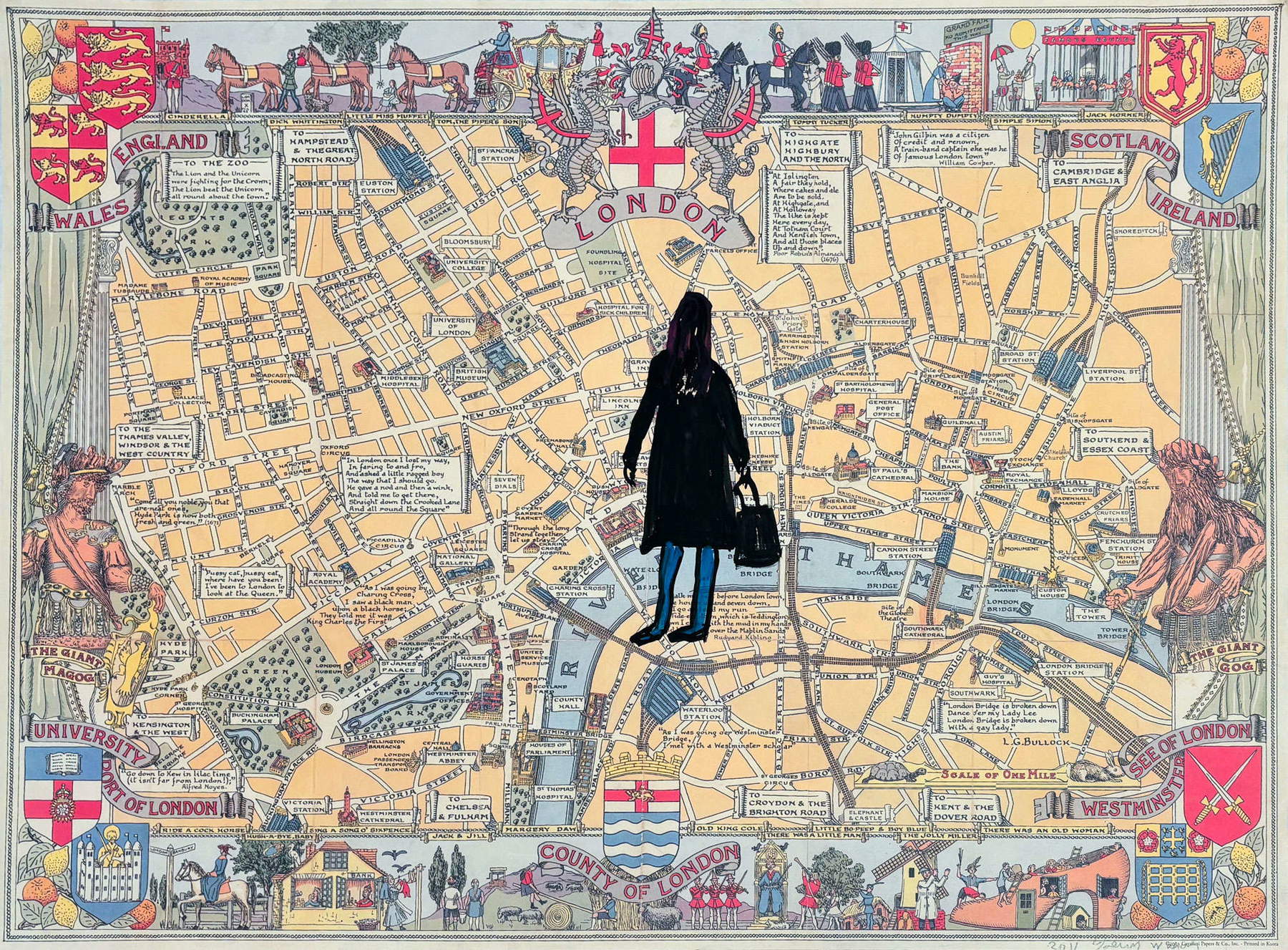
Tornando a quello che Lei diceva all’inizio, ovvero che lo Studio Raffaelli ha sempre lavorato con la pittura: ne consegue che Lei non guarda a forme d’arte come le grandi installazioni, la videoarte e via dicendo. Ecco, perché questa scelta di concentrarsi soltanto sulla pittura e sulla scultura?
Perché ciò che mi dà emozione è soprattutto la pittura. E poi la pittura è la forma d’arte che credo di capire meglio. Solo questo. Poi ritengo anche che un gallerista non possa diventare tuttologo e fare tutto. Io ho cercato di specializzarmi in questo campo il meglio possibile e sono andato avanti così. Con qualche incursione anche sulla fotografia, ma solo sulla fotografia di un certo tipo.
E poi, voglio dire: è un campo che Le ha dato tantissime soddisfazioni...
Sì, certo. Anche sulla pittura africana ci sarebbe veramente da aprire un capitolo. E non parliamo poi della fotografia africana, vale la stessa cosa, perché i fotografi di studio degli anni Sessanta-Ottanta erano tantissimi, non c’erano solo Malick Sidibé, Bob Bobson o Seydou Keïta, ce n’erano tanti altri, ma servirebbe una galleria che faccia solo questo tipo di lavoro. E troverebbe delle cose bellissime: penso per esempio a Sanlé Sory, a tanti fotografi che nessuno qui da noi conosce, e che sono veramente molto bravi.
È stato facile proporre all’epoca al pubblico italiano, ai collezionisti italiani, ai compratori italiani questo tipo di arte, oppure non è stato immediato?
Posso dire che la risposta in alcuni casi è stata eclatante: quando abbiamo fatto la prima mostra di Bob Bobson, fotografo di studio, l’unico poi che ha fatto foto a colori (lo presentammo a un’edizione di Miart), ottenemmo uno straordinario riscontro di stampa, senza che per altro ci fossimo mossi in alcun modo. Direi il riscontro di stampa più ampio mai avuto nella nostra carriera. E poi anche un riscontro di un pubblico di alto livello molto importante. Anche quando abbiamo fatto, nei primi anni Duemila, la mostra di Zanele Muholi (la prima mostra in Italia), lei era un’artista assolutamente sconosciuta, però anche in quel caso abbiamo avuto un discreto riscontro. Anche qua in provincia, da parte dei collezionisti di Trento. Collezionisti di Trento che poi in seguito, peraltro, hanno avuto anche delle soddisfazioni dal punto di vista economico, perché le quotazioni di Zanele Muholi, rispetto a quella prima mostra che facemmo in occasione dell’edizione di Manifesta che si tenne quell’anno qui a Trento, oggi sono decuplicate.
Oggi invece Zanele Muholi la conoscono tutti. È insomma Lei che l’ha portata in Italia e l’ha fatta conoscere.
Sì, fui il primo a fare una mostra in Italia di Zanele Muholi: era una piccola mostra con venti fotografie di Zanele Muholi, che all’epoca nessuno conosceva. Potei farla avendo frequentato molto il Sudafrica: avevo visto i suoi lavori nella galleria che la trattava a Città del Campo, e comprai quella ventina di foto con le quali poi facemmo la mostra. Fu anche un rischio.
A tal proposito, visto che mi apre l’argomento: la Sua propensione al rischio negli anni è aumentata, è rimasta stabile, è diminuita? E poi, secondo Lei i galleristi oggi sono ancora così propensi al rischio come poteva esserlo Lei all’epoca?
Devo dire in realtà di non essere stato uno che ha rischiato moltissimo: ci sono galleristi della mia età e della mia generazione che hanno davvero fatto i salti mortali e si sono presi dei rischi enormi. Oggi non ne vedo tanti, cercano un po’ tutti di andare sul sicuro, di vivacchiare. Nei galleristi delle nuove generazioni non vedo la grossa personalità: vedo tanti ottimi galleristi ma che lavorano in modo omogeneo, ognuno che porta avanti i suoi cinque o sei artisti. Non saprei come dire: diciamo che oggi non vedo un gallerista come Sperone, ecco. È un po’ come abbiamo detto prima per gli artisti. Sia per gli artisti sia per i galleristi siamo arrivati a un livellamento della qualità, che quantitativamente è molto più alta, nel senso che ci sono molti più artisti e galleristi bravi rispetto a un tempo, ma dal punto di vista qualitativo mancano figure di spicco. È quello che ho potuto constatare anche nelle varie fiere, dove si fa fatica a vedere qualche artista giovane veramente interessante.
Per concludere: una delle singolarità della Sua galleria risiede nel fatto che Lei invita spesso gli artisti a soggiornare in Trentino. Quasi tutti gli artisti che collaborano con Lei sono passati proprio fisicamente da Trento. Perché ritiene importante questo contatto degli artisti col territorio in cui Lei lavora?
Intanto perché così, alle volte, possono anche ispirarsi a qualche tema che possono sviluppare solamente rimanendo qua per qualche tempo, oppure possono assimilare degli aspetti della città e del territorio che poi possono portare nei loro lavori. Ricordo una delle prime mostre di Ontani, Trentazioni era il titolo: realizzò una serie di quadri ispirati alla situazione geografica, alle montagne, a tutto ciò che poteva trovare qua. L’ultima in ordine di tempo è stata Melissa Brown, che è arrivata qua un anno fa, ha visitato il Castello del Buonconsiglio, ha focalizzato alcuni oggetti che poi li ha serigrafati sui fondi dei suoi dipinti. Quindi penso sia interessante far lavorare gli artisti a Trento, essendo una città anche interessante dal punto di vista storico e artistico. È interessante farli vivere un periodo qua e in seguito stabilire un rapporto che si può esplicitare anche in un rapporto che è quotidiano per almeno un determinato periodo, e poi rimane tale per sempre. Parlo di rapporto umano e rapporto artistico.
E immagino che gli artisti saranno entusiasti di lavorare a Trento quando arrivano!
Sì, specialmente gli americani, ma anche gli artisti italiani sono sempre stati contenti. E si sentono un po’ come in famiglia. Ce lo hanno detto loro. Più volte hanno detto proprio: “Ci sembra di essere in famiglia”. Lavoriamo davvero bene, insomma. Così si cerca di stabilire un rapporto di amicizia che poi può durare nel tempo. Certo, può anche interrompersi per anni, ma rimane sempre una conoscenza abbastanza approfondita che non si può dimenticare.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.