Il Museo Galileo di Firenze, fondato il 7 maggio 1925 come Istituto di Storia delle Scienze, quest’anno compie cent’anni, e in occasione del centenario sono diverse le iniziative in programma. Ne approfittiamo per parlare con il direttore Roberto Ferrari (Taormina, 1981), che dal 2021 guida l’istituto nel ruolo di direttore esecutivo. A cosa serve oggi un museo? In che modo può essere un punto di riferimento nel dibattito? Come può aiutare i giovani? Perché è importante che i musei investano in ricerca? Di questi temi parliamo con il direttore in questa intervista di Federico Giannini. Con alcuni esempi di come lavora il Museo Galileo.

FG. Quest’anno si celebra il centenario del Museo Galileo, e tra gli obiettivi che l’istituto si dà ce n’è uno a mio avviso molto interessante e molto ambizioso: valorizzare la posizione di Firenze nella storia della scienza. Significa, del resto, anche lavorare sulla percezione del pubblico. Come intendete lavorare per raggiungere questo obiettivo, questa ricollocazione di Firenze nella storia della scienza?
RF. Questo è uno sforzo che nasce quando già Andrea Corsini dal 1922 coltiva il proposito di dare valore alla storia della scienza attraverso gli strumenti che avevano cessato la loro vita utile e che però potevano continuare, a suo dire, a ispirare il lavoro degli storici e degli scienziati, costituendo anche un ponte tra i due saperi. Oggi noi siamo impegnati su questa missione in vari modi. Uno è quello di far comprendere quanto anche della cultura artistica fiorentina, che è ovviamente molto più conosciuta della cultura scientifica della città, deve alle idee, ai personaggi e alle invenzioni della storia della scienza. È impensabile apprezzare la cupola del Brunelleschi senza interrogarsi sull’apparato di conoscenze tecnico-scientifiche che vi stava dietro, così come è impensabile apprezzare e comprendere l’opera di Galileo senza riconoscere che in Galileo convivono la figura di scienziato e quella di letterato (come dirà Calvino in un famoso articolo del 1967) e anche quella di abile disegnatore: come scrive in quella bella poesia a lui dedicata Primo Levi, Galileo era “uomo dotto ma di mani sagaci”. Trovo effettivamente molto affascinante la sfida di provare a ricollegare quei legami che si sono spezzati nella specializzazione disciplinare che, soprattutto tra Settecento e Ottocento, ha costituito la linea di tendenza generale. Il nostro lavoro quindi è, da una parte, quello di riunire e ricongiungere queste diverse traiettorie e far vedere come opere spesso ascritte all’una o all’altra parte in verità sono il frutto di un lavoro che ha messo insieme diverse forme di sapere, e dall’altra anche rendere noto il contributo che la città, e poi la Toscana e tutto il paese, hanno dato alla storia della scienza, al di fuori ovviamente di questioni d’identità nazionale: si tratta di un contributo molto importante che certamente fino all’epoca galileiana è stato riconosciuto universalmente. Uno degli aspetti più affascinanti che cerchiamo sempre di mettere in luce, anche se questo richiederebbe poi anche altre competenze, è quanto la cultura scientifica abbia ispirato anche il buon governo, cioè quanto stretta fosse la vicinanza tra mondo scientifico e mondo politico. Da anni si parla di evidence-based policy, cioè di politiche fondate sulla conoscenza e sull’evidenza. È una cosa che non è priva di rischi quando si ritiene che la scienza dia tutte le risposte che servono. Non è così, e la storia della scienza aiuta a vedere nella giusta luce anche i contributi scientifici stessi, che si basano sulla fallibilità e sul fatto che ovviamente qualunque scienziato deve riconoscere anche i limiti delle proprie ipotesi, come per un certo verso Galileo ci ha insegnato a fare.
Per affrontare questo tipo di lavoro, che richiede un approccio direi multidisciplinare, e quindi mette insieme varie competenze, non si può lavorare soltanto sul piano fisico, ma serve anche passare al digitale. Come allora secondo Lei deve un museo lavorare sul digitale?
La consapevolezza del potenziale degli strumenti informativi al servizio del museo nasce qui con la direzione di Paolo Galluzzi, che già alla metà degli anni Ottanta decide di dare vita ad un laboratorio multimediale. Il laboratorio aveva l’ambizione, con i mezzi di allora, di lavorare sui due fronti principali della digitalizzazione, che ancora oggi costituiscono per noi una missione costante. Il primo è lo studio delle fonti: vanno in questa direzione lo sviluppo delle teche, la prima delle quali fu la Galileoteca, quindi ambienti costruiti per la ricerca, dove è possibile individuare tutti i materiali utili, e che siano rivolti anche però ad un pubblico di non addetti ai lavori. Su questa linea si sono sviluppate poi anche le edizioni digitali di testi antichi e di mappe antiche, come quella del planisfero di Martin Waldseemüller. Si tratta quindi di rendere accessibili, comprensibili ed apprezzabili gli oggetti anche nell’ambiente digitale e soprattutto utilizzare il digitale non per gli effetti speciali, ma per migliorare le vie della ricerca e della conoscenza. Il secondo fronte è quello che riguarda gli strumenti: tutta la strumentaria scientifica fin dagli anni Ottanta è stata oggetto di una continua analisi tesa a comprendere come forme nuove di visualizzazione potessero aiutare questo fronte di attività, che possiamo denominare di filologia delle macchine e che ha ovviamente l’ambizione di studiare continuamente gli strumenti scientifici con l’obiettivo di esplorarne sempre in modi più accurati le funzioni, il contesto culturale, i rapporti questa ideale catena che lega le invenzioni di strumenti scientifici, tutt’altro che lineare. In questo caso il digitale significa, per esempio, la modellazione 3D e la ricreazione di ambienti digitali dentro cui collocare gli oggetti digitali: un caso recentissimo è stata la creazione di un gemello digitale (sebbene sia un termine improprio) della Sala della Guardaroba di Palazzo Vecchio. Nell’ambito di un progetto con il Comune di Firenze e Friends of Florence, abbiamo poi realizzato, con il nostro laboratorio multimediale, anche la riproduzione digitale del globo di Ignazio Danti che quindi è esplorabile senza ovviamente mettere in difficoltà e sottoporre a stress l’originale (ed è stato possibile in questa ricostruzione portare in evidenza anche quegli elementi progettuali del Vasari che non possono più essere visti, come gli effetti scenotecnici dell’uscita dei globi dal soffitto, o, come si immaginava, il venir fuori dagli armadi dell’orologio dei pianeti). L’idea è comunque quella di creare strumenti che siano anche facilmente utilizzabili.
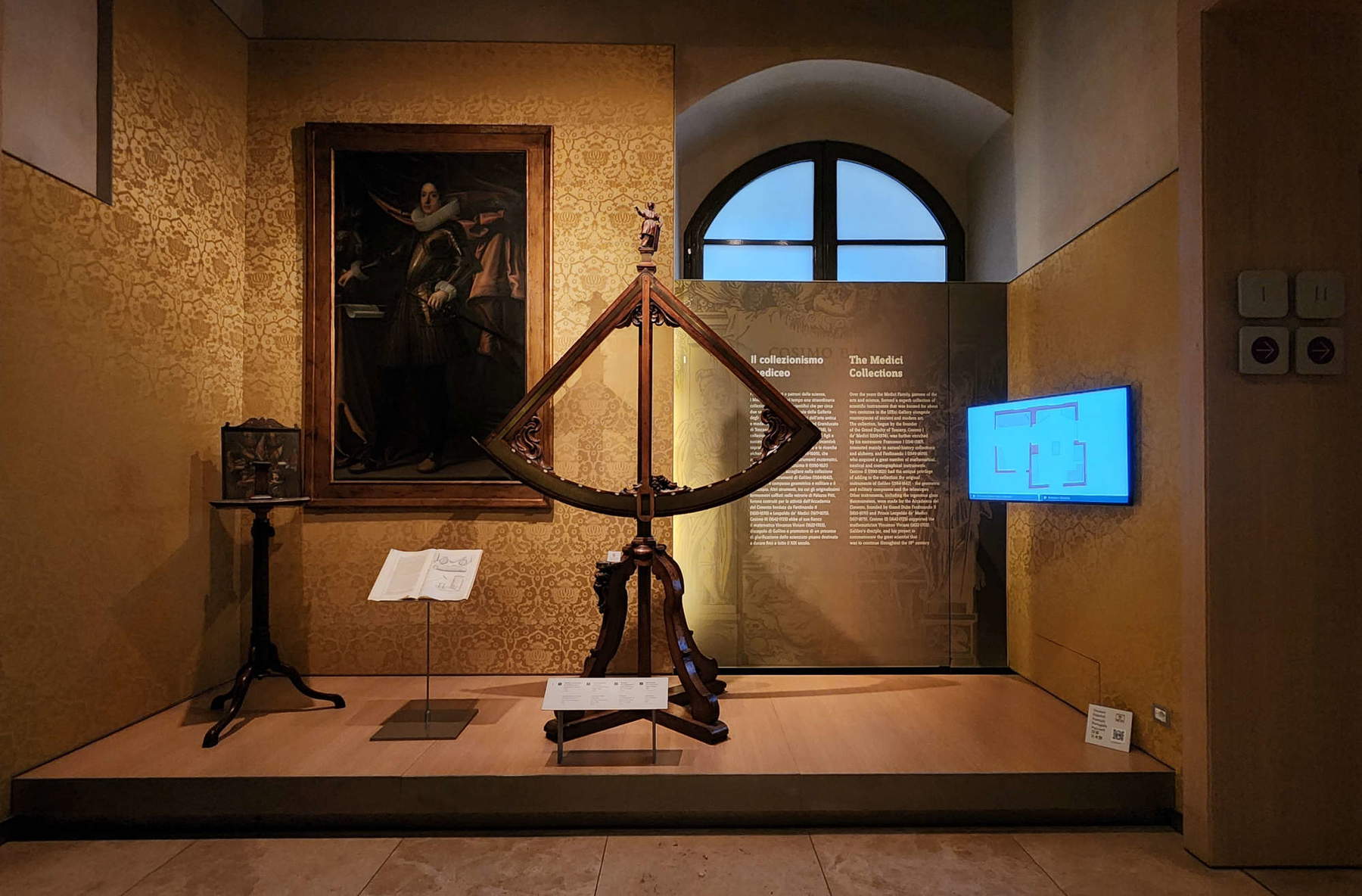



Parliamo allora di ricerca, ambito in cui il Museo Galileo interviene con diverse attività, l’ultima delle quali è un progetto di realtà virtuale, disponibile quotidianamente al pubblico nelle sale del museo tramite visori che tutti possono indossare, realizzato con uno spin-off della Normale di Pisa. Al di là di questo, tuttavia, mi interesserebbe sapere come il museo si approccia alla ricerca, che rapporti ha con le università e poi, dal momento che il museo è inserito all’interno di un sistema, se i musei fanno abbastanza in questo senso, ovvero se hanno dei rapporti abbastanza solidi con tutto il mondo accademico e se davvero la ricerca è ancora un obiettivo dei musei oppure se, negli ultimi tempi, è stata un po’ lasciata da parte per concentrarsi invece su altri obiettivi, magari di più immediato conseguimento e anche di più immediato effetto...
Mi verrebbe da dire che se oggi oltre 200.000 persone all’anno entrano in un museo di strumenti scientifici, a volte di difficilissima lettura, lo si deve al fatto che questi oggetti hanno trovato una voce in chi li ha studiati, cioè in chi ha dedicato parte della vita professionale di studioso per far comprendere che in quegli oggetti apparentemente inutili, ricordo di vecchi tempi, si nascondesse invece una storia che ancora merita di essere raccontata, e quindi che in qualche modo questi oggetti fungessero da classici che continuano ad avere un loro valore anche nell’orientarci nelle domande che oggi ci poniamo. Se devo sintetizzare il contributo della ricerca, lo vedo anche in questa sua capacità di dare forma a qualcosa che non c’era prima, perché gli oggetti sono muti o, per riprendere una celebre definizione di Argan del 1975, non sono beni culturali, ma sono oggetti di conoscenza, oggetti di ricerca scientifica, e lo sono nella misura in cui qualcuno è messo in condizioni di fare ricerca, che è un vero tema. Noi facciamo ricerca con studiosi in residenza, dipendenti del museo, ma collaboriamo anche con studiosi esterni. Il museo ha una fitta rete di collaborazioni, oltre 100 accordi tra università e istituti culturali che ci permettono, ovviamente, anche di coprire quelle aree che non copriamo con gli studiosi interni, e ci permettono anche di andare nella direzione di quei lavori necessariamente interdisciplinari che richiedono spesso il coinvolgimento di figure specialistiche. Tra le ragioni che inibiscono credo, in generale, l’impegno nella ricerca dei musei italiani c’è la difficoltà della gran parte dei musei di avere un orizzonte di risorse, e quindi anche di programmazione, che permetta di coprire le esigenze necessarie, e quindi di potersi avvalere di studiosi che si impegnino nello studio delle collezioni. Mi pare però di poter dire che c’è sempre minore attenzione da parte degli enti che sono costituzionalmente impegnati nella conservazione e nello sviluppo dei musei, come il Ministero o le regioni, che dovrebbero essere coinvolte in questo progetto, anche sfruttando la piattaforma ideale del Sistema Museale Nazionale, e purtroppo in questo senso non possiamo non registrare alcuni segnali, a cominciare dal venir meno della Direzione generale Educazione e Ricerca che con la recente riforma è stata de facto abrogata, e con anche il limite che sembra sia un po’ tramontata la stagione del collegamento tra i due ministeri che pure hanno sperimentato negli anni passati dei tavoli di lavoro congiunti (mi riferisco al Ministero della Cultura, come si chiama oggi, e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora diviso in due ministeri diversi). Quindi purtroppo c’è, oltre ad un limite fisiologico che deriva dalla debolezza strutturale dei musei, anche secondo me il fatto che i musei sempre meno sono stati stimolati a fare ricerca. E questo ovviamente è un tema serio. E poi ovviamente sta anche alle scelte anche di chi dirige l’istituto.
E questo è un tema politico.
Certo. Credo che il fatto di avere spesso incarichi a breve termine dei direttori dei musei possa indurre anche i direttori più bravi a puntare a iniziative di corto respiro perché producono i loro effetti in due o tre anni. La ricerca non lo fa: ovviamente, purtroppo o per fortuna, ha tempi più lunghi.



Prima ha fatto un accenno al Sistema Museale Nazionale, e mi piacerebbe conoscere uno Suo parere su come oggi sta funzionando: se questo sistema che racchiude i musei italiani potrebbe essere migliorato, se va tutto bene, cosa si potrebbe fare...
Diciamo che la gestazione del Sistema Museale Nazionale, così come immaginato dal decreto ministeriale 113 del 2018, è stata molto faticosa per varie ragioni, non ultimo il fatto che si sia speso molto tempo perfino sulla individuazione di quei requisiti minimi che pure erano chiaramente espressi dal decreto e che dovevano costituire una condizione necessaria per ammettere all’accreditamento i musei che venivano valutati. Questo secondo me ha determinato un ritardo che solo in parte è stato recuperato, e solo su una linea di lavoro, che è stata quella della messa a sistema attraverso l’applicazione Musei Italiani. Quella è una linea che ha avuto un suo sviluppo che vediamo, perché è una piattaforma sulla quale sempre più musei sono presenti e che ha cominciato anche ad erogare servizi, quindi a permettere addirittura la vendita di biglietti, e questo non può che essere un dato positivo. Rimane però un enorme impegno da assumere su quella che era forse la promessa principale del Sistema Museale Nazionale, cioè essere un sistema capace di valutare, e quindi con il coraggio di poter dire sì e no. E questo è un coraggio che deve maturare come cultura all’interno degli uffici che poi dànno forma a quell’impegno. Per arrivare a essere un sistema competitivo e cooperativo c’è un punto che mi pare ancora mancante, purtroppo: agganciare i sistemi di programmazione delle risorse (e quindi dei finanziamenti ai musei) al sistema museale, cioè al sistema di accreditamento che è incardinato nel Sistema Museale Nazionale. Fino a quando ci sarà uno scollamento, o addirittura una contraddizione tra le regole di finanziamento dei musei e il Sistema Museale Nazionale, non si andrà purtroppo da nessuna parte: chi dà i soldi ai musei, ovvero Stato e regioni, deve davvero credere nel valore del Sistema Museale Nazionale e deve quindi ancorare i criteri di finanziamento al rispetto dei criteri stessi e dunque, intanto, dei requisiti minimi, e poi dei livelli di qualità, come si chiamano nella denominazione del decreto. Però la sostanza di tutto questo è che i musei dovrebbero essere affiancati in un percorso che li veda crescere. Senza un collegamento forte tra i sistemi di programmazione delle risorse e il Sistema Museale Nazionale mancheremo la promessa fondamentale che ci portiamo dietro fin dall’atto d’indirizzo del 2001.
Insistendo sul tema della gestione dei musei: mi piacerebbe fare un affondo su un tema particolare, quello delle qualità del direttore di un museo. C’è stato in questi anni recenti, e ogni tanto riemerge, un accalorato dibattito, uno dei più animati, sulle caratteristiche che deve avere un un direttore di un museo. Poiché il Museo Galileo, anche dal punto di vista della governance, ha un assetto particolare, vorrei chiederLe se questo dibattito che contrappone i “manager”, chiamiamoli così, alle figure tecniche, a Suo avviso è un dibattito ozioso, oppure è utile: Lei che posizione ha su questo tema?
Penso che sia un dibattito che merita di essere portato avanti, e portato avanti in maniera tale da valorizzare anche tutta quella conoscenza che sta nella prassi e sta nella letteratura che su questi temi esiste. Quindi sarebbe un peccato sprecarlo in una sorta di dibattito di prese di posizione ideologiche. Penso che ci sia, intanto, da fare una distinzione fondamentale tra i musei che sono chiamati, da statuto e da configurazione, a trovare dei fondi perché sennò non sopravvivono, rispetto a quelli pubblici che invece i fondi li hanno o li dovrebbero avere, e che quindi richiedono certamente di avere un’attenzione all’uso dei fondi, soprattutto quando si tratta di fondi pubblici, ma è chiaro che servono figure che sono in grado di reperire fondi e quindi di interrogarsi anche su come un museo può ottenere dei fondi esterni. Spendere bene i soldi pubblici è una cosa molto complessa, ma ancor più complesso è spendere bene i soldi e trovarli. I musei davvero autonomi, quelli che a fine anno devono assolutamente arrivare a pareggio, devono farlo a qualunque condizione, perché altrimenti si creano le condizioni per una crisi che ne produce, a medio andare, un’estinzione. Poi ovviamente le esigenze possono essere risolte con vari tipi di assetti organizzativi. Io sono dell’idea che debbano esserci diverse competenze all’interno di ogni museo. Non sono così convinto che la direzione affidata ad una figura che è uno specialista della collezione o della materia risolva sempre tutti i temi, a meno che non si tratti di piccole collezioni che possono essere dominate da una persona sola. Lo vedo nel caso nostro: pure essendoci una figura di una direzione scientifica competente, questa figura è competente soprattutto su una parte della collezione, quindi avere una comunità di studiosi è condizione fondamentale. Credo tuttavia che l’aspetto forse più critico della risposta che tento di dare, è che purtroppo tutta la disciplina che è venuta formandosi negli ultimi trent’anni della cosiddetta economia e management e della cultura ha deluso le aspettative. Io credo che buona parte della polemica e dell’inquinamento del dibattito derivi dal fatto che il management della cultura, a mio avviso, vive di formule astratte e vive in una sorta di campana di vetro astorica. Nella mia esperienza, ho capito che gli strumenti che si presume possano essere applicati al settore della cultura (dall’organizzazione, dal management, dall’economia d’azienda e così via), sono spesso applicati in modo acritico e con risultati pessimi, e quindi penso che lo studio delle collezioni, lo studio delle relazioni culturali che legano una collezione all’istituto e l’istituto al suo contesto siano un prerequisito fondamentale per costruire una visione manageriale delle istituzioni culturali, che invece di solito stata purtroppo ne è priva. Mi riferisco all’aver immaginato che il management sia solo la ricerca fondi, sia solo un problema contabile o che sia solo parlare di piani strategici, spesso scritti a vanvera e fatti anche da istituzioni che non erano in grado neanche di assicurare il pareggio di bilancio, ma guardavano ad un mondo ideale senza un metodo, senza un’attenta ricerca delle fonti. Penso che purtroppo il dibattito si sia inquinato per un limite della comunità a cui anche io faccio riferimento: se i musei devono essere centri di ricerca che hanno anche l’ambizione di trasformare le persone che entrano in quel luogo, allora non basta la logica di mercato. Se invece noi immaginiamo che il museo sia soltanto un contenitore di oggetti in cerca di pubblico, basta metterci su un’azienda. Come in effetti succede, perché basta vedere il modo in cui impropriamente viene spesso usato dato il termine museo, e questo mi preoccupa più del dibattito sulla natura dei direttori. Si tratta di competenze che servono tutte, a condizione che ci si parli, che ci si capisca, perché non esiste una buona organizzazione che non si sia formata attorno ai progetti, ai progetti di ricerca, ai progetti di conoscenza che il museo porta avanti, e non esiste un buon progetto di ricerca e conoscenza che non faccia i conti con le caratteristiche e i vincoli organizzativi ed economici di ogni museo.
Parliamo invece del pubblico del museo. Il Museo Galileo supera ogni anno i 200.000 visitatori, e sono numeri importanti per un museo dedicato alla storia della scienza. A me piacerebbe sapere chi è il vostro pubblico, ovvero quanti sono i turisti, se c’è una prevalenza di giovani, di meno giovani, insomma, come sono composti i flussi che danno vita a questi oltre 200.000 visitatori che ogni anno vengono a trovarvi.
Noi abbiamo due fonti informative: una sono i dati che ci derivano dai canali di vendita, e l’altra i questionari che somministriamo con, ovviamente, il limite che il questionario ti dà una rappresentazione, anche molto accurata, dei soli rispondenti, quindi sono evidentemente una parte della popolazione statistica. Da queste due fonti noi abbiamo desunto che il 60% circa dei nostri visitatori sono turisti che sono qui a Firenze per fare fondamentalmente un giro della città, e un 40% è dato invece dai cittadini. E sono perlopiù fiorentini, toscani. Abbiamo un pubblico che è fatto prevalentemente di americani, il che ovviamente pone un tema di multilinguismo: il museo è organizzato per offrire tutto l’apparato comunicativo (il sito web, le app, tutti i prodotti multimediali) almeno in italiano e in inglese. Ed emerge inoltre dai questionari che il pubblico del museo è fatto da persone di una fascia d’età compresa tra i 28 e i 45 anni. Questa è la fascia più presente. Sappiamo poi dal questionario che vengono in coppia: una curiosità che francamente stupisce anche me, però è stabile tutti gli anni, è che la fetta di pubblico più numerosa è fatta di trentacinquenni che vengono in coppia, quindi il Museo Galileo è una sorta di museo dell’amore... ! Ovviamente abbiamo una grossa fetta di pubblico scolastico perché abbiamo un gruppo di educazione didattica interno, con il quale si realizzano circa 1.500 laboratori all’anno e la parte di gruppi organizzati è di poco più del 20% (intorno ai 25.000 visitatori che vengono con i gruppi, con le visite con esperienze, come le chiamiamo qui, e le visite guidate).
Parlando del pubblico italiano, e in particolare del pubblico giovane. In Italia c’è una certa ritrosia nei riguardi delle materie scientifiche. Siamo abbondantemente sotto la media europea dei laureati in materie STEM (secondo dati Eurostat), ed è peraltro è un settore che sconta un forte divario di genere perché le laureate nel settore sono grosso modo la metà rispetto ai maschi, secondo i dati Istat che rilevano una quota del 16,6% delle donne (nella fascia degli italiani tra i 25 e i 34 anni con titolo terziario) che ha una laurea STEM contro il 34% dei maschi, situazione che si riflette poi anche in ambito occupazionale. E tutto questo nonostante i test INVALSI certifichino che i nostri studenti più giovani (scuole medie, scuole superiori) abbiano competenze che in realtà sono più o meno in linea con quelle dei loro coetanei europei. Faccio allora un paio di domande: riscontrate con la vostra attività quotidiana una sorta di differenza di approccio oppure di interesse tra gli adulti da una parte e i giovani e i giovanissimi dall’altra? E un museo come il vostro ha gli strumenti per intervenire su uno scenario come quello che ho sommariamente descritto?
È un tema importantissimo perché ovviamente le discipline scientifiche sono anche quelle a cui più si associa la capacità di un paese di non subire gli sviluppi tecnologici, ma guidarli. Noi siamo convinti, intanto, che dentro il grande mondo delle discipline scientifiche continui ad essere necessario sostenere la ricerca di base che, come è stato dimostrato in molti casi, è fondamentale proprio per permettere di unire anche quella parte della scienza che alimenta poi qualunque sviluppo applicativo, e anche perché questo permette ovviamente di riunire anche alcune discipline che tipicamente sono escluse dai ragionamenti sulle STEM (sebbene questo aspetto per fortuna negli ultimi ultimi anni stia cambiando: una consapevolezza storica, una consapevolezza culturale degli scienziati migliora enormemente, complessivamente a livello di sistema, anche la capacità dei nostri più giovani concittadini di incidere e di ottenere anche soddisfazioni professionali). La questione ha molte ragioni che ne spiegano oggi la situazione complicata. Una è ovviamente il basso livello di investimento del paese sulla ricerca scientifica per un pregiudizio che probabilmente risale addirittura a Croce: forse non siamo ancora riusciti a superare quella barriera culturale. Poi è necessario interrogarsi, oltre che sulla quantità dei finanziamenti, sulla qualità dell’infrastruttura di ricerca, che ovviamente in Italia conta tantissime eccellenze. Noi lo misuriamo sui temi che conosciamo meglio: potremmo dire, semplificando, che forse il Museo Galileo ha creato, ad esempio, una biblioteca come quella che ha creato perché nelle università si faceva fatica a crearla. Ha creato una serie di format e di progetti di ricerca che dentro le università non solo si fa fatica a creare, ma si fa fatica a mantenere. Questo per una cultura del progetto che, purtroppo, avrà pure avuto dei risultati e dei risvolti positivi, ma se non è accompagnata da una cultura delle istituzioni rischia di avere una continua produzione di progetti che poi muoiono e che non producono tutti gli effetti che pure dovrebbero produrre. Questo per dire che anche la storia della scienza intesa come ponte tra le discipline umanistiche e le discipline scientifiche, dal nostro punto di vista (e ci sono tantissimi casi interessanti che lo raccontano), può migliorare le cose. È un piccolo contributo, me ne rendo conto, ma può anche aiutare a far capire, a far avvicinare, e questo lo vediamo nei nostri laboratori didattici. Molti bambini che si dichiaravano lontani dalle materie scientifiche scoprono poi che dietro la storia di quelle materie scientifiche, dietro gli strumenti, dietro i personaggi, ci sono storie che sono molto più ricche di quelle che tipicamente uno si aspetta. È come nell’esempio di Galileo, che certamente è stato uno scienziato visionario e capace di creare degli oggetti e immaginarne anche degli altri che suscitano interesse, però è stato molte cose insieme: quando ritorna a Firenze pretende di essere chiamato filosofo prima ancora che matematico, e quindi fa capire come in verità il sapere poi si possa riunire. E probabilmente è anche uno dei modi per avvicinare i giovani alle materie scientifiche.



Tra l’altro oggi di scienza si parla in continuazione. Basti pensare anche al dibattito politico. Ai temi come la sostenibilità, l’intelligenza artificiale, il cambiamento climatico. Un istituto come il Museo Galileo, dedicato alla storia della scienza, cosa deve fare per stare sul pezzo in questo dibattito? Detto brutalmente: è necessario che prenda posizione, che faccia informazione, che faccia divulgazione, oppure la sua missione è più legata alla storia della scienza?
Il ruolo del museo, credo, continuerà a essere quello di un mediatore culturale qualificato: il Museo Galileo, come tutti i musei, continuerà ad avere senso fino a quando ci sarà qualcuno che si fida della sua opera di mediazione culturale, cioè della capacità di poter selezionare, tra le fonti, quella che è più rilevante, prendendosi i rischi del mestiere. Io non sono tra quelli che ritengono che il parere degli esperti sia equivalente al parere di un visitatore, o che dobbiamo inventarci sistemi di partecipazione che facciano sentire curatori pure quelli che sono passati qui per caso, magari perché volevamo vedere il dito di Galileo. Penso che dobbiamo fidarci degli studiosi, e ovviamente gli studiosi come tutti possono sbagliare, ma la ricerca ha un suo sistema di confronto interno e di selezione che può essere migliorabile come tutte le cose umane. E bisogna ovviamente fare in modo di creare organizzazioni che stimolino gli studiosi a dialogare con altre figure per fare sì che il raggio di azione e la parabola dei progetti di conoscenza sia molto lunga e arrivi anche a chi è davvero solo un curioso e non uno specialista. Io credo che gli strumenti ci aiuteranno, se sapremo utilizzarli bene, ad ampliare il raggio di azione, ma rimarrà il nocciolo della questione: l’istituto culturale esiste nella misura in cui riesce ad avere un motore che produce conoscenza nuova attraverso la ricerca ed è in grado di vagliare anche quello che i sistemi automatici sono in grado di produrre e che però devono avere un filtro e un riscontro.
E a Lei, come piace pensare al museo Galileo? Ovvero: cos’è o cosa dovrebbe essere per Lei il Museo Galileo?
Quello che io mi aspetto e che spero di contribuire a fare è intanto di non disperdere l’eredità intellettuale di questo istituto, perché c’è una parte visibile di questa eredità che è fatta di libri, di oggetti e di documenti che incorporano una memoria, ma ce n’è una che non ha un supporto, ed è un certo modo di lavorare, un certo tono nel comunicare che non è mai presuntuoso, che non è mai in cerca di successo facile, di battute ad effetto, e questo cerchiamo di utilizzarlo come criterio guida di molte cose. Spero di salvaguardare un certo modo di lavorare che viene, lo dico apertamente, dalla direzione di Galluzzi, che era attenta allo studio delle fonti, senza le quali nessun progetto di ricerca può avere solide basi, però allo stesso tempo era capace di sperimentare forme nuove di comunicazione. È necessario prendere sul serio i giudizi di chi frequenta l’istituto anche solo occasionalmente, però con l’ambizione di poter ingaggiare un confronto serio. E il confronto serio presuppone che chi si siede a parlare abbia davvero a cuore le cose di cui parla e quindi abbia avuto voglia di dedicare un po’ di tempo a poterle studiare e comprendere, perché altrimenti ogni decennio c’è una nuova tendenza dei musei. E questo ovviamente è un limite del dibattito professionale sui musei che viene affascinato da questioni alla moda, come ad esempio la Convenzione di Faro, e trascura le questioni fondamentali, per esempio che nella gran parte dei musei italiani mancano le condizioni minime di funzionamento e di apertura in sicurezza.
Per chiudere invece una domanda che solitamente si fa al all’inizio: la faccio alla fine, perché credo possa riassumere tutto quello che ci siamo detti. Lei dirige il Museo Galileo da quattro anni: può trarre un breve bilancio?
Io sono contento delle cose che siamo riusciti a fare: ho sempre tenuto a lavorare per rafforzare soprattutto il lavoro di squadra, perché ovviamente avendo un museo con dei settori molto specializzati il rischio è sempre quello che si chiudano nella loro specializzazione, ma per fortuna i progetti consentono sempre il lavoro tra vari settori del Museo Galileo. Io penso che il riallestimento del piano terra sia stato un bel passo avanti per il nostro istituto e che abbia permesso ai visitatori di capire che, dietro quello che vedono nelle vetrine, c’è un istituto che fa ricerca, che lo fa in tutto il mondo, e che cerca di tenere unita la dimensione di studio con quella di comunicazione. Anzi: le due si alimentano in maniera molto stretta, e il mio mestiere è anche quello di cercare di raccordare sempre di più i vari fronti che a volte tendono inevitabilmente a divaricarsi, e di tenere ovviamente un ritmo che è cresciuto molto, perché sono cresciuti i progetti, sono cresciuti gli accadimenti economici (le registrazioni contabili sono triplicate), sono cresciute le persone (quando sono arrivato credo ci fossero 40-42 dipendenti, adesso siamo a 65 dipendenti), è cresciuto il numero dei visitatori, è cresciuto il bilancio anche per effetto di una serie di bandi PNRR che abbiamo vinto. Quindi sono contento che il museo abbia mantenuto la sua fisionomia di istituto che fa ricerca, e abbia mantenuto l’impegno verso le forme innovative di comunicazione su cui abbiamo apportato anche delle novità interessanti, anche con il contributo di società creative esterne e ovviamente di collaborazioni. Sono quindi contento che il museo abbia potuto celebrare il suo centenario in una condizione di serenità dal punto di vista di un bilancio che ora supera i 4 milioni di euro e che per un istituto che si occupa di storia della scienza è chiaramente uno sforzo importante. E tutto questo mentre la biblioteca continua a crescere e la collezione cresce, perché la collaborazione col Ministero ci ha permesso negli ultimi anni di avere qui da noi importanti oggetti che discendono dall’attività, che il museo fa, di dare pareri alle soprintendenze sul patrimonio storico-scientifico. Avevamo intercettato degli oggetti molto belli e molto importanti, che ora sono qui da noi, compreso anche un nuovo ritratto di Galileo. Il personale cresce, anche coi giovani, cosa che mi fa assolutamente piacere perché è inevitabile che dobbiamo preparare il museo anche al pensionamento di alcune figure che hanno lavorato per molto tempo qui, il che non è mai facile. Abbiamo nuovi progetti ambiziosi davanti, nuove collaborazioni che fanno promettere bene: continuo insomma a credere che, nonostante la storia della scienza sia una disciplina considerata specialistica, una nicchia, continui a essere tuttavia una nicchia che qui al Museo Galileo si riunisce, che produce, ovviamente con una dialettica interna che è la parte per me affascinante di un modo di intendere la disciplina che non vede sempre tutti d’accordo (e questa è una cosa, secondo me, molto sana). Il museo è il luogo privilegiato del confronto degli studiosi sui progetti, sulle attività e quindi anche in qualche modo sul futuro della disciplina. Io penso che il museo debba continuare a essere la casa di tutti: qui si incontrano storici della scienza, filosofi della scienza, storici dell’architettura, storici dell’arte, proprio per il carattere assolutamente multidisciplinare. E anche le nuove linee di lavoro che si sono rafforzate in questi anni, come lo studio dei rapporti tra scienza e musica, per esempio con il convegno sulla figura di Vincenzo Galilei, di cui ora pubblicheremo gli atti, o, ad esempio, il lavoro sul rapporto donne e scienza con la mostra fatta alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Donne del cielo. Da muse a scienziate), sono non solo tracce di un lavoro che è l’erede di un impegno di molti anni, ma è anche una traccia, secondo me, importante sul futuro. E su questo voglio essere ottimista.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.