Dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026 le Scuderie del Quirinale aprono le porte a Tesori dei Faraoni, mostra che porta a Roma una selezione di 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto. Questi reperti, provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, rappresentano un’occasione eccezionale, poiché molti di essi vengono esposti per la prima volta al di fuori del loro paese d’origine. Il progetto è curato da Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, e si configura come la seconda più vasta esposizione di antichità egizie mai allestita in Italia a partire dal 2002.
Il percorso espositivo si configura come un viaggio nella civiltà egizia attraverso le sue forme più alte e insieme più intime: il potere, la fede e la vita quotidiana. La mostra racconta la storia di una delle più antiche civiltà della Terra, nata sul Nilo nel 3200 a.C., i cui faraoni si distinsero per il loro talento in medicina, astronomia, arte, architettura, letteratura e magia. Le sale illustrano la vita dei sovrani, il concetto di regalità, l’organizzazione politica e amministrativa dello Stato, rivelando anche aspetti della loro vita quotidiana, dal controllo sulla coltivazione della terra alla costruzione di grandi opere. I reperti dimostrano l’amore dei faraoni per la vita, assaporata in ogni aspetto, e la loro aspirazione all’esistenza eterna nell’aldilà.
L’iniziativa è promossa da ALES - Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura e MondoMostre, in stretta collaborazione con il Supreme Council of Antiquities of Egypt. Gode inoltre del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura italiano e del Ministero del Turismo e delle Antichità d’Egitto, oltre al patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino. La realizzazione di questo evento è stata resa possibile grazie al fondamentale sostegno di Intesa Sanpaolo ed ENI, entrambi Main Sponsor del progetto, che ribadiscono il loro impegno nella promozione culturale e nel rafforzamento del dialogo tra le diverse civiltà. EgyptAir partecipa come Vettore Ufficiale, facilitando il trasporto delle opere dall’Egitto a Roma. Si aggiungono i Partner Cotral, Urban Vision e Ferrovie dello Stato Italiane, il cui prezioso contributo supporta un’iniziativa che coniuga eccellenza scientifica, respiro internazionale e partecipazione pubblica.










Il percorso si apre con lo splendore dell’oro, materia divina e simbolo di eternità. Gli Egizi avevano introdotto i primi sistemi conosciuti per l’estrazione dell’oro già intorno al 3200 a.C.. Una delle testimonianze storiche di questa attività è la più antica mappa delle miniere d’oro, il Papiro delle miniere, oggi conservato al Museo Egizio di Torino, rinvenuta nella necropoli di Deir el-Medina, a Luxor. L’oro abbondava nel deserto orientale vicino alle colline del Mar Rosso e nel sud del Paese. La mostra presenta oltre quaranta preziosissimi manufatti in oro. Tra i pezzi di spicco che introducono al mondo delle élite si trovano il sarcofago dorato della regina Ahhotep II, la Collana delle Mosche d’oro – un’antica onorificenza militare conferita per il valore in battaglia – e il celebre collare di Psusennes I. Quest’ultimo è una creazione straordinaria, composta da sette fili di oltre 6.000 dischetti d’oro, ed è considerato il gioiello più pesante dell’antichità giunto fino ai giorni nostri.
Dalla magnificenza regale, il percorso entra nell’universo del rito, dove la morte è interpretata come trasformazione. L’esistenza nell’Antico Egitto era profondamente legata al concetto di vita eterna: gli Egizi vedevano la vita e la morte come un ciclo eterno, osservando il sorgere e tramontare del sole, le inondazioni annuali del Nilo e il ciclo agricolo di mietitura e semina. Erano convinti che avrebbero continuato a vivere nell’aldilà in una forma diversa. Tuttavia, l’accesso alla vita eterna era subordinato a numerose condizioni. La più cruciale era l’esistenza di una tomba o di un luogo di sepoltura, la conservazione della mummia, la presentazione continua di offerte e la custodia del nome e dell’immagine del defunto attraverso i rilievi nelle camere funerarie o le statue. Gli Egizi credevano, infatti, che la morte vera sopraggiungesse solo quando l’ultima persona che ricordava il nome del defunto fosse scomparsa.
Questa sezione della mostra è dominata dal monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye. Attorno ad esso, statuette shabti, vasi canopi e un papiro del Libro dei Morti illustrano la precisione quasi scientifica con cui gli Egizi preparavano il viaggio nell’aldilà, un insieme di formule, immagini e strumenti destinati ad attraversare il mondo invisibile e a rinascere alla luce di Ra.
La sezione successiva svela il volto umano della regalità e l’organizzazione sociale. Già agli albori della storia egizia, intorno al 3200 a.C., si identificavano i sovrani con il termine shemsu Hor, ovvero “seguaci di Horus”. L’istituzione stessa della regalità era strettamente legata a un popolo persuaso della sacralità del faraone. La società egizia era gerarchica e aveva al vertice il faraone, che incarnava l’autorità religiosa, politica e amministrativa. Questo ordine rimase stabile per oltre tremila anni, in parte grazie alla possibilità di mobilità tra le classi sociali basata sul merito e sulle capacità personali. Figure come Imhotep, l’architetto geniale, e Senenmut, che ricoprì più di venti importanti cariche sotto la regina Hatshepsut, dimostrano che anche uomini del popolo potevano raggiungere posizioni di rilievo. Immediatamente sotto il faraone si trovavano gli aristocratici, i sacerdoti e i ministri. Mentre nell’Antico Regno le cariche più alte erano riservate prevalentemente ai membri della famiglia reale, dal Medio Regno in poi l’assegnazione delle qualifiche cambiò radicalmente, basandosi sul merito e non più solo sul ceto. Questa promozione dell’innovazione e dell’eccellenza è considerata uno dei punti di forza della società egizia, rendendo possibili opere straordinarie come piramidi, tombe e templi. La classe media, composta da scribi, soldati e professionisti specializzati – tra cui artigiani e artisti – costituiva una parte fondamentale della società. Seguivano i contadini, gli operai che lavoravano nelle cave e nell’edilizia, i marinai e i pescatori. Il gradino più basso era occupato dalla classe servile, che includeva cuochi, birrai, tessitori e domestici. Le tombe dei nobili e dei funzionari, come quella di Sennefer, svelano la quotidianità del potere, la devozione e il senso del dovere di coloro che servivano il faraone, garante dell’ordine cosmico. In dialogo con queste figure, la poltrona dorata di Sitamun, figlia di Amenofi III, restituisce un’intimità sorprendente: un oggetto domestico usato in vita e poi deposto come dono nella tomba dei nonni, una rara testimonianza di affetto e continuità familiare.






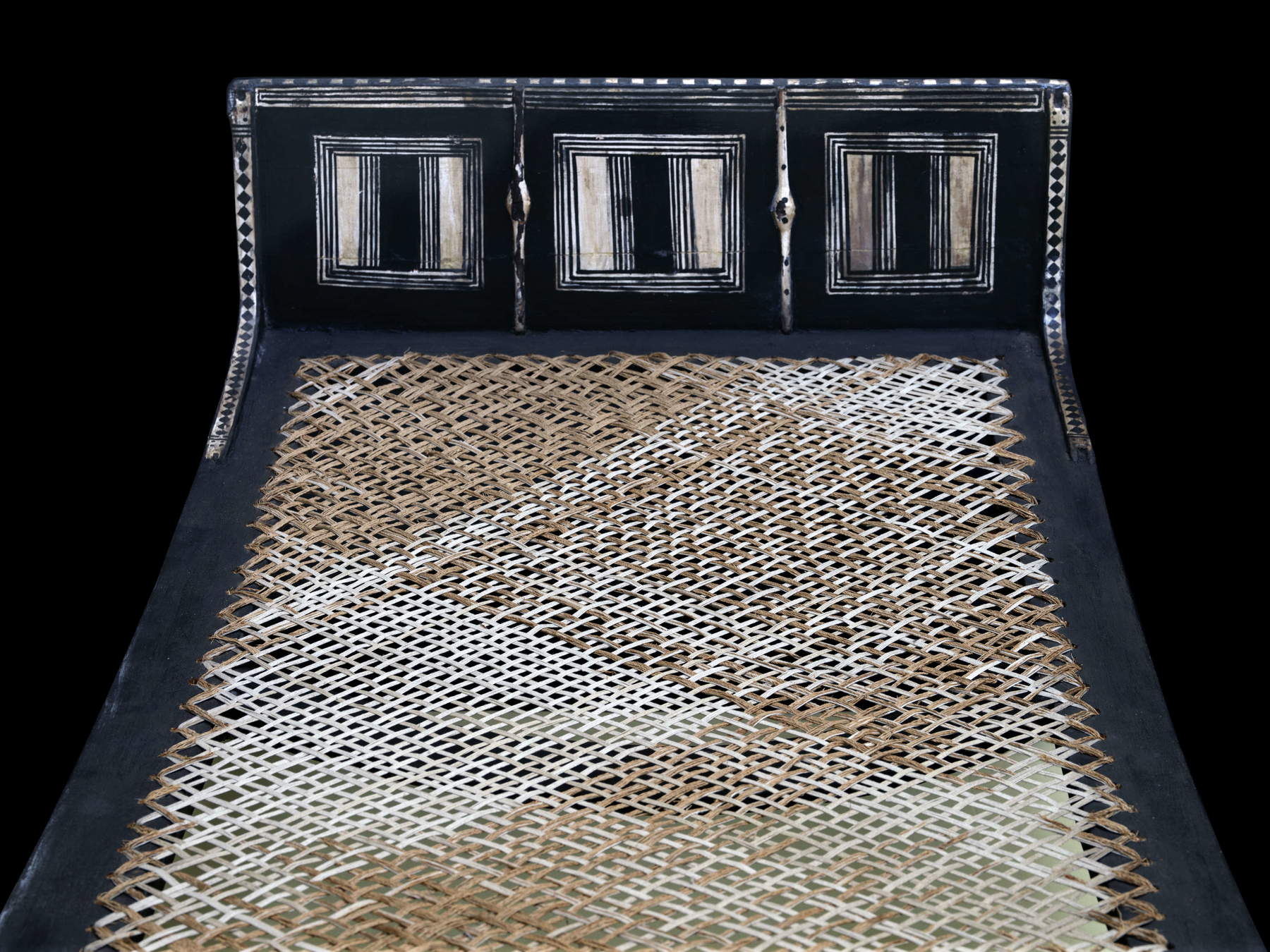
Una delle sezioni più attese è dedicata alla “Città d’Oro” di Amenofi III. Questa straordinaria scoperta archeologica è stata portata alla luce nell’autunno del 2021 da Zahi Hawass, che guidava una squadra inizialmente alla ricerca del tempio funerario di Tutankhamon. L’insediamento, noto nell’antico Egitto come il “dominio dell’abbagliante Aton”, è una delle più importanti città di artigiani dell’antichità, risalente al regno di Amenhotep III della XVIII dinastia. Si trova sulla riva occidentale del Nilo, a Luxor, a nord del tempio di Medinet Habu. Gli scavi hanno fatto riemergere gran parte della città, che era suddivisa in quartieri separati da muri a zig-zag costruiti in mattoni crudi, come tutti i suoi edifici. La Città d’Oro si è conservata in ottimo stato, probabilmente perché fu abbandonata all’improvviso, forse nel quinto anno di regno di Amenhotep IV/Akhenaton, dopo che questi ebbe costruito una nuova capitale a Tell el-Amarna, dedicata esclusivamente al culto del dio Aton. Luxor, infatti, era la capitale religiosa di Amon, la cui potente casta sacerdotale aveva l’autorità per opporsi ad Akhenaton e alla sua nuova religione.
Si prosegue con la sezione sulla religione egizia, una delle più antiche del mondo, che si distingueva per il suo stretto legame con la natura e la geografia. Ritenendo che ogni forza naturale fosse espressione del divino, gli Egizi svilupparono un sistema politeista con un numero infinito di divinità che rappresentavano il sole, la luna, la terra, il vento, il deserto, l’agricoltura, il Nilo e le inondazioni. Dèi e dee incarnavano anche valori spirituali come il bene, il male, la giustizia, la verità, l’amore, l’odio, la lealtà e la gelosia, ed erano raggruppati in famiglie composte da padre, madre e figli, analogamente agli esseri umani. C’è anche, verso il finale, una sezione sulla regalità sacra, concetto affermatosi sin dagli albori intorno al 3200 a.C., che diede vita a uno dei sistemi di governo più complessi e duraturi, rimasto quasi immutato per oltre tremila anni. Il faraone era considerato l’incarnazione di Horus, il dio che aveva lottato per riconquistare il trono del padre Osiride. In quanto Horus, il sovrano non solo difendeva il trono d’Egitto, ma garantiva anche la conservazione dell’ordine cosmico. Il re governava in base al concetto di maat: verità, giustizia e armonia universale. Alla sua morte, assumeva una forma divina come manifestazione di Osiride, signore dell’oltretomba. La mostra culmina nel mistero della regalità divina. Le statue e i rilievi che chiudono il percorso sono tra le espressioni più alte dell’arte faraonica: l’Hatshepsut inginocchiata in atto d’offerta, la diade di Thutmosi III con Amon, la Triade di Micerino, fino alla splendida maschera d’oro di Amenemope, dove il volto del re, levigato e perfetto, diviene icona di un corpo che appartiene ormai al divino. In chiusura, la Mensa Isiaca, eccezionalmente concessa dal Museo Egizio di Torino, riannoda il filo simbolico che da Alessandria conduce a Roma, testimoniando l’antico legame spirituale e culturale tra i due mondi. Questo oggetto, una tavola bronzea, dimostra una conoscenza approfondita del pantheon egiziano da parte del suo autore. Il contesto di provenienza più probabile è l’Iseum Campense, il tempio di Iside al Campo Marzio, attestato nell’antica Roma dal I secolo a.C. al V d.C.. L’Iseum occupava un’area allungata di oltre 10.000 metri quadri, situata a sud del Tempio di Adriano e separata dal Pantheon dai Saepta Iulia.
La prima traccia storica della tavola risale al Cinquecento, quando fu acquisita dall’umanista Pietro Bembo, ragione per cui è nota anche come “tavola bembina”. Sebbene la data esatta dell’acquisizione sia incerta, le ipotesi includono un regalo di papa Paolo III, l’acquisto da un fabbro che l’aveva recuperata dopo il sacco di Roma del 1527, o un’acquisizione precedente, attorno al 1522, da ambienti vicini alla corte papale.





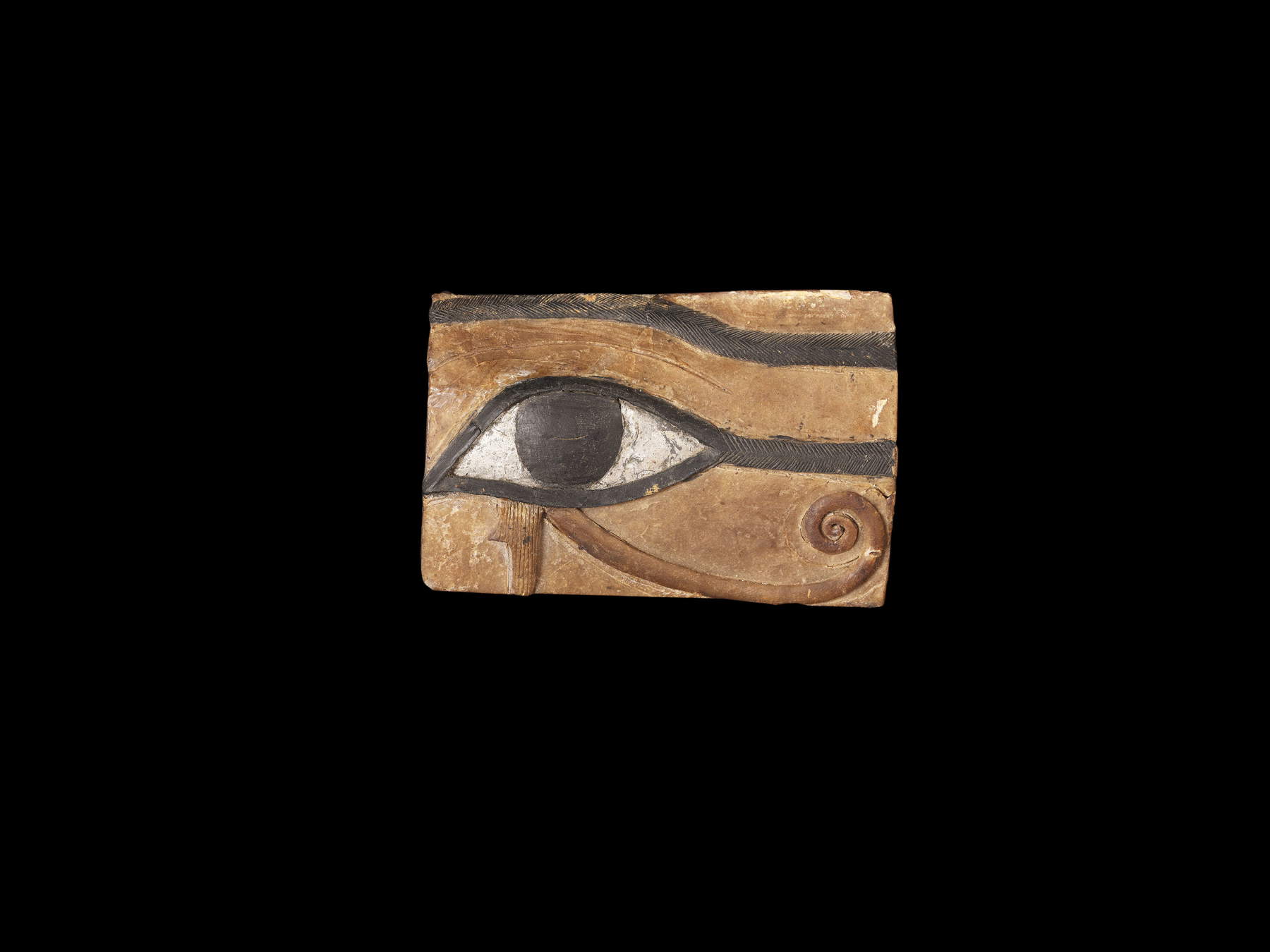



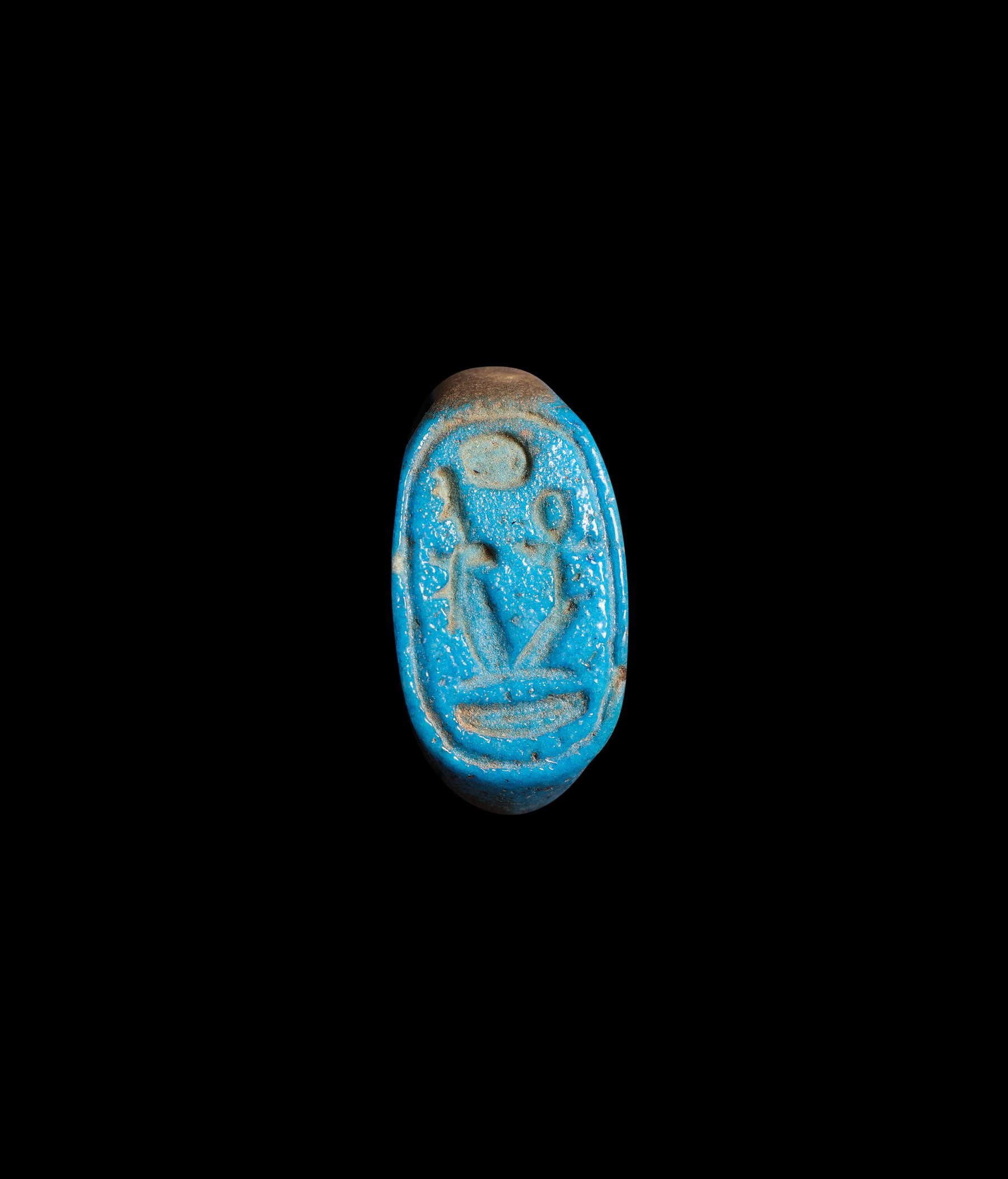


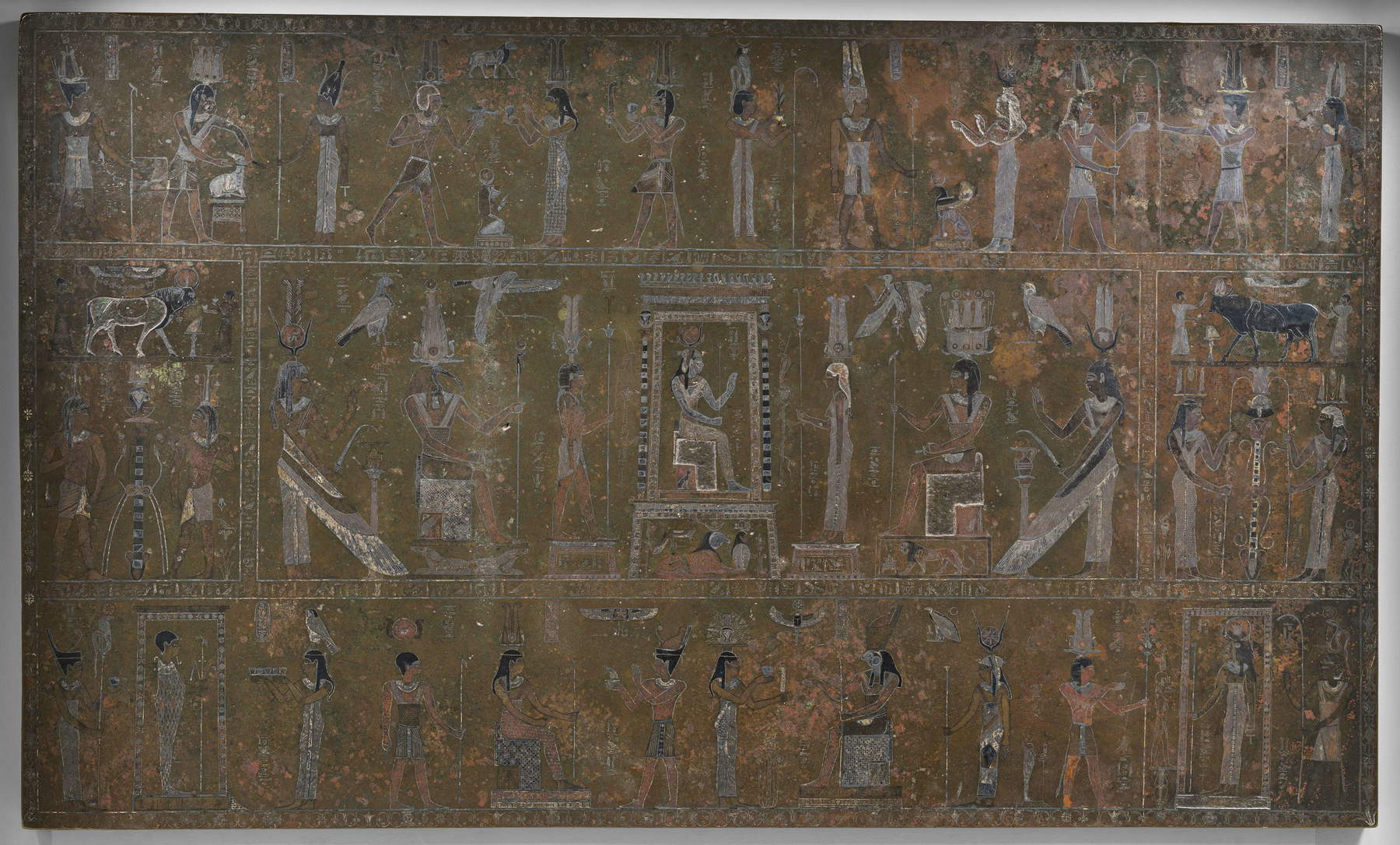

“Tesori dei Faraoni” è corredata da un vasto programma di mediazione e divulgazione. Il catalogo, curato da Zahi Hawass ed edito da Allemandi in edizione italiana e inglese, include le fotografie di Massimo Listri che documentano la magnificenza dei capolavori esposti. Hawass firma per la casa editrice anche la guida breve e la guida per ragazzi, concepite per accompagnare il pubblico più giovane con un racconto accessibile tra storie, divinità e simboli.
Tutti i visitatori avranno a disposizione un’audioguida inclusa nel biglietto, disponibile in quattro lingue. La versione italiana è narrata dalla voce di Roberto Giacobbo, mentre la versione inglese è narrata da Zahi Hawass. È prevista anche una versione dedicata specificamente ai bambini, per un’esperienza di visita ancora più coinvolgente.
È attivo un ricco percorso didattico pensato per tutti i pubblici. Sono previsti laboratori didattici e visite guidate, progettati in collaborazione con il Museo Egizio di Torino, che partono dai temi centrali della mostra per offrire esperienze concrete. Ad esempio, i più giovani potranno esplorare simboli, animali e figure divine, ricostruendo in modo interattivo la vita dell’antico Egitto. Per le scuole, dalla fascia dell’infanzia alle secondarie di primo grado, sono già attivi laboratori specifici che estendono l’offerta formativa tradizionale, permettendo di attraversare i principali assi tematici della mostra, come l’evoluzione sociale, l’arte funeraria, l’iconografia religiosa e le innovazioni materiali. A completamento di questa proposta si aggiunge un programma di attività collaterali, sviluppato in collaborazione con il dipartimento SARAS della Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma. Questo programma prevede incontri, seminari e approfondimenti guidati da studiosi, archeologi ed esperti, con l’obiettivo di arricchire la fruizione dell’esposizione e favorire il dialogo tra cultura, ricerca e pubblico. È possibile acquistare in prevendita il biglietto sul sito www.scuderiequirinale.it, una pratica consigliata data la forte richiesta attesa. Sullo stesso sito è anche possibile scaricare gratuitamente tutte le audioguide e consultare il programma completo dei laboratori didattici, delle visite guidate e l’elenco degli eventi collaterali in programma.
| Titolo mostra | Tesori dei Faraoni | Città | Roma | Sede | Scuderia del Quirinale | Date | Dal 24/10/2025 al 03/05/2026 | Curatori | Tarek El Adawy | Temi | Arte antica, Egittologia, Arte Egizia |
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.