Alle porte del Cairo, il 21 luglio 1798, l’esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 1769 - Sant’Elena, 1821) entrò in conflitto con le truppe mamelucche in quello che sarebbe passato alla storia come la Battaglia delle Piramidi, episodio che fin dal principio assunse un potente valore evocativo. Non sorprende, infatti, che la storia dell’arte abbia restituito numerose raffigurazioni del generale in terra d’Egitto, spesso complesse e cariche di significati, in grado di restituire l’ambivalenza tra gloria militare e riflessione storica. Il periodo neoclassico e quello romantico, in modo particolare, hanno fatto di Bonaparte un personaggio popolare, ritratto sotto aspetti differenti. Anzitutto come condottiero trionfante. A partire dal 1797, quando i suoi trionfi militari iniziarono a risuonare, Napoleone viene infatti ritratto come un eroe, in pose simili alle sculture e ai busti dell’antichità greco-romana, come quelli di Giulio Cesare e Antinoo, amante dell’imperatore Adriano.
Tra queste riproduzioni, spiccano le raffigurazioni della campagna in Egitto, periodo tra il 1798 e il 1801 che restituisce la figura del generale attraverso opere che inquadrano la sua forza nella battaglia delle Piramidi e gli attimi quotidiani del percorso orientale di Bonaparte. La sua ritrattistica è mirata perciò verso il desiderio di immortalarsi come un condottiero indomito. Le opere ne enfatizzano la grandezza e l’ego. Per Napoleone infatti, l’impresa bellica in Egitto diventa un simbolo di gloria personale. Le composizioni che raffigurano la spedizione furono realizzate durante il periodo dell’impero, come testimonia Battaglia delle Piramidi di Francois-Louis-Joseph Watteau (Valenciennes, 1758 – Lilla, 1823), dipinta tra il 1798 e il 1799, e che sembra riflettere l’influenza dell’illustrazione risalente al 1803 di Dirk Langendijk (Rotterdam, 1748 – 1805) e dello schizzo di François-André Vincent (Parigi, 1746 – 1816). Lo scenario narrato nell’opera di Watteau descrive la battaglia più conosciuta della campagna, combattuta il 21 luglio 1798 e che vide l’esercito francese guidato da Napoleone, contro le forze dei Mamelucchi guidati da Murād Bey e Ibrāhīm Bey. Per l’occasione, il futuro imperatore di Francia svelò una delle sue tecniche militari più interessanti: il grande quadrato divisionale, una strategia innovativa che gli permise di mantenere una difesa impenetrabile contro la cavalleria nemica e che segnò un punto di svolta nelle tattiche militari dell’epoca. Nel dipinto di Watteau la scena della battaglia si staglia sotto l’imponente piramide dipinta sullo sfondo del quadro.

I ritratti di Napoleone che lo raffigurano in Egitto sono per lo più disegni e schizzi eseguiti dagli artisti che lo accompagnarono nella spedizione, come nel caso di Charles Louis Balzac e André Dutertre. Intorno al 1867, quest’ultimo abbozzò una serie di opere che catturavano l’esercito del generale Bonaparte tra le strade del Cairo e tra le sabbie del deserto. Dutertre, tra i protagonisti della grande impresa napoleonica, fu accolto nell’Institut d’Égypte nell’agosto 1798, all’interno della sezione dedicata alla letteratura e alle arti. In quel periodo tracciò 184 ritratti dei membri della spedizione, tra scienziati e ufficiali, le cui immagini compongono oggi l’Histoire scientifique et militaire di Reybaud e illustrano il Journal di Villiers du Terrage. Oltre alla rievocazione degli uomini di scienza e guerra, Dutertre si volse anche alla gente del luogo, colpito dall’anima e dai colori delle persone.
In realtà sono diversi gli artisti che rappresentano la campagna egiziana di Napoleone: molti lo ritraggono in piedi, di fronte alle imponenti rovine mamelucche della Città dei Morti, altri invece lo immortalano a cavallo pronto a scrutare la città del Cairo e le antiche rovine di Giza. Del 1835 è l’opera di Léon Cogniet (Parigi, 1794 – 1880) intitolata L’Expédition d’Egypte sous les ordres de Bonaparte. Nel contesto della campagna militare e scientifica, la figura del comandante si eleva a leader militare e promotore di un’impresa culturale e intellettuale. La spedizione è un momento storico fondamentale per la connessione tra il mondo antico e moderno. Tramite la campagna, Napoleone riesce infatti a convalidare sia il legame tra l’Egitto faraonico che le aspirazioni illuministiche legate al nuovo secolo. Nel dipinto di Cogniet, oggi conservato al Museo del Louvre, il generale Bonaparte appare come un comandante e allo stesso tempo come un uomo di cultura circondato da scienziati, archeologi, artisti e militari.

Con lo sguardo deciso dirige le operazioni di ricerca e scavo, mentre all’interno del dipinto si intravedono gli archeologi intenti a scoprire un sarcofago. Il lavoro che vede il legame tra la guerra, la ricerca e lo studio rispecchia infatti l’idea di Napoleone di rendere la sua spedizione una missione di conoscenza, oltre che di potere. Può essere una sfida di vanità e grandezza? Assolutamente sì. Nel 1851 lo svizzero Karl Girardet (Le Locle, 1813 – Versailles, 1871) produce l’incisione Napoléon en Egypte (Quarante siècles le méprisent). La scena rappresenta il momento in cui Bonaparte a cavallo si pone di fronte all’enigmatica sfinge e alla piramide, testimoni di un Egitto perduto. Il titolo dell’incisione Quaranta secoli lo guardano dall’alto richiama oltre a ciò una frase (attribuita al Napoleone) pronunciata davanti al suo esercito “Soldati! Dall’alto di queste piramidi, quaranta secoli di storia vi osservano”.
Nel 1895 Maurice Henri Orange (Grandville 1868 – Parigi 1916) lo illustra nel suo Napoléon Bonaparte devant les pyramides, contemplant la momie d’un roi nell’intento di osservare la mummia di un faraone. Possiamo quindi definire l’opera come una conversazione silenziosa tra il generale francese rappresentante del potere moderno e occidentale, e il sacro sovrano d’Egitto. La scena viene ripresa dal regista Ridley Scott all’interno del film Napoleon, del 2023. Nella trasposizione cinematografica Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix, contempla la mummia nel sarcofago avvertendo, probabilmente per la prima volta, la grandezza della cultura egizia. Seguendo il modello di Orange, Scott immortala con la stessa intensità l’istante in cui Napoleone si avvicina alla mummia per scrutare il suo volto con attenzione. Appoggia il cappello sul sarcofago con un gesto di curiosità, poi prende una cassa di legno e si avvicina ancora di più cercando negli occhi della mummia un confronto.

Napoleone riesce effettivamente a reggere quello sguardo? Non lo sappiamo, ma nelle rappresentazioni del periodo egiziano, la figura di Bonaparte si delinea come un eroe che si immerge in un dialogo di conquista con un Egitto immortale. Si innalza in una contemplazione profonda di quelle terre. Il Napoleone di Dutertre riflette proprio su questo. Ragiona sulla sua grandiosità e su quella di una civiltà che vive nei ricordi delle sue rovine e nella maestosità del suo passato. Sul piano storico, la spedizione francese in Egitto rispondeva a precise ambizioni coloniali: Bonaparte mirava a indebolire l’influenza britannica in India, colpendone gli interessi economici attraverso il controllo del Mediterraneo orientale.
Perciò, oltre a radunare un esercito imponente di circa 50.000 soldati, Bonaparte inviò oltre 160 studiosi, componenti della Commission des sciences et des arts, di varie discipline che comprendevano la botanica, la geologia, e le scienze umanistiche, a unirsi all’impresa. Gli esperti si dedicarono a esplorare e documentare con attenzione i paesaggi culturali e naturali dell’Egitto, producendo nel 1809 una pubblicazione enciclopedica chiamata Description de l’Égypte ou Recueil des ob- servations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française (Descrizione dell’Egitto, o la raccolta di osservazioni e ricerche fatte in Egitto durante la spedizione dell’esercito francese) che contiene descrizioni dettagliate, tra cui quelle del complesso piramidale di Giza. I resoconti lasciati dai membri della commissione permettono oggi agli storici di confermare che Napoleone visitò le Piramidi, pur restando improbabile che ne attribuisse un’importanza strategica dal punto di vista militare.
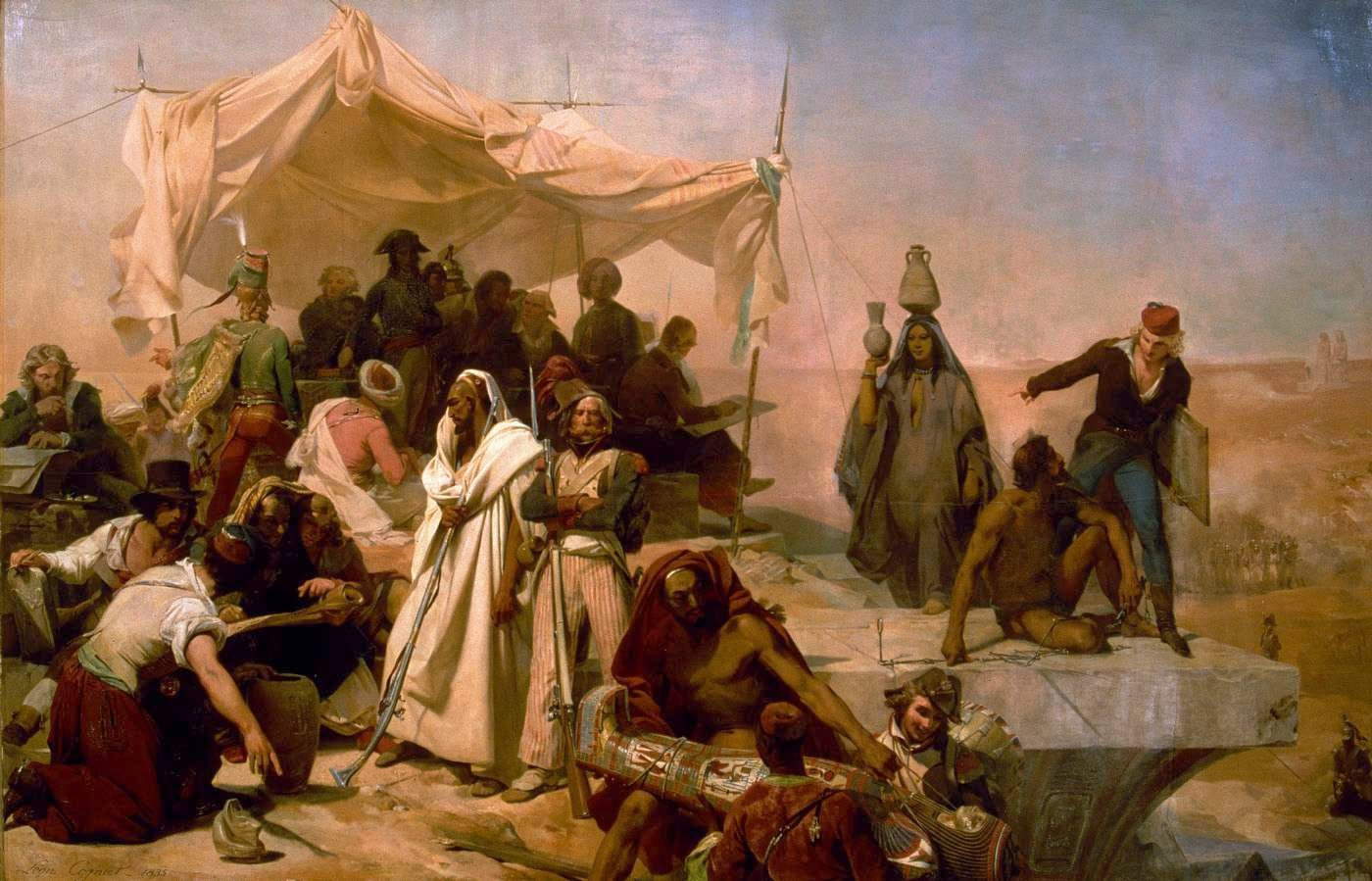
Secondo Salima Ikram, professoressa di egittologia all’Università americana del Cairo, Napoleone nutriva una grande ammirazione per la sfinge e le piramidi, utilizzandole addirittura come simboli per motivare le sue truppe verso una vanità personale e gloria maggiore. Per questo motivo, al contrario di quello che è possibile vedere nella trasposizione di Scott, Ikram ha sottolineato che Bonaparte non avrebbe mai potuto sparare contro di esse. In un’intervista rilasciata al Times, lo stesso Scott ha affermato “non so se lo abbia fatto”, riferendosi al presunto colpo di cannone contro la sfinge attribuito alle truppe di Napoleone visibile all’interno del film, aggiungendo poi che la narrazione era un modo veloce per simboleggiare la conquista dell’Egitto da parte del condottiero.
Durante la spedizione, nel fervore di catalogare le ricchezze archeologiche dell’Egitto, gli studiosi francesi si appropriarono dei tesori e dei manufatti della terre faraoniche, tra cui la Stele di Rosetta, una lastra di pietra granodiorite incisa in tre lingue di circa 760 chili, fondamentale nella decifrazione dei geroglifici egiziani. Per Andrew Bednarski, studioso specializzato in egittologia e storia del XIX secolo, esisteva infatti un autentico interesse tra gli studiosi, condiviso anche da Napoleone, nel comprendere aspetti a cui gli europei non avevano avuto accesso sin dall’epoca classica.
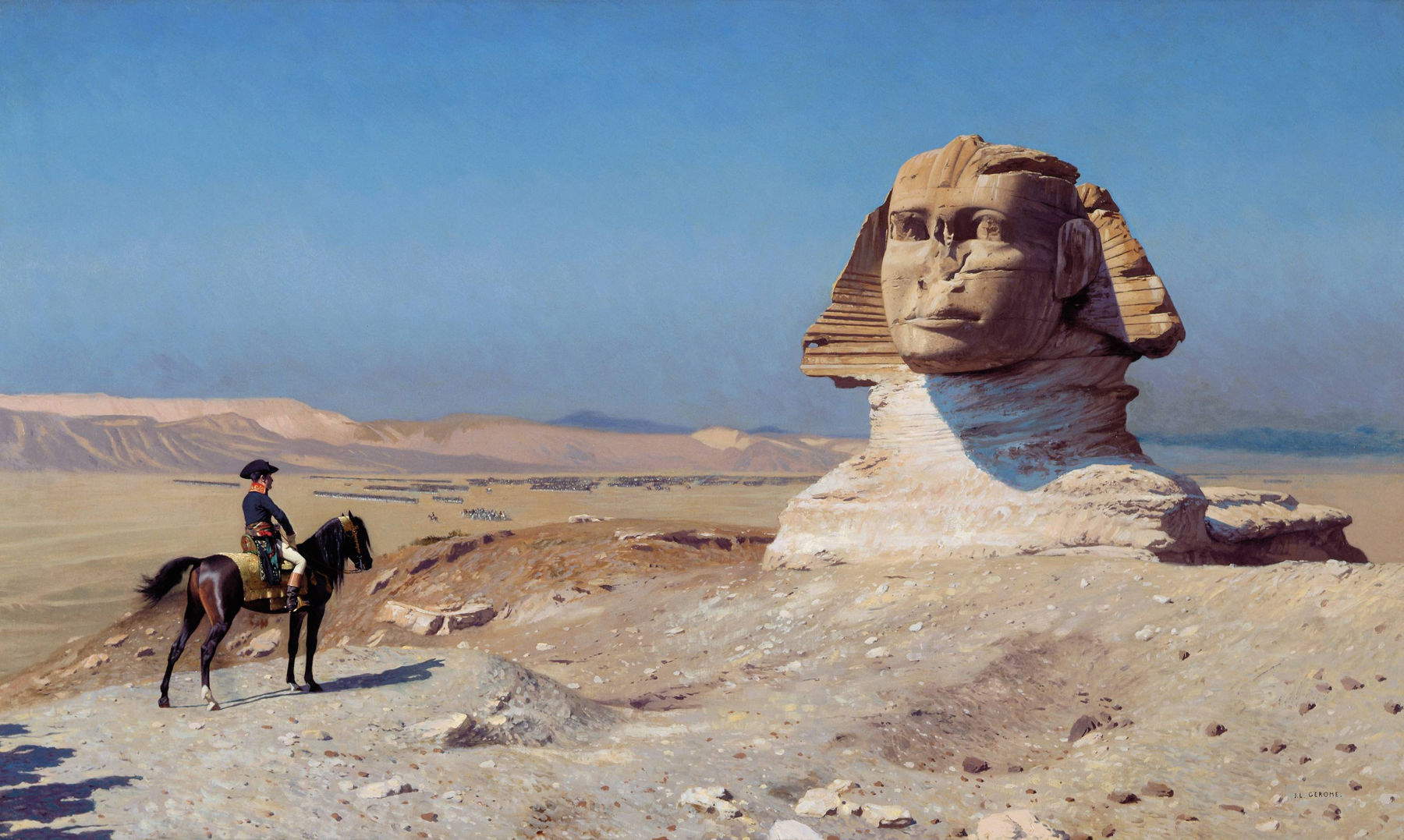
Pur conclusasi con un fallimento sul piano militare, la spedizione di Bonaparte contribuì a diffondere in Europa un profondo interesse per la civiltà egizia, innescando un’ondata di egittomania che avrebbe conquistato il mondo. E così è stato. Con la fine del dominio francese in Egitto nel 1801, molti dei cimeli compresa la stessa Stele finirono nelle mani degli inglesi nonostante in quel periodo Napoleone avesse già fatto ritorno in Francia. Il desiderio quindi di possedere i reperti dell’antica civiltà egizia aprì le porte a secoli di scavi, traffici e razzie, che spogliarono l’Egitto delle sue memorie. Dall’invasione napoleonica in poi, un fiume di reperti lasciò il suolo egiziano, spesso attraverso percorsi clandestini.
Secondo Alexander Mikaberidze, docente presso la Louisiana State University di Shreveport e autorevole studioso della storia napoleonica, la campagna egiziana, pur terminata con una sconfitta militare, produsse effetti importanti sul piano scientifico e culturale. L’invasione, infatti, segnò l’inizio di una nuova stagione di interesse per l’Egitto, dando impulso alla fascinazione occidentale per la civiltà faraonica che avrebbe orientato gli studi e le esplorazioni nei decenni successivi. Oltre a ciò tra tutti gli artisti che hanno ritratto Bonaparte, spicca sicuramente la figura di Jean-Léon Gérôme. L’artista francese ha familiarità con l’Egitto e, avendone esplorato le terre in quattro occasioni a partire dal 1855, sa bene quello che fa. Il dipinto Bonaparte devant le Sphinx realizzato tra il 1867 e il 1868 può essere considerato il quadro più rappresentativo del periodo napoleonico egiziano. Di forte impatto visivo e di grande potenza scenica, nell’opera la sfinge domina la metà della tela innalzandosi sopra Bonaparte immobile di fronte ad essa.

Come spesso accade nell’arte di Gérôme è proprio l’inquadratura a conferire profondità alla scena. Le piramidi vengono volutamente escluse per esaltare lo scontro tra l’uomo e la pietra millenaria. Gérôme, maestro nel cogliere l’istante, riesce dunque a ghiacciare il tempo sebbene piccoli dettagli riescano a preannunciarne la ripresa imminente: la coda del cavallo vibra appena, le ombre di un bastone si delineano nell’angolo sinistro del dipinto e in lontananza nel deserto le truppe si muovono pronte a partecipare alla battaglia delle piramidi del 1798. Gérôme presenta il dipinto dal titolo Edipo per la prima volta al Salon di Parigi del 1886 e attraverso la figura della sfinge traccia un sottile legame tra l’eroe mitologico di Tebe e colui che avrebbe salvato la Francia. Ridley Scott omaggia il lavoro di Gérôme con la stessa inquadratura. Le opere dell’artista rivolte alla spedizione di Bonaparte in Egitto sono diverse. Nel 1867 dipinge Le Général Bonaparte et son état-major en Égypte. La scena si svolge nel deserto, con un Bonaparte fiero in groppa ad un cammello al centro della scena e circondato dai suoi ufficiali. Nell’opera, l’artista enfatizza l’esotismo dell’ambientazione attraverso la rappresentazione dettagliata dei costumi colorati dei beduini, il paesaggio e la postura dei personaggi. Contemporanea alla data del 1867 e 1868 è l’ulteriore opera ad olio Bonaparte en Égypte. Ancora una volta Gérôme, raffigura il condottiero fermo e orgoglioso in piedi davanti alle tombe mamelucche, fuori dal Cairo.
Così, sul cavallo davanti al colosso immortalato da Gérôme, Napoleone scruta il suo destino. Dopo la sua sconfitta in Egitto la sua arroganza si piega all’eternità dell’Egitto, poiché le piramidi, gli obelischi, i templi che hanno resistito ai secoli rimangono lì, in memoria di quanto fragile e passeggera sia la sua esistenza e quella degli uomini.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia
Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.