La Casa Siviero di Firenze è chiusa da qualche tempo per alcuni importanti interventi di restauro che terranno sbarrate le sue porte fino alla prossima primavera. C’è però da dire che è un museo che non ha voglia di star fermo, e da alcuni mesi ha cominciato a far girare le sue collezioni. Intanto, quest’estate c’è stata la presentazione, al Museo Horne, del recupero della croce dipinta, sontuosa tavola trecentesca del bolognese Lippo di Dalmasio, che Rodolfo Siviero aveva acquistato per la sua collezione: la Regione Toscana ha comperato all’asta, lo scorso anno, i due tabelloni ch’eran stati staccati dalla croce grosso modo cent’anni fa, li ha riuniti al crocifisso, ha restaurato l’insieme e ha presentato la ritrovata croce nelle sale del museo fiorentino, dove rimarrà fino almeno ad autunno inoltrato. E per l’occasione, l’opera è stata ribattezzata “Croce Siviero”. Prima ancora però Casa Siviero ha portato alcuni pezzi della sua collezione in quel lembo di Toscana dove Siviero nacque e dove trascorse la sua infanzia: alcuni pezzi sono ora al Teatro Marchionneschi di Guardistallo, a due passi dalla casa natale di quel funzionario che sarebbe poi passato alla storia per averci riportato indietro cataste di quadri e sculture che i nazisti avevano sottratto all’Italia durante la seconda guerra mondiale, e altri sono invece al Comune Vecchio di Bibbona, a nemmeno dieci minuti d’auto da Guardistallo. Le due sedi compongono, fino al 25 ottobre, un’unica mostra che reca fin dal titolo la più icastica, asciutta sintesi dei suoi contenuti (La vita di Rodolfo Siviero, tra il Rinascimento e De Chirico), e che si deve all’infaticabile lavoro del conservatore di Casa Siviero, Gabriele Mazzi, e del Dipartimento Cultura della Regione Toscana diretto da Elena Pianea, cui va il merito d’aver lavorato di concerto coi sindaci dei due Comuni (due province diverse, peraltro, con tutti gli ostacoli burocratici del caso) per aver portato un nucleo delle raccolte del museo in terra di Maremma.
Ne è uscita una mostra che fornisce a chi l’andrà a visitare una pregiata, disinvolta introduzione a una figura contornata di nebbia, a un personaggio poco noto anche a chi ha una certa consuetudine con le vicende dell’arte del secolo scorso, e ch’è stato tuttavia determinante per il rientro in Italia di quanto i nazisti avevan cercato di sottrarre. Chi era, intanto, Rodolfo Siviero? Alla domanda, la mostra, in entrambe le due sezioni, risponde cominciando con una lunga biografia, che si può qui riassumere per sommi capi: figlio d’un veneziano, Giovanni Siviero, maresciallo dei carabinieri che nel 1911, anno della nascita di Rodolfo, comandava la stazione di Guardistallo, e d’una senese, Caterina Bulgarini, dal cognome che tradisce probabili origini aristocratiche (le medaglie col profilo dei genitori, che Rodolfo commissionò a Mario Moschi nel cinquantesimo del loro matrimonio, sono esposte al Teatro Marchionneschi), si distinse fin da giovanissimo come studente brillante, che coltivava passioni artistiche e letterarie e aveva persino ambizioni da poeta (a venticinque anni, nel 1936, pubblicò con Le Monnier una raccolta, La selva oscura, di cui in mostra è esposto un raro esemplare: era convinto che fosse un’opera fondamentale per le sorti della poesia italiana del tempo, lo scarso successo di pubblico e di critica gli avrebbe dimostrato l’inverso). Nel 1937 lo sappiamo già informatore per il Ministero degli Esteri, inviato in Germania sotto copertura, e poi espulso l’anno dopo. Allontanatosi via via dal fascismo, avrebbe in seguito prestato la sua esperienza d’informatore all’intelligence anglo-americana a Firenze, e dopo l’8 settembre avrebbe partecipato attivamente alla guerra di liberazione: il suo compito era quello di monitorare le operazioni del Kunstschutz, il corpo militare tedesco ufficialmente incaricato di proteggere i beni culturali, nei fatti l’unità che sottoponeva a sistematici saccheggi i territori occupati. Finita la guerra, in virtù dei suoi contatti e della sua esperienza, gli venne affidato dal governo l’incarico di far tornare in Italia le opere ch’erano passate di là delle Alpi, secondo il principio per cui non soltanto avrebbero dovuto far ritorno le opere trafugate durante la guerra, ma anche quelle che l’Italia aveva mandato illegalmente in Germania prima del conflitto dietro pressione dei gerarchi nazisti. Un’attività che sarebbe continuata anche dopo il ritiro di Siviero (trascorse gli ultimi anni della sua esistenza come presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze, ruolo che ricoprì con passione e spirito riformatore), fino al 1989, e poi per qualche tempo nel biennio 1995-1996.


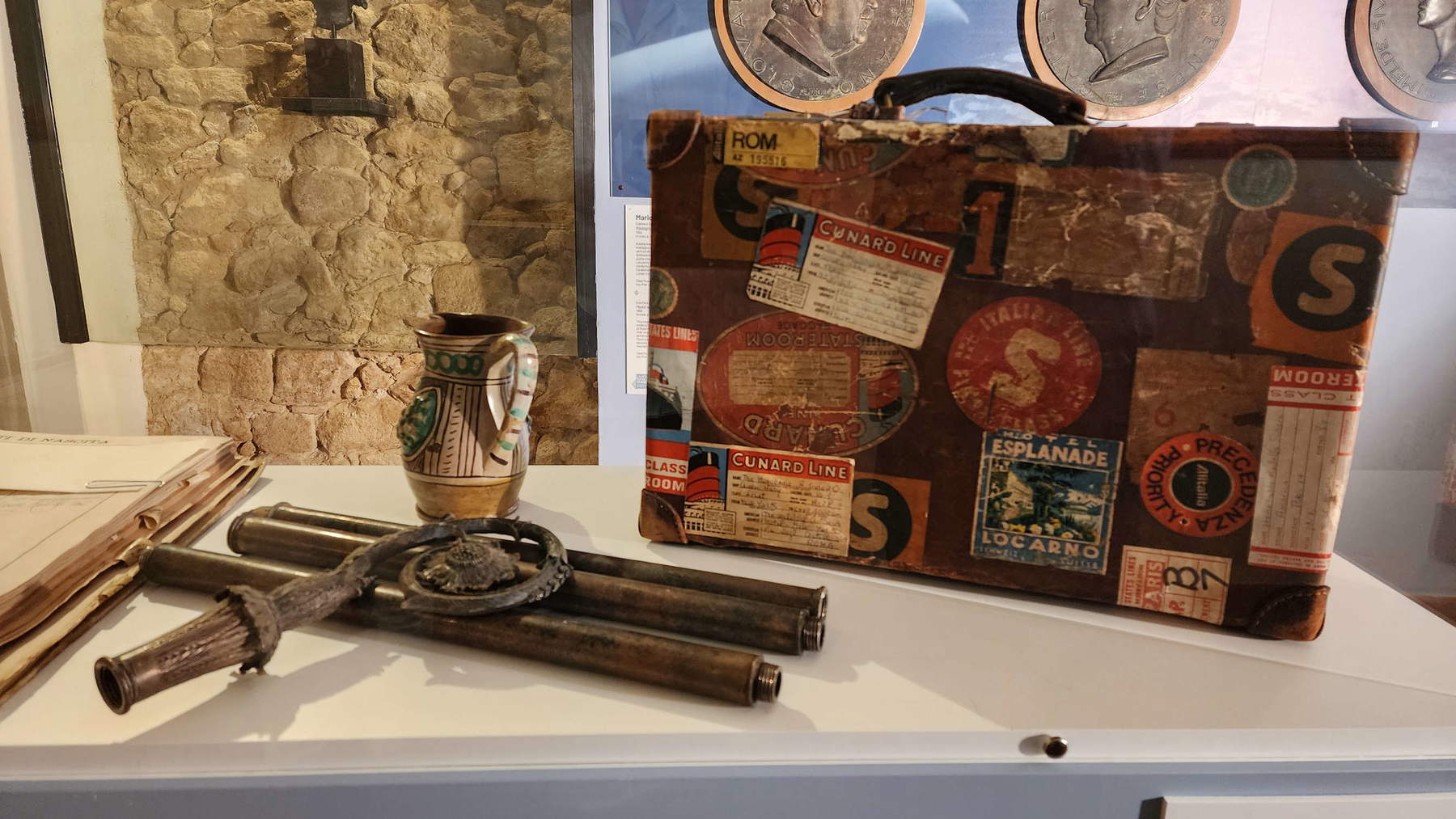



Casa Siviero rappresenta a oggi l’eredità più concreta del lavoro di questo monument man italiano, com’è ormai d’uso appellarlo (escluse, naturalmente, le opere che possiamo vedere nei musei di tutta Italia grazie a lui): l’edificio che fu suo centro operativo e sua dimora è oggi di proprietà della Regione Toscana grazie al suo lascito. “Non solo un atto di generosità”, spiegano i pannelli in mostra: “soprattutto l’espressione concreta dell’idea che l’arte non debba essere un bottino di guerra da rivendicare, ma un patrimonio inalienabile dell’identità culturale di un popolo”. Al Teatro di Guardistallo, qualche suggestione biografica: le succitate medaglie dei genitori, quella che commemora il Discobolo Lancellotti ch’è forse la più famosa delle restituzioni favorite da Rodolfo Siviero assieme alla Danae di Tiziano, e poi il registro dell’anagrafe con la sua data di nascita, il ritratto che gli fece Quinto Martini, e un curioso cimelio quale è la valigia diplomatica, marca Franzi, che accompagnò Siviero nei suoi tanti viaggi alla ricerca delle opere che i nazisti avevano portato via dall’Italia. A Bibbona, invece, ci sono le opere della collezione Siviero, un corpus piuttosto consistente per offrire al pubblico la seconda parte della risposta su chi fosse Siviero, per far emergere dalla foschia questo singolare personaggio di cui forse il pubblico sa ancora poco. E varrà la pena sottolineare, per inciso, che il Comune Vecchio di Bibbona torna per il terzo anno consecutivo a ospitare, nelle sue belle, riposanti sale, una mostra di solida qualità, com’era stato l’anno scorso per quella sugli etruschi e l’anno prima ancora per quella coi dipinti dei macchiaioli prestati dalla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti per gli Uffizi Diffusi: davvero mirabili l’impegno del Comune di Bibbona e il modello che offre a chiunque voglia seguirne l’esempio.
Cosa dice, dunque, di Siviero il nucleo di dipinti scelto per la mostra? La selezione appare investita d’una doppia funzione: intanto, offrire un sunto delle passioni collezionistiche di Rodolfo Siviero, che a volergli bene andrebbero definite “eclettiche”. C’è un po’ di tutto, nella sua raccolta. La mostra parte da un Autoritratto in costume da torero di Giorgio de Chirico, che attesta la confidenza che il funzionario aveva col pittore: Siviero acquistò il quadro nel 1940, per la somma di 80mila lire (70mila euro di oggi, la cifra è giustificata dal fatto che il dipinto è ritenuto un capolavoro), direttamente dall’artista, col quale aveva una certa familiarità, anche perché durante la guerra aveva salvato, in maniera rocambolesca, facendoli sequestrare con uno stratagemma, i dipinti che stavano in casa sua e che rischiavano di finire in Germania. De Chirico è anche sintesi di quel che Siviero pensava in fatto d’arti contemporanee: refrattario a qualunque astrattismo, convinto che l’avanguardia del suo tempo fosse solo “confusione intellettuale” e “rumore” destinato a passare “per naturale inconsistenza”, e che l’unica forma d’arte contemporanea plausibile fosse quella figurativa, quella in grado di far esprimere all’artista il proprio talento mimetico. C’è anche un altro autoritratto, tradizionalmente attribuito a De Chirico, sebbene mai riconosciuto come autografo dall’artista (c’è il sospetto che il pittore lo rifiutò in reazione ad alcuni dissapori con Siviero legati a una causa contro la sua galleria, ma gli studi più recenti hanno confermato che dovrebbe effettivamente trattarsi d’un’altra mano), e però utile per ricostruire i rapporti di Siviero, dacché in precedenza appartenuto a Maltide Forti e Giorgio Castelfranco, coppia di amici ebrei che vennero aiutati dal funzionario durante la guerra e che nel 1944 gli vendettero quella ch’è oggi Casa Siviero (e quando ci abitavano i Castelfranco, peraltro, per alcuni anni ospitò anche De Chirico, ch’era sempre stato un loro protégé).
E poi ci sono i paesaggi di Jan van Bloemen che Siviero aveva acquistato a Roma, che assieme alle tele di Ugo Pignotti rivelano l’inclinazione del collezionista per la pittura di paesaggio (e, in particolare, per i paesaggi che gli erano familiari), ci sono oggetti liturgici (turiboli, pissidi, ostensori) che ci parlano, invece, d’un uomo devoto, alla ricerca d’una fede fatta a suo modo: s’ha quasi l’impressione d’un fedele spinto dalla necessità d’avere qualcosa davanti agli occhi, dal bisogno di toccare gli arnesi della propria devozione, eppure al contempo animato da una spiritualità semplice, pura, quasi contadina, legata a pochi simboli ricorrenti. La presenza di dipinti a tema sacro nella raccolta probabilmente è da leggere sia come riflesso della devozione di Siviero, sia come evidenza concreta della sua passione per l’arte rinascimentale. Ecco allora un Matrimonio mistico di santa Caterina che Siviero comprò nel 1944 per 40mila lire (poco più di 3mila euro attuali), e una ben più interessante Natività ritenuta di Jacopo del Sellaio all’epoca di Siviero, ma poi più correttamente riferita al cosiddetto Maestro della Natività Johnson, anonimo in cui è stato in seguito riconosciuto il fiorentino Domenico di Zanobi, allievo di Filippo Lippi.







In un’ultima sala, da sola, è stata posizionata una grande tela di Pietro Liberi, la Verità liberata dalle catene, che venne acquistata da Siviero in un’asta nel 1970, ch’è stata inserita quasi come compendio delle attività del funzionario, una sorta d’allegoria di quella verità, si legge in mostra, “ricercata in una vita spesa interamente nel recupero del patrimonio storico-artistico disperso prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, verità che si è liberata ‘dai vincoli del tempo crollato’”. Il dipinto, pertanto, pare quasi una sorta di coronamento, una dichiarazione: come a dire che, nonostante tutto, l’obiettivo suo ultimo era quello di levar le catene alla verità. Una forma di rivendicazione che certo s’attaglierebbe alla spavalderia del personaggio, etichettato spesso come “controverso” (questo l’aggettivo che gli affibbiano mille biografie) per i suoi trascorsi al servizio del fascismo, per le sue ambiguità politiche, per i suoi metodi spregiudicati.
L’idea di Siviero che la mostra intende far emergere è, tuttavia, di segno totalmente opposto rispetto a quella che di solito alberga nell’immaginario di chi lo ha sentito nominare giusto per la sua attività di recupero nel dopoguerra. Attività che in realtà, come detto sopra, Siviero portò avanti per anni. Un mito, quello dell’“agente segreto dell’arte” (per adoperare un’espressione tremenda ma che tanti hanno adoperato per incollare un’etichetta addosso a Rodolfo Siviero) che la mostra cerca di scardinare, chiarendo in maniera inequivocabile, da un lato, che il grosso della sua azione si svolse dopo il periodo clandestino del conflitto, e dall’altro che la sua azione ebbe un respiro ben più vasto di quello che solitamente si tende ad attribuirgli. La mostra ascrive a Siviero, intanto, il merito d’aver fatto valere in sede diplomatica l’argomento che la Germania dovesse restituire all’Italia anche le opere che erano partite prima dell’armistizio di Cassibile (ovvero il termine a quo stabilito dal trattato di pace firmato a Parigi nel 1947): Argan avrebbe in seguito ricordato che Siviero “si giovò delle lettere che comprovavano come l’autorizzazione agli espatrii fosse sempre stata data da organi incompetenti, come il capo del governo o il ministro degli Esteri e come perciò, a meno di legittimare gli arbitrii di un governo autoritario, dovessero considerarsi illegali: accettando questa tesi, gli alleati hanno implicitamente affermato sia l’illegalità sostanziale di qualsiasi governo autoritario sia la sostanziale estraneità del patrimonio culturale rispetto ad ogni criterio di opportunità politica”). E poi gli attribuisce l’idea d’aver visto nella difesa dell’arte un gesto politico d’estrema rilevanza, non per niente poi commemorato con le medaglie commissionate a Mario Moschi nel 1981: “non solo la ricostituzione materiale di un patrimonio violato, ma un atto di riscatto morale, una redenzione del passato totalitario”. I pezzi esposti tra Bibbona e Guardistallo restituiscono, certo, l’immagine d’un uomo dai disordinati appetiti collezionistici, un uomo che aveva un’altissima concezione di se stesso, che si vedeva quasi come una sorta di mecenate rinascimentale, o qualcosa del genere, ma sono anche una sorta di sintesi della missione di cui si sentiva investito e che ha posto le basi per un’Italia nuova.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.