Si è conclusa la prima fase della nuova campagna di indagini archeologiche subacquee nel lago di Mezzano, tornate operative dopo un lungo periodo di sospensione. Il piccolo specchio d’acqua di origine vulcanica, incastonato nella caldera di Latera nel cuore della Tuscia viterbese, torna così al centro dell’attenzione per l’importanza del suo insediamento palafitticolo sommerso, databile tra la fine del Bronzo Antico e il Bronzo Recente (circa 1700–1150 a.C.). L’intervento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, è stato condotto dal Servizio Archeologia Subacquea insieme a un’équipe multidisciplinare composta da archeologi, restauratori, tecnici specializzati e con la collaborazione dell’Aliquota Carabinieri Subacquei di Roma. L’obiettivo è documentare, tutelare e valorizzare uno dei siti protostorici più significativi dell’Italia centrale.
Finora sono stati mappati oltre 600 pali emergenti dal fondale argilloso, su circa un terzo dell’area nota dell’insediamento. Questi dati offriranno elementi preziosi per ricostruire non solo la struttura dell’abitato, ma anche aspetti della vita quotidiana di una comunità dell’Età del Bronzo.
Dopo il rilievo morfobatimetrico dell’intero bacino, sono stati eseguiti interventi mirati che hanno permesso di chiarire meglio la formazione del deposito archeologico, la cui comprensione è essenziale per interpretare correttamente i reperti rinvenuti in un contesto ancora parzialmente sconosciuto.
Le indagini hanno interessato anche zone in cui si conserva ancora il deposito antico, coperto da un spesso strato di argilla compatta, rimosso con l’uso della sorbona in condizioni di visibilità ridotta e acqua molto fredda. È emerso che non ovunque l’assenza di pali visibili corrisponde a un’assenza di materiali: in molti casi, il deposito archeologico giace al di sotto di livelli di argilla più recenti, accumulatisi su un fondale irregolare e disomogeneo.
Dallo studio delle profondità, comprese tra i 2,5 e i 10 metri, si deduce che l’insediamento lacustre abbia seguito nel tempo le variazioni del livello del lago, nel corso di circa sei secoli. Il materiale rinvenuto — caduto o rotolato da una probabile struttura lignea, in parte anche incendiata — mostra una stratificazione coerente: i reperti più antichi si trovano negli strati inferiori, quelli più recenti in prossimità della superficie. Non sembrano emergere aree abitative distinte, ma piuttosto una distribuzione continua dei pali e dei materiali, che occupano almeno un quarto del lago seguendo un andamento “concentrico” più che lineare.


Tra i ritrovamenti più significativi figura un consistente gruppo di manufatti in bronzo, rinvenuti in zone caratterizzate dalla presenza di pietre laviche — forse antiche frane — sotto le quali sono stati individuati numerosi pali fino quasi al livello dell’attuale riva. Si tratta di oltre 25 oggetti in bronzo in eccellente stato di conservazione, grazie al contatto con la parte superiore dell’argilla che ne ha impedito l’ossidazione.
Tra questi spiccano asce ad alette, punte di lancia, fibule, anelli, uno spillone e un falcetto perfettamente conservati, insieme a frammenti di “panelle” o lingotti di bronzo, che suggeriscono la presenza di antiche officine metallurgiche. Particolarmente notevole anche la scoperta di una borchia forata decorata con un motivo solare, di grande valore simbolico. Nelle zone dove i metalli risultavano in giacitura secondaria, ossia in posizione più superficiale, l’utilizzo del metal detector in collaborazione con i Carabinieri subacquei si è rivelato determinante, sia per individuare nuovi reperti sia per prevenire possibili azioni di scavo clandestino. Grazie all’intervento immediato dei restauratori, tutti i manufatti sono stati protetti e consolidati per conservarne l’aspetto originale. Alcuni presentano tracce di combustione, forse legate al crollo di strutture lignee incendiate.
Le prossime campagne di scavo punteranno a completare la mappatura dei pali e a collegare i materiali ceramici e metallici alle diverse zone del sito, in base alle fasce di profondità. Lo scavo stratigrafico consentirà inoltre di chiarire la formazione dei depositi, in molti casi ben sigillati da strati di argilla compatta.
Non è escluso che parte dei materiali più superficiali, trovati sopra l’argilla, provengano invece dalle sponde del lago, dove l’emissario Olpeta continua tuttora a erodere antichi livelli d’insediamento già segnalati in passato.

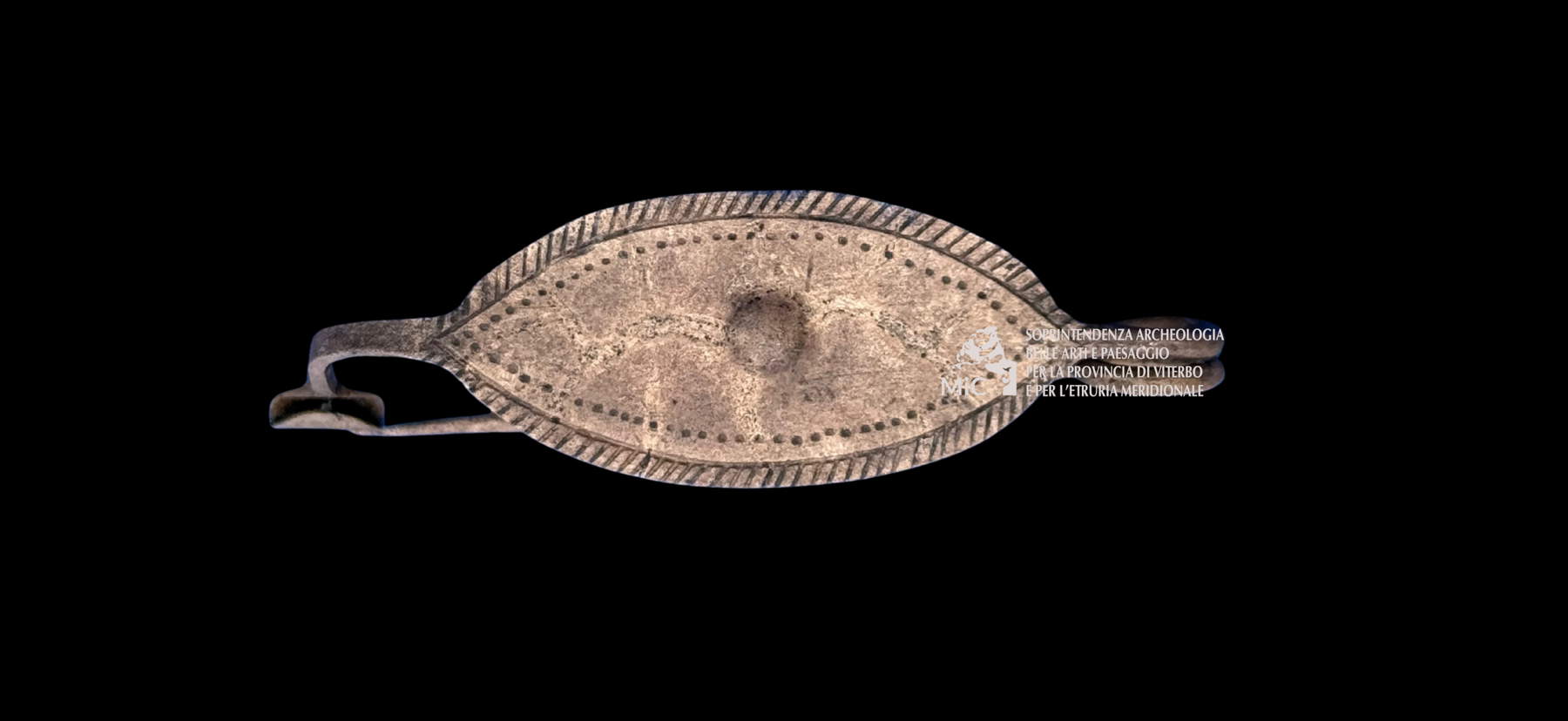
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.