A Siena, nel cuore del complesso monumentale di Santa Maria della Scala, torna visibile un importante capitolo della pittura trecentesca. Dopo un lungo e accurato restauro, è stato restituito alla collettività il ciclo di affreschi della Tebaide, attribuito al pittore senese Lippo Vanni (Siena, attivo tra il 1340 e il 1375) e databile ai primi anni Quaranta del XIV secolo. L’intervento, promosso e realizzato dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni, ha riportato alla luce un’opera di eccezionale valore storico e artistico, permettendo di riscoprire un raro esempio di iconografia monastica ed eremitica nel contesto toscano del Trecento.
Il complesso pittorico, che decorava l’antico locale di accesso alla Compagnia dei Disciplinati, oggi sede storica della Società promotrice del restauro, sarà aperto al pubblico a partire dal 7 novembre 2025 e inserito stabilmente nel percorso di visita del museo di Santa Maria della Scala. La presentazione ufficiale è prevista per il 6 novembre alle ore 16.00, nella Sala Sant’Ansano, con la partecipazione dei restauratori e degli studiosi che hanno seguito il progetto.
La storia della riscoperta di questo ciclo di affreschi è relativamente recente. Nel 1999, durante i lavori di recupero e restauro dell’Ospedale condotti dall’architetto Guido Canali, furono individuate le prime tracce di pittura sotto le imbiancature che ricoprivano le pareti. Le porzioni visibili rivelavano la presenza di scene monocrome in ocra rossa, raffiguranti episodi di vita eremitica e santi padri nel deserto di Tebe.








Pochi anni più tardi, la rimozione di un controsoffitto permise di portare alla luce un’estensione più ampia del ciclo pittorico, anche se ancora parzialmente coperta da strati di calce e residui di intonaco. Fu allora che lo storico dell’arte Alessandro Bagnoli, nel 2001, pubblicò un primo studio preliminare che rese nota la scoperta e ne ipotizzò l’attribuzione a Lippo Vanni, artista attivo a Siena nella prima metà del XIV secolo e autore di importanti commissioni religiose e civili.
L’intervento di restauro vero e proprio è stato avviato solo nel 2021, grazie al contributo economico di Robert Cope, presidente della Fondazione Vaseppi, che ha finanziato la completa scopertura, il consolidamento e la pulitura degli affreschi. Il progetto ha permesso di recuperare nella sua interezza la decorazione murale, restituendo leggibilità e profondità al ciclo pittorico e consentendo un’analisi più precisa delle sue caratteristiche stilistiche.
La Tebaide rappresenta un soggetto di grande fascino e rarità nella pittura medievale italiana. Ambientata nel deserto di Tebe in Egitto, narra episodi della vita quotidiana dei primi eremiti cristiani e dei santi Padri del deserto, tra cui san Paolo Eremita, sant’Antonio Abate e san Girolamo. Le scene si ispirano alle Vite dei santi Padri, opera di letteratura religiosa diffusa nel Medioevo e tradotta in volgare intorno al 1330 dal domenicano pisano fra’ Domenico Cavalca, che contribuì alla fortuna del tema nel mondo monastico e confraternale.
Nel ciclo senese, la narrazione non segue una sequenza lineare, ma si sviluppa come una serie di episodi isolati immersi in un paesaggio roccioso e spoglio, punteggiato di celle e grotte. I monaci vi compaiono intenti in atti di meditazione, preghiera, lavoro e penitenza, delineando un’immagine corale della vita ascetica. L’impianto iconografico, privo di riferimenti architettonici complessi, è concepito per suggerire la quiete del deserto e la distanza dal mondo, in perfetta sintonia con la destinazione dell’ambiente originario.
La Compagnia dei Disciplinati, infatti, era una confraternita laica dedita alla preghiera e alle pratiche penitenziali. Nello stesso locale che ospita la “Tebaide”, i confratelli si preparavano ai riti di flagellazione e meditavano sulla condizione umana, assistiti dalle immagini di santi ed eremiti che fungevano da exempla virtutis: esempi di purezza e sacrificio spirituale contrapposti al peccato e alla corruzione terrena.
Il valore di questo ciclo non risiede solo nella qualità pittorica, ma anche nella sua coerenza tematica e simbolica. Lippo Vanni traduce in immagini il linguaggio morale e teologico della spiritualità trecentesca senese, rendendo tangibile la ricerca di salvezza attraverso l’isolamento e la penitenza. La tecnica prevalente, basata sull’uso del monocromo in ocra rossa, conferisce all’insieme un tono sobrio e meditativo, lontano dai fasti del colore, e accentua la dimensione spirituale del racconto. L’effetto visivo, al tempo stesso essenziale e intenso, restituisce il senso di un’arte al servizio della devozione, nata per la contemplazione più che per la rappresentazione pubblica.



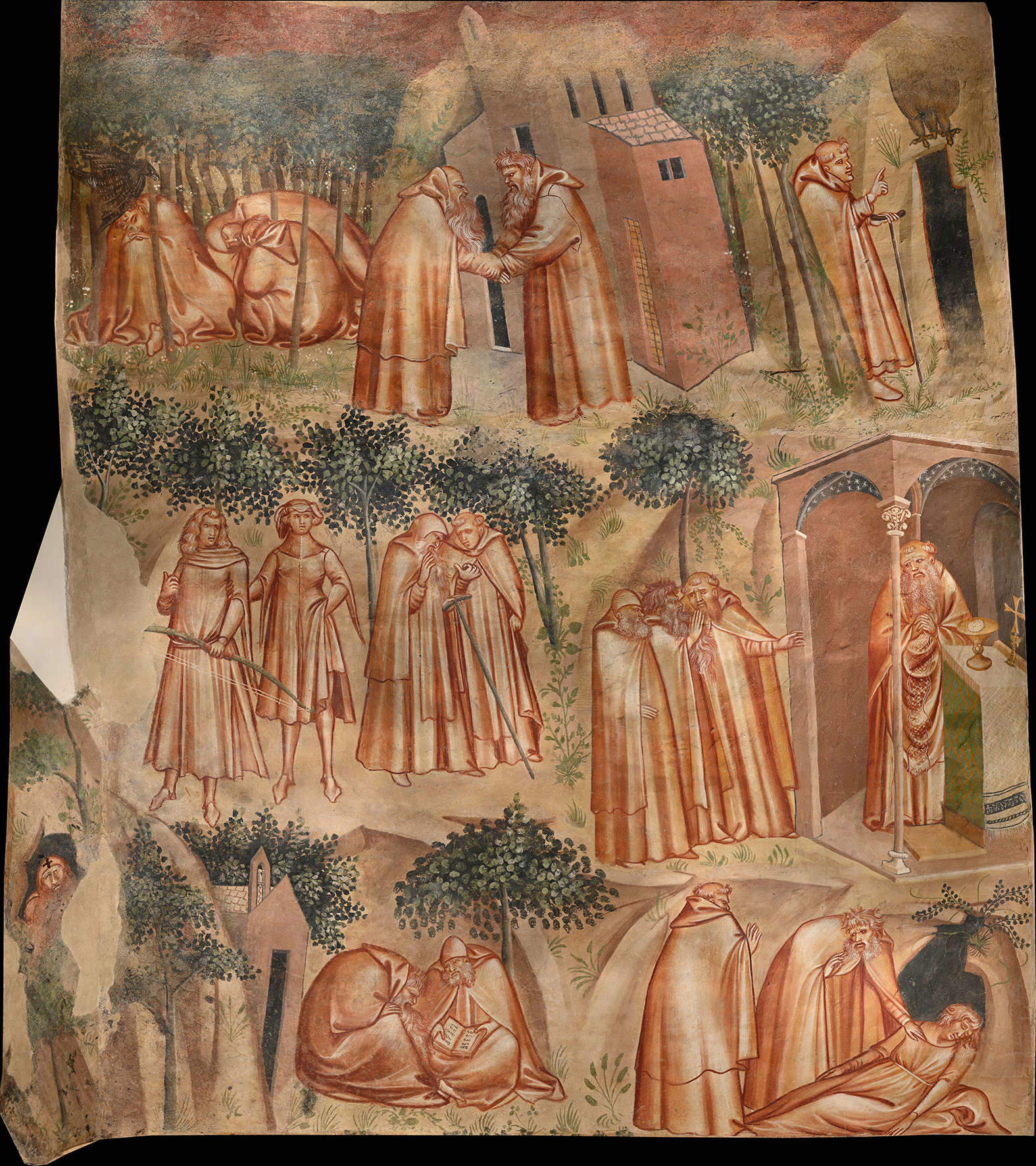
Con la conclusione dei lavori, la Tebaide ritrovata entra a far parte del percorso espositivo del Complesso Museale di Santa Maria della Scala, uno dei poli culturali più significativi della città, che già custodisce importanti testimonianze di arte medievale e rinascimentale. L’apertura al pubblico del ciclo consente di ampliare la conoscenza della pittura senese del Trecento e di contestualizzarla nel più ampio panorama della spiritualità confraternale toscana.
Il progetto rappresenta anche un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, come la Società di Esecutori di Pie Disposizioni, realtà antica che da secoli svolge un ruolo attivo nella tutela del patrimonio cittadino, e la Fondazione Vaseppi, il cui sostegno ha reso possibile la restituzione di un capolavoro dimenticato.
Dal 7 novembre, il pubblico potrà ammirare da vicino questo straordinario ciclo di affreschi, riscoprendo un luogo dove arte e spiritualità continuano a dialogare nel silenzio delle antiche volte del Santa Maria della Scala. Informazioni su orari e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.santamariadellascala.com.
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.