Dall’11 giugno al 3 ottobre 2025 la Galleria Christian Stein a Milano ospita per la terza volta una mostra personale di Stefano Arienti (Asola, 1961), artista tra i più riconoscibili del panorama contemporaneo italiano. A fare da cornice all’esposizione Ut pictura poësis è il salone neoclassico della sede milanese della galleria: uno spazio affacciato su un giardino appartato dove la vegetazione alta e matura filtra la luce e introduce nell’ambiente interno una costante vibrazione atmosferica.
Arienti aveva già esposto in questo stesso luogo nel 2019 e nel 2021, con due progetti centrati sulla trasformazione poetica di immagini fotografiche personali, spesso banali, alle quali restituiva uno statuto estetico attraverso tecniche ibride: carte stropicciate, superfici graffiate, rilievi e abrasioni. In quei lavori, il rapporto fra cultura visiva e mondo naturale si articolava in un equilibrio precario ma fertile, che metteva in discussione i dualismi tradizionali. La natura, l’umano, l’urbano, il tecnologico: tutto si trovava sullo stesso piano di una visione non gerarchica, dove il gesto artistico diventava strumento di sospensione del conflitto.

“Utilizzando delle tecniche si possono ottenere dei risultati sempre differenti ... ho cercato in questi anni di dimostrare che si può fare arte, poeticamente, con un gesto minimo. Che quel gesto lì, anche un poco ottuso e magari ripetitivo, è cruciale”, dice Arienti. “Lo spazio aulico di Palazzo Cicogna, con la sua vista segreta sul giardino, incornicia una sequenza di quattro tempi sovrapposti: classico, rinascimentale, impressionista e contemporaneo. La storia, come la geografia, mi ha sempre incuriosito”.
“Le sue opere cominciano sempre da qualcosa che già esiste, ma che attraverso diverse tecniche subisce una rielaborazione, trasformandosi in qualcosa di nuovo e inedito”, scrive Chiara Bertola, direttrice della GAM di Torino. “Conferma lui stesso in un’intervista che non avrebbe mai «prodotto niente di nuovo, perché tutta la creatività è già disponibile: bisogna soltanto avere l’attenzione di andarla a scoprire e farla diventare qualcosa di personale». Arienti è più pittore che scultore: lavora con le immagini e lui stesso si considera pittore «perché prendo prevalentemente delle decisioni pittoriche, sebbene non dipinga in senso stretto». Lavora però con i valori tattili della pittura, spesso intervenendo sulle figure dipinte o fotografate ‘implementandole’ o ‘aumentandole’ con la plastilina, con il pongo, con i puzzle. Aggiunge materia all’immagine, per trasformarla e renderla più tattile e più viva”.

Con Ut pictura poësis, titolo che evoca il parallelo tra arte e poesia, Arienti compie un ritorno alle origini, ma non in senso regressivo. Piuttosto, si tratta di un rinnovamento della pittura che passa attraverso la memoria, personale e collettiva, dei gesti e delle immagini fondative. L’artista presenta due serie di lavori che, pur formalmente distinte, si richiamano a vicenda in un gioco di echi e corrispondenze. Da una parte, troviamo le sue celebri composizioni realizzate con il pongo, materia povera e infantile, ma capace di una sorprendente densità tattile e cromatica; dall’altra, i grandi teli da cantiere, antipolvere, leggeri, semitrasparenti, che accolgono tracce pittoriche appena percettibili, quasi evanescenti.
Le opere al pongo rappresentano una riflessione sul paesaggio e sulla pittura come evento sensibile. Arienti parte da dipinti impressionisti noti, in particolare da Monet, scelto per l’insistenza con cui ha cercato di catturare l’inafferrabile, e li ricostruisce manipolando la materia plastica sulla superficie fotografica. L’immagine originale si dissolve ma sopravvive come impressione, come eco visiva. Il colore ritorna a essere corpo e materia viva.
“Tutto è mirabile, e ogni giorno la campagna è più bella, ed io sono stregato dal paese”, scrisse Monet al suo mercante parigino Durand-Ruel.
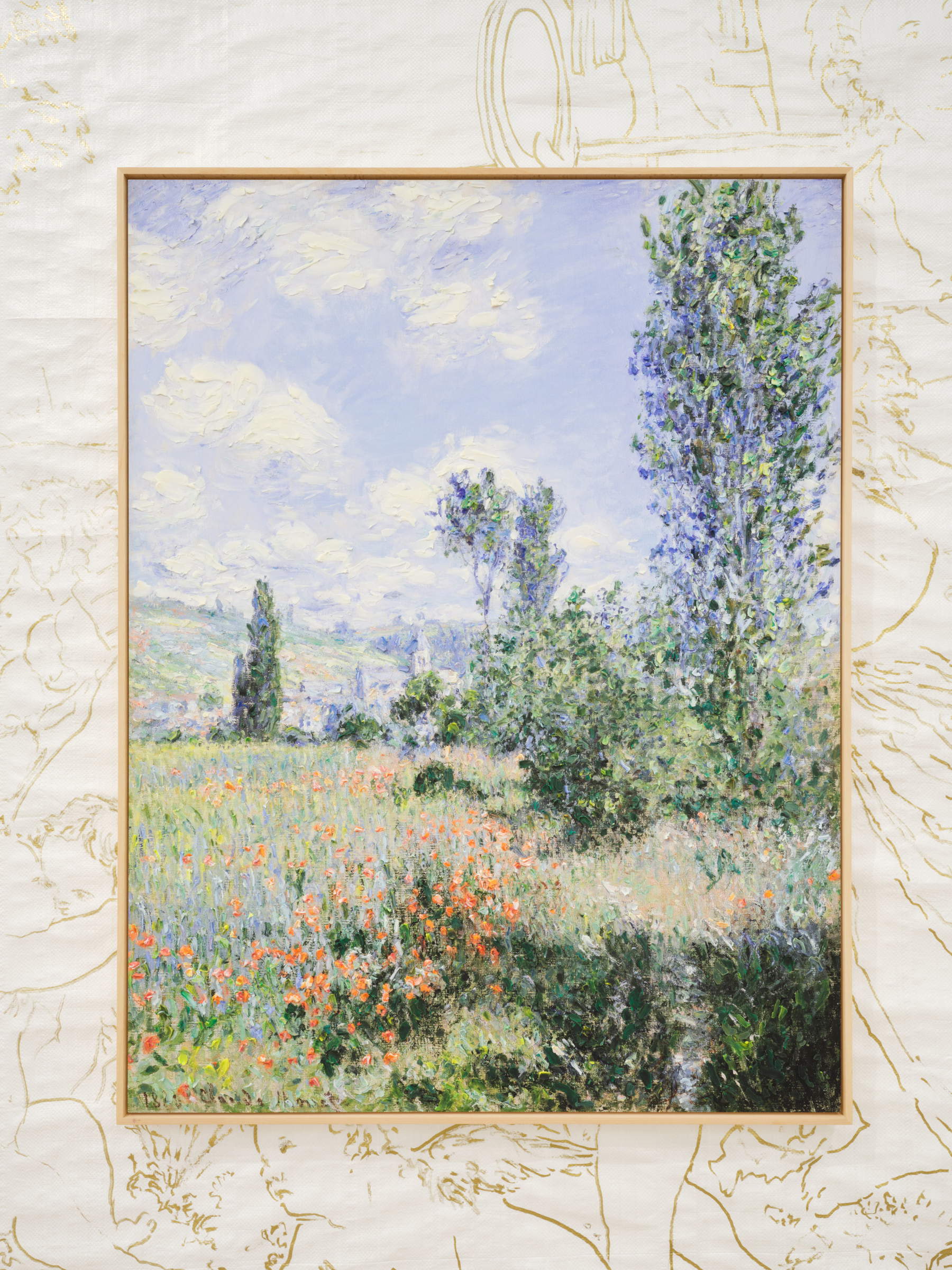
La scelta del pongo, apparentemente ludica, recupera il tempo libero e originario dell’infanzia, in cui forma e significato nascono da un’intuizione primitiva, non mediata, e restituiscono all’atto creativo un senso di scoperta e incanto.
A questi lavori si affiancano grandi teli antipolvere stesi a parete: superfici diafane, su cui affiorano segni minimi, tracciati leggeri, che paiono evaporare nell’aria. Arienti li definisce “più simili a grandi arazzi disegnati, che si impaginano spontaneamente nell’architettura della sala”, ed è vero: sono opere che invitano l’osservatore a rallentare, a lasciarsi attraversare dalla luce. L’artista ha qui rievocato la tecnica della sinopia e dello spolvero, quella fase del disegno preparatorio che precede l’affresco, facendo emergere non tanto un’immagine compiuta quanto la sua possibilità, il suo divenire. Come se ci trovassimo di fronte a un sogno che si sta per formare, o a una memoria che riaffiora.
Su questi fondali si stagliano poi le composizioni a pongo, accese e corpose, che rimandano alla tradizione della grande pittura decorativa italiana. E qui, in un’ulteriore stratificazione, Arienti cita Tiziano, riprendendo i famosi cicli mitologici dipinti per il Camerino d’Alabastro del duca Alfonso d’Este: Bacco e Arianna, il Festino degli dei, il Baccanale degli Andrii, la Festa degli amorini. Temi profani, tratti da Ovidio e Filostrato, in cui l’ebbrezza, l’amore e la musica diventano metafore della bellezza e della fugacità. Arienti rielabora, reinterpreta, smonta e ricompone.

L’artista agisce sempre su almeno tre livelli: manipola materiali e tecniche con curiosità sperimentale; raccoglie, cataloga, ricicla immagini come un collezionista enciclopedico; e infine, ed è forse questo il gesto più radicale, rinnova il linguaggio della pittura partendo dalla sua crisi. Non per chiuderla, ma per abitarla poeticamente.
| Titolo mostra | Ut pictura poësis | Città | Milano | Sede | Galleria Christian Stein | Date | Dal 11/07/2025 al 03/10/2025 | Artisti | Stefano Arienti | Temi | Arte contemporanea |
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.