Riesce difficile negare che questo momento storico sia particolarmente felice per i cosiddetti “pittori della realtà”, se ancora c’è da usare quella formula, inventata negli anni Trenta e poi fatta sua nel 1953 da Roberto Longhi che l’ha resa celebre, per indicare tutti quegli artisti che tra il Sei e il Settecento, soprattutto in area lombarda, si dedicarono a una pittura fondata su di una nuova idea di “realtà”, un’idea veristica la potremmo dire, priva d’intenti moralistici, allegorici, bozzettistici, un’idea di realtà seriamente vicina al quotidiano degli ultimi. C’è, intanto, un forte interesse del mercato, e quando esce qualcosa di buono d’un Ceruti, d’un Cipper, d’un Bellotti, d’un Cifrondi o d’uno di quei tanti anonimi che praticarono lo stesso genere, non è raro veder le aggiudicazioni raddoppiare, triplicare, quadruplicare le stime. Certo, parliamo di risultati tutto sommato modesti rispetto a quelli d’altri Old Masters, ma a volte capita di vedere martelli che fissano cifre a cinque zeri, e non è neppure più raro vedere copiosi dispiegamenti di pittori della realtà nelle botteghe degli antiquarî o alle fiere (Salamon, per dire, ha portato alla Biennale dell’Antiquariato di Firenze dell’anno scorso l’ultima delle tele del ciclo di Padernello di Ceruti rimasta sul mercato, opera notificata, che in quell’occasione veniva proposta a un milione e centomila euro). E poi c’è il lavoro dell’industria espositiva che ha ulteriormente ravvivato la fiamma della pittura della realtà, e il capitolo più recente di quella che potrebbe già assumere le sembianze d’una sorta di cronologia della riscoperta di questi pittori è la mostra che le Gallerie dell’Accademia di Venezia dedicano a Pietro Bellotti, Pietro Bellotti e la pittura del Seicento a Venezia. Stupore Realtà Enigma. È la prima di sempre sul pittore gardesano ma è la quarta in tre anni sui pittori della realtà, preceduta da Ceruti a Brescia e Cifrondi a Clusone nel 2023 e da Cipper a Trento la scorsa primavera. Stavolta però è un po’ diverso.
Ceruti è pittore noto, ha conosciuto negli anni Ottanta una certa fortuna culminata nel 1987 con la monografia di Mina Gregori e aveva bisogno d’un lavoro che definisse meglio la sua fisionomia, rileggesse meglio il portato simbolico della sua arte (ch’era peraltro già stato in certa misura intuito da Manganelli, autore d’una memorabile recensione della mostra che s’era tenuta a Brescia proprio nel 1987), e riconsiderasse la rilevanza della sua personalità, non senza liberarlo da quel nomignolo, “Pitocchetto”, che forse gli ha procurato più danni che profitto. Cifrondi ha beneficiato d’una piccola mostra, una trentina d’opere, che ha fornito l’occasione per una mappatura, peraltro disponibile online, di tutte le sue opere rimaste tra il bresciano e il bergamasco. E su Cipper serviva una mostra che ripulisse un poco la sua immagine, condannata per un certo periodo dalla damnatio della critica novecentesca, e per giunta offuscata da un diluvio di opere di scarsa qualità che negli anni gli sono state attribuite con eccessi di leggerezza: quella del Castello del Buonconsiglio non era la prima mostra di sempre sul pittore austriaco, ma è stata di sicuro la migliore. Indagare Bellotti, invece, è come sfogliare le pagine d’un quaderno che ha già qualche pagina ordinatamente compilata (la prima, e per adesso unica, monografia su di lui è quella pubblicata da Luciano Anelli nel 1996, fondamentale perché ha avuto il merito d’ordinare una messe di documenti e di materiali che hanno offerto le basi per le ricerche successive), ma dove restano ancora tanti fogli bianchi, lisci, intonsi.
E ci sono tanti fogli bianchi perché, al contrario d’altri pittori della realtà, Bellotti ha conosciuto cambiamenti repentini durante la sua carriera, ha frequentato diversi generi, ha avuto una dimensione internazionale, è approdato alla pittura del quotidiano in una fase relativamente avanzata della sua carriera, e s’è formato in una città, Venezia, tradizionalmente lontana dalla terragna Lombardia dei contadini, dei portaroli, dei bevitori. Senza contare che di Pietro Bellotti si hanno poche notizie biografiche, e che molti nodi della sua carriera possono essere ricostruiti soltanto su base ipotetica, immaginando le sue frequentazioni, i suoi interessi, le sue conversazioni. E stiamo poi parlando d’un pittore nato trentanove anni prima di Cipper e settantatré prima di Ceruti. Una specie di padre. O di nonno. Con una fisionomia tutta sua, che però ha degl’innegabili punti di tangenza con le generazioni che sarebbero arrivate dopo. Il fascino di Bellotti risiede proprio nella sua versatilità e nella sua curiosità, che sono forse i tratti più riconoscibili del suo carattere e che gli vengono in un certo senso riconosciuti anche dai tre giovani curatori della mostra veneziana, Francesco Ceretti, Michele Nicolaci e Filippo Piazza, che con la terna di sostantivi scelti per il sottotitolo han cercato di riassumere, in tre parole, il temperamento di questo artista così seducente. Stupore, quello che noi proviamo davanti ai suoi lavori, e quello che provava lui quando vedeva qualcosa di nuovo, qualcosa che catturava la sua attenzione. Realtà, per ovvie ragioni, di cui si dirà poi meglio più avanti. Enigma, perché Bellotti ha ancora molto da svelare, perché tanti suoi dipinti affrontano temi tutt’altro che convenzionali, perché la sua personalità non ha eguali nella pittura del Seicento e vien dunque da domandarsi donde gli derivassero tanta facilità d’invenzione, tanta capacità d’immedesimazione, tanto spirito d’osservazione.









I due autoritratti che i curatori han scelto di presentare in apertura di percorso, mai accostati prima d’ora, mirano effettivamente a stabilire fin dall’inizio l’anticonvenzionalità di Pietro Bellotti, perché nel modo in cui l’artista sceglie di raffigurarsi (in veste di “Stupore” e in veste di “Riso”: lo “Stupore”, peraltro, è un’acquisizione recente delle raccolte pubbliche, dacché comperato nel 2017 dallo Stato proprio per le Gallerie dell’Accademia) non c’è solo l’autoironia, non c’è solo l’attenzione al dato veristico (e quindi la descrizione perfetta delle rughe sulla fronte, dei riflessi della luce sull’armatura, dello scintillio sul bicchiere, del foglietto piegato che reca la sua firma, reminiscenza quattrocentesca, o del millimetro quadrato di pelle imberbe sopra al labbro, tra i due baffi), non c’è solo l’indiscutibile qualità d’un artista aggiornato, capace di fondere mirabilmente il neocinquecentismo che andava di moda nella Venezia di metà Seicento (e ch’è forse ancor più evidente nella Parca Atropo esposta sulla parete opposta, da mettere in relazione alla celeberrima Vecchia del Giorgione di più di centocinquant’anni prima, che s’ammira al piano di sopra del museo) e un naturalismo tagliente e sferzante che s’è voluto spiegare, in maniera del resto convincente, con un sincero interesse per il realismo di José de Ribera: c’è la volontà precisa di fare qualcosa di profondamente nuovo e profondamente radicale, e son queste le credenziali con cui Bellotti vien presentato al pubblico delle Gallerie dell’Accademia. Una specie di cometa impazzita, che illumina di punto in bianco il cielo di Venezia senza che si sappia bene da dove sia arrivata, anche perché il suo primo lavor noto, la Parca Lachesi arrivata in prestito dalla Staatsgalerie di Stoccarda, firmata e datata 1654, non è solo opera d’un pittore già maturo, già profondo, già sicuro dei suoi mezzi e già riformatore (Bellotti non prende una vecchia contadina abbronzata, con la pelle raggrinzita e cotta dal sole e lo scialle che le copre i capelli, come modello per costruire un’immagine della moira che svolge il filo della vita: la sua contadina è la parca Lachesi, senza imbellettamenti e senza trasfigurazioni), ma è anche un’opera che niente ha a che spartire con quello che poteva aver imparato dal maestro, quel Girolamo Forabosco che, dimostra il suo Ritratto di vecchia esposto accanto a un’intensa e quasi inquietante Vecchia velata di Bellotti, sapeva padroneggiare un realismo di marca rembrandtiana al pari del suo allievo, ma probabilmente questa Vecchia è da intendersi, o almeno così la intendono in mostra, come un’opera che s’aggiorna sulle novità introdotte proprio dal suo ex studente. Della Parca Lachesi, opera ch’ebbe una gran successo anche perché il tema ebbe una certa fortuna all’epoca, è esposta anche una delle tante repliche autografe (se ne conosce una dozzina all’incirca), che si distingue, scrive Ceretti in catalogo, “per un naturalismo leggermente più dispiegato, anzitutto apprezzabile nella restituzione materica più rotta che interessa sia l’incarnato rugginoso della parca, sia le meravigliose stoffe che le cingono il corpo”.
È questo il terreno su cui matura e cresce l’arte di Bellotti: una pittura stravagante, spregiudicata, anticonformista, pregna, nelle prime fasi della carriera, d’implicazioni allegoriche e filosofiche, aggiornata sui dibattiti letterarî del tempo, una pittura popolata di personaggi della mitologia, di streghe, di maghi, di filosofi, soggetti certo ricorrenti nell’arte di metà Seicento, ma ai quali Bellotti riesce a dare una marca propria. Le raffigurazioni dei filosofi (in mostra s’ammirano due versioni dello stesso Socrate e un Sapiente velato, tutti lavori databili alla seconda metà degli anni Sessanta, messi a confronto con un Democrito di Ribera e con un Filosofo di Luca Giordano, ma anche con un Filosofo tentato di Giovanni Battista Langetti, inserito sia per dimostrare come l’arrivo a Venezia del pittore ligure abbia inciso sugli sviluppi del tenebrismo lagunare, sia per render evidente la distanza tra la sua vecchiaia, eroica e retorica, e quella invece feriale di Bellotti), popolarissime all’epoca, sono utili per ricostruire i possibili punti di contatto con l’arte di José de Ribera, anche lui autore di diverse figure di vecchi filosofi in abiti umili e sdruciti se non logori: a Venezia, dove Bellotti s’era trasferito fin da giovanissimo lasciando la natia Roè Volciano sulle rive del lago di Garda, quando tutto il bresciano era territorio della Serenissima, poté sicuramente vedere i dipinti dello Spagnoletto registrati nelle collezioni veneziane, e soprattutto poté coltivare rapporti lavorativi, argomenta Filippo Piazza, coi diplomatici spagnoli operativi in laguna, con alcuni dei quali sappiamo che Bellotti ebbe contatti stretti. E ancora, l’artista gardesano poté aver assorbito elementi di cultura figurativa spagnola soggiornando e lavorando a Milano, città dove Bellotti, scrive Piazza, “trovò terreno favorevole e un ambiente ricettivo, in grado non solo di valorizzare la sua abilità nel realizzare i ritratti dal vero […] ma, al tempo stesso, di spingerlo a traguardare verso un realismo svuotato di qualsiasi carattere aneddotico e allegorico”. Ovvero, quel realismo del quotidiano che avrebbe contrassegnato tutta la seconda parte della sua carriera.




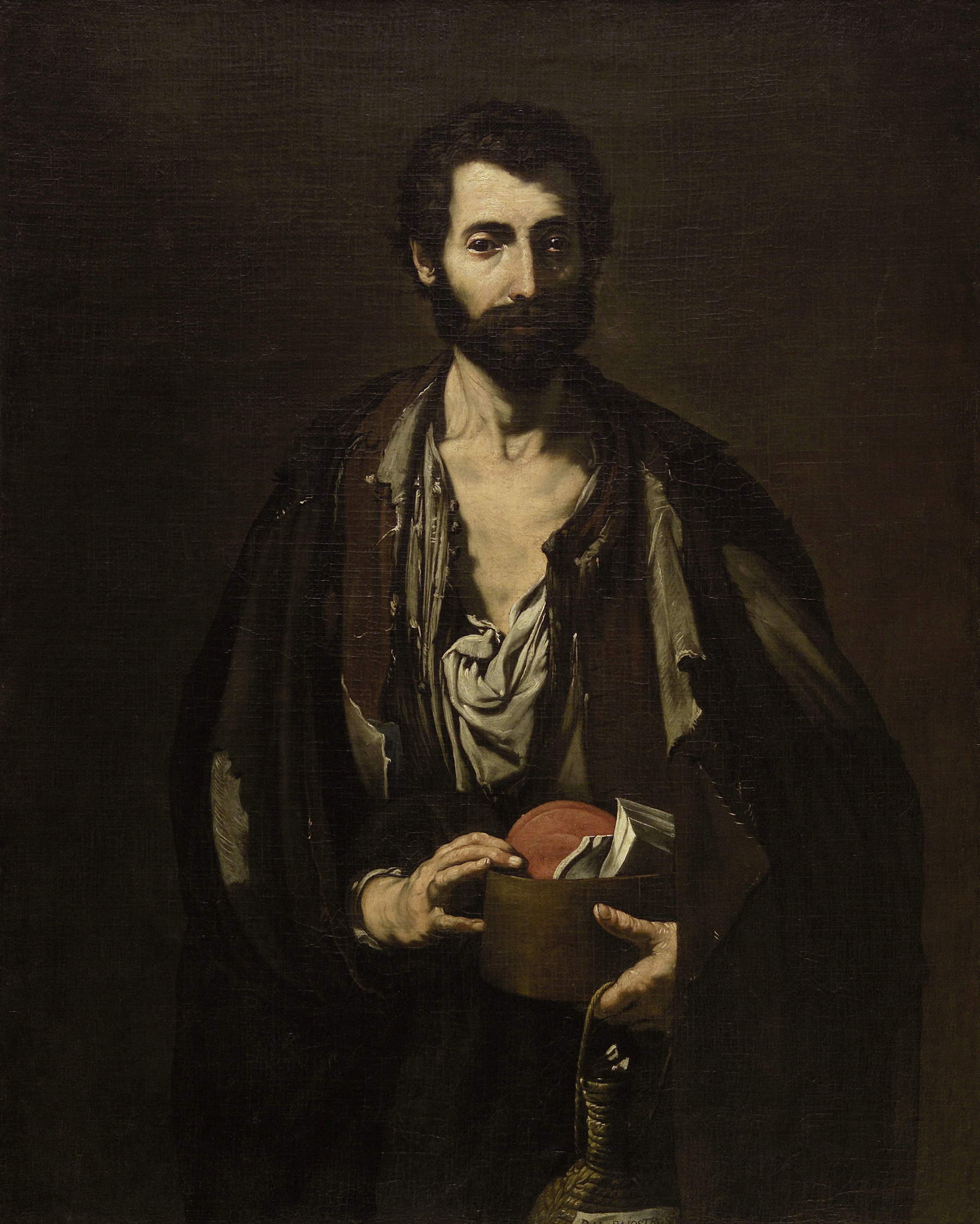
Prima d’arrivare al suo singolarissimo realismo del quotidiano, Bellotti sentiva ancora forte il fascino di quel mondo di maghe e filosofi che faceva fatica ad abbandonare, e non avrebbe rinunciato neppure a sondare i temi dell’occulto, tant’è che un’intera sezione della mostra è tutta dedicata a questo richiamo che avrebbe indotto il pittore gardesano a produrre alcuni dei suoi più interessanti lavori: il più intrigante è senza dubbio l’Indovina Martina giunta a Venezia in prestito dalla collezione Koelliker di Milano, dipinto dal soggetto rarissimo, adeguatamente identificato dallo stesso artista con un foglietto vicino al bordo inferiore della tela dove si legge “Martina io fui ch’assicurò l’imperio / col morir di Germanico a Tiberio”, allusione al fatto più noto ch’è attribuito a questa vecchia megera ricordata negli Annali di Tacito, ovvero l’avvelenamento di Germanico, che avrebbe consentito a Tiberio di rafforzare il suo potere. È forse la figura più lugubre della produzione di Bellotti ed è accostata a un altro dipinto inquietante, il Negromante di Pietro Paolini, raffigurazione d’un mago che evoca un demonio dalle mani scheletriche e artigliate salvo poi fuggire nel momento in cui la presenza si manifesta nel suo laboratorio, e dialoga con la Strega di Salvator Rosa, recente acquisizione degli Uffizi, benché ci si muova su piani diversi: il Negromante appartiene ancora alla pittura di genere, sebbene affronti un tema singolare per i caravaggeschi, e la Strega è tutta tesa a suscitare ribrezzo evocando le paure del tempo attraverso un preciso immaginario, che doveva esser ben chiaro agli uomini e alle donne del Seicento. Bellotti compie un’operazione d’altro segno: la vecchia Martina, per quanto ripugnante, è semmai da ritenersi più vicina a quel filone di figure a mezzo busto che il pittore aveva sempre praticato, e va considerata più come un ritratto che come l’evocazione d’una strega ch’è viva soltanto nell’immaginazione delle persone (e, proprio perché più vera della Strega di Salvator Rosa e più credibile del Negromante, ci appare tanto più sinistra).
È questo portamento quasi ritrattistico la ragione per cui la Martina di Pietro Bellotti appare più vicina alla Vecchia Filosofa che s’ammira nella sezione successiva, dedicata al tema della Vanitas, riflessione alla quale l’artista di Roè Volciano non si sottrasse, sebbene con un’originalità che dalla mostra emerge per contrasto e per affinità: il contrasto è con le figure seducenti di Guido Cagnacci (la sua Allegoria della vita umana è esempio altissimo di quella sensualità epidermica che ha reso grande e impareggiabile la pittura del romagnolo), o di Nicolas Régnier (per il quale la vanitas è anzitutto bellezza che sfiorisce e ricchezza che svanisce, e di conseguenza meditazione su quello che sarà), e l’affinità è invece con la vecchia di Antonio Carneo e quella d’autore ancora sconosciuto del Musée des Beaux-Arts di Nîmes, angoscianti perché sanno che il tempo che rimane è poco e la loro meditazione assume le forme d’una rassegnata preparazione. Bernard Aikema ha voluto trovare un filo che lega tutta questa prima produzione di Bellotti, leggendola alla luce della cultura di quel “sapere nascosto”, lo chiama lo studioso, ambiguo, precario e spesso semi-clandestino, che non s’esprimeva apertamente sui libri ma circolava mascherato attraverso immagini, allegorie, paradossi, provocazioni. Bellotti, Pietro della Vecchia (nella sezione sull’occulto s’ammira il suo Chiromante, per esempio) e altri pittori contemporanei avrebbero dunque tradotto per immagini quella cultura, ch’era tipica d’ambienti come quello dell’Accademia degli Incogniti, il circolo fondato a Venezia da Giovan Francesco Loredan e ch’era noto per il suo libertinismo intellettuale e il suo gusto per il paradosso e per lo scandalo. Il Socrate di Bellotti sarebbe una sorta d’epitome di questo atteggiamento: il pittore, scrive Aikema, “presenta il filosofo come un vecchio povero e rugoso, declinando ogni tentativo di abbellirne le sembianze”, ma al contempo gli fa compiere un gesto, quello della testa appoggiata alla mano sinistra, che “dà un’indicazione di quel che è l’essenza del quadro, che gira attorno al concetto di apparenza ingannevole contro una sublime verità nascosta, da scoprire”. Lo stesso vale per la Vecchia filosofa, forse sensibile alla discussione, particolarmente sentita a quel tempo, sul ruolo delle donne nella vita pubblica, una discussione cui s’interessarono anche gl’Incogniti (Loredan era in rapporti con la monaca Arcangela Tarabotti, da alcuni ritenuta addirittura una protofemminista), ma nel caso non sappiamo se per reale interesse di Bellotti o per semplice gusto dello scandalo, dacché sostenere la causa delle donne al tempo significava accogliere e poi promuovere una posizione percepita come scomoda e bizzarra. Questi dipinti, al pari di quelli ch’esplorano i temi dell’occulto, sarebbero dunque veicoli di conoscenze alternative che circolavano attraverso i manoscritti e non tramite i volumi a stampa, oppure per via orale, o tramite le immagini, o in qualsiasi modo potesse sfuggire ai controlli ufficiali.
Non sappiamo quali fossero i reali intendimenti di Bellotti: l’unica sicurezza su cui possiamo contare è che a un certo punto della sua carriera avrebbe abbandonato quei soggetti che tanto gli erano cari, e si sarebbe tramutato in quel pittore del quotidiano capace d’anticipare di diversi decennî i varî Cipper e i varî Ceruti. Ed è una trasformazione che, alle apparenze, potrebbe quasi sembrare innaturale: il passaggio dalla Vecchia filosofa ai dipinti della sala successiva, dal Bevitore del Castello Sforzesco alla Scuola di ricamo della Collezione Koelliker, per non parlare di quelli dell’ultimo ambiente della rassegna, sembra quasi improvviso, immotivato, poco logico, poco coerente con quello che Bellotti aveva costruito grosso modo fino a metà della sua carriera. Due fatti, è lecito pensare, hanno determinato questa trasformazione, almeno sul piano formale: il primo è l’incontro con l’arte di Eberhard Keilhau, il “Monsù Bernardo” nato in Danimarca ma di formazione olandese, che s’era trasferito a Venezia nel 1651 portandoci quel suo realismo rembrandtiano fatto, scrive Nicolaci, “di soggetti popolari spesso interpretati in senso moralistico e allegorico” e che avrebbero ottenuto un successo notevole in laguna. Il secondo, ancor più decisivo, è il trasferimento di Bellotti, verso la metà degli anni Settanta, nella Milano in cui questo filone del quotidiano cominciava a uscire dalla culla per opera soprattutto d’un pittore ancora semisconosciuto, quel Sebastiano Giulense, detto “il Sebastianone”, ch’è stato riscoperto solo di recente grazie specialmente agli studî di Alessandro Morandotti, che si può a oggi considerare una sorta di anello di congiunzione tra la ritrattistica d’un Pier Francesco Cittadini e la vena schiettamente popolaresca che sarà propria di Ceruti, e col quale i curatori han voluto stabilire un nesso, dacché la produzione di questo pittore milanese è ricca di tutti quei personaggi che affolleranno il genere (in mostra è possibile vedere una popolana che tiene in mano un’anatra, un’opera che par quasi fare il verso alla ritrattistica ufficiale, e che soprattutto non era mai stata mostrata in pubblico prima d’ora). L’operazione di Bellotti è originale: spoglia i suoi soggetti di quegl’intenti moralistici che ancora resistevano nella pittura di genere (rimane, semmai, qualche richiamo simbolico: il Devoto colto in un ambiente spoglio con una colomba bianca che gli svolazza di fianco, una scena ovviamente troppo costruita per esser vera, si può leggere come un’allegoria della saldezza della fede, e forse a qualche significato celato rimanda anche la Vecchia popolana con un ragazzo del MarteS di Calvagese dipinto scoperto l’anno scorso e reso noto pochi mesi fa), e porta i suoi personaggi a un realismo disincantato, smaliziato, quasi esasperato. Eccoli, dunque, i germi della pittura della realtà del Settecento: figure, come saranno quelle di Cipper e di Ceruti, che non vengono indagate (o quanto meno non sempre: alcuni residui, certo, persistono) con l’intento d’offrire al riguardante un ammonimento, un’allegoria, una caricatura del povero, ma semplicemente perché esistono. L’inedito Ragazzo su un cesto con una ciotola, che indugia sulla giacca sfrangiata e logora del giovane, sulla sporcizia delle mani, sul tozzo di pane sulle ginocchia, misero pasto che comunque il ragazzo mostra sorridendo a noi che lo osserviamo, arriva in anticipo di quasi cinquant’anni sui portaroli di Ceruti. Il Vecchio pellegrino del Dallas Museum of Art è un vecchio pellegrino e basta, e al massimo, col quel gesto della mano destra, allude al fatto che il cammino che gli rimane da percorrere è ancora lungo. La scena coi Popolani all’aperto, recentissima acquisizione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, dopo l’asta Millon di Cremona in cui il dipinto è stato venduto a 275mila euro (e alla mostra su Ceruti del 2023 non era ancora chiaro di chi fosse: era attribuito a un generico pittore del nord-est, mentre i curatori della mostra presente sono convinti si tratti d’un autografo di Bellotti), è un lavoro che, scrivono i curatori nella scheda redatta a sei mani, intende evidenziare con una certa oggettività le condizioni dell’esistenza di questo gruppo di uomini, donne e bambini, con un’immagine “di forte impatto emotivo”, anche perché sfrondata “da qualsiasi stonatura retorica, tuttalpiù limitata a qualche espressione un po’ beffarda che, a ogni modo, ha ormai perso l’intonazione più scopertamente ammiccante e picaresca impiegata dallo stesso Bellotti nelle opere degli esordi, vale a dire in quelle eseguite durante il periodo veneziano, negli anni Cinquanta e Sessanta del Seicento”. La Vecchia filatrice, tutta concentrata sul suo lavoro, non chiede più niente e non nasconde più niente, e non sembra esserci motivo di riconoscerci una parca, perché rispetto a qualche anno prima cadono tutti i presupposti: non ci sono più cartigli, non ci sono attributi simbolici, non ci sono figure che fissano negli occhi il riguardante come a ricordargli quale sia il destino di tutti gli esseri umani: qui c’è solo un’anziana intenta a filare.










Poco ancora è dato sapere sulle motivazioni che suggerirono a Bellotti l’abbandono dei temi che aveva sempre praticato e l’adesione alla nascente pittura della realtà, ma non siamo lontani dal vero se ce lo immaginiamo come un pittore profondamente partecipe del clima culturale del suo tempo, consapevole delle novità della letteratura, aggiornato sui dibattiti, interprete di quel “barocco dal basso”, lo chiama Emilio Liguori, attento alla bruttezza, alla deformità, alla povertà, allo scorrere del tempo. Liguori accenna alla fortuna che il Lazarillo de Tormes, romanzo capostipite del genere picaresco, avrebbe conosciuto in Italia e in particolare a Venezia: il letterato veneziano Giulio Strozzi fu il primo a tradurlo in italiano, nel 1608, anche se la sua traduzione sarebbe rimasta inedita, ma proprio in laguna sarebbe stata pubblicata infine la prima traduzione italiana, edita nel 1622 dal tipografo Barezzo Barezzi, e poi di nuovo ristampata nel 1626 e nel 1635, a testimonianza del favore che evidentemente l’opera doveva aver riscontrato. Si deve allo stesso Barezzi un ruolo non secondario di promotore della letteratura picaresca in Italia, dal momento che proprio dalla sua stamperia sarebbero uscite anche le versioni in italiano del Guzmán de Alfarache di Mateo Alemán e della Picara Justina, altri due capisaldi del genere. Ora, non abbiamo idea delle letture di Bellotti, né sappiamo quali legami avesse stabilito coi circoli letterarî della Venezia del tempo (s’è fatto più sopra un cenno agl’Incogniti: si potrebbe immaginare una sua frequentazione con gli accademici, ma non esistono prove che possano dimostrarla), ma forse non sarebbe lontana dal vero l’immagine d’un Bellotti tutt’altro che refrattario alle discussioni sui libri che circolavano in laguna, né è insensato rilevare, pur in assenza di una sua adesione formale all’accademia, una contiguità culturale ai temi ch’erano dibattuti negli ambienti degl’Incogniti (e non solo, verrebbe da dire, dato che i tre pilastri su cui si basa la mostra, la realtà, lo stupore e l’enigma, son comunque da considerare tipici della sensibilità barocca).
Adesso, dopo una mostra che ha fatto vedere a tutti chi è stato e cosa ha fatto Pietro Bellotti, vien naturale domandarsi in che termini vadano pensate le innegabili tangenze con l’arte di Giacomo Ceruti, che dei pittori della realtà sembra esser quello a lui più prossimo per temi, temperamento, similarità di sguardo. In mostra non ci sono opere di Ceruti (ci si consola, in compenso, con la Madre mendicante con due bambini, capolavoro del Maestro della tela jeans ch’è un altro degli anticipatori, uno dei più vicini al pittore milanese), ma è difficile non pensare a quelle sue malinconiche immagini di mendicanti, di portaroli, di filatrici, di frequentatori di taverne e osterie e non trovarci una sorta di continuazione ideale di quel che Bellotti aveva fatto molto tempo prima. La mostra cerca d’affrontare il problema, seppur lasciandolo soprattutto al catalogo, dove però emergono più i punti di contatto che le divergenze e dove i due si trovano quasi affratellati in una sorta di corrispondenza “spirituale”, la dice Filippo Piazza, che affiora, pur nelle innegabili differenze di stile, laddove si provi a immaginare assieme certi dipinti dell’uno e dell’altro. Le divergenze sono allora da rinvenire negli esiti: c’è, in Giacomo Ceruti, un’intensità ch’è sconosciuta a Pietro Bellotti, così com’è sconosciuta a tutti gli altri pittori che si son cimentati nel genere. Quell’intensità ch’è stata spesso scambiata (a torto) per partecipazione emotiva, quand’era soltanto una scelta poetica, un registro retorico. In questa intensità, Ceruti sarebbe rimasto ineguagliato. Bellotti però gli aveva preparato il terreno.
E pure con una mostra tanto completa, con tante novità, che interviene su quel Seicento veneziano così poco approfondito dalla critica eppure così affascinante, e peraltro con un allestimento e un percorso tanto intelligente anche per un pubblico di non specialisti, resta ancora tanto da chiarire attorno a Bellotti. Sappiamo per esempio che venne chiamato sia a Monaco di Baviera sia a Mantova per il suo talento da ritrattista, ma a oggi non conosciamo neppure un singolo suo ritratto, tolti quelli di se stesso. I suoi anni giovanili sono ancora un punto interrogativo. E per certi versi è un punto interrogativo anche quella scena di Popolani all’aperto, che pur presentando nelle figure elementi e caratteri del tutto compatibili col resto della sua produzione, rimane tuttora un hapax, perché non si conoscono altre scene di grandezza e respiro simili, dacché Bellotti si produsse per lo più in figure singole e lavorò soprattutto sul piccolo e medio formato: c’è dunque da attendersi che riemergano altre sue cose simili, oppure, magari, è possibile immaginare una collaborazione con qualcun altro per questa sua prova tanto inusuale. Come ogni mostra di ricerca che si concentra su di un pittore riscoperto, anche questa delle Gallerie dell’Accademia di Venezia va considerata come un punto di partenza.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.