Suonerà strano, ma sono passati trent’anni da quando Nicolas Bourriaud, era il 1996, ha cominciato a stabilire i contorni della sua fortunatissima formula “arte relazionale”, e fino a oggi nessuno, prima della mostra che invade il primo piano del MAXXI di Roma fino al 1° marzo (1+1. L’arte relazionale), aveva mai dedicato all’arte relazionale una rassegna che tenesse conto di tutto il cammino compiuto dalle pratiche individuate da Bourriaud e fatte da lui ricadere nella definizione, invero piuttosto larga, di un’arte “che assume come orizzonte teorico il regno delle interazioni umane e il suo contesto sociale, piuttosto che l’affermazione di uno spazio simbolico indipendente e privato” (così nel suo libro Relational Aesthetics del 1998). Naturalmente si potrebbe contestare a Bourriaud (com’è stato fatto, del resto) il fatto che l’arte è sempre stata relazionale, nel senso che un’opera d’arte, tranne rarissimi casi, e comunque irrilevanti, presuppone sempre almeno una relazione tra chi produce e chi osserva (ma anche immaginando un artista che produce per se stesso, l’opera d’arte non può prescindere da una relazione con un contesto): non è però questo il punto, dacché Bourriaud stesso ne è avveduto e dacché il suo grido di battaglia è, in realtà, più circoscritto di quanto si potrebbe pensare, e riguarda quelle opere che elevano la relazione e l’incontro tra osservatore e immagine a fulcro del loro significato, quelle opere che intendono deliberatamente far emergere, e talvolta persino orientare e condizionare, uno spazio d’incontro tra i suoi destinatari, o quelle opere che, al contrario, nascono o si sviluppano da una relazione tra esseri umani, oppure tra gli esseri umani e l’oggetto. Volendo seguire la filtrazione degli apparati che accompagnano il pubblico lungo le sale del MAXXI, gli artisti relazionali hanno cominciato a considerare l’oggetto come il singolo elemento di un qualche cosa di più ampio, e la creazione come un momento che va oltre il processo di laboratorio e prosegue quando l’oggetto viene messo di fronte a un pubblico.
Ci sono, in mostra, tutti gli esempi delle tre rudimentali fattispecie di cui s’è appena detto. Nel primo caso siamo ancora sul piano del rapporto spettatore-oggetto, ma la relazione presuppone la presenza d’un partecipante attivo che diventa materiale stesso dell’opera, dal momento che senza la relazione l’oggetto rimarrebbe soltanto materia inerte: è questo il caso di Love Drug di Carsten Höller, una boccetta che si tiene tra due dita ma che attiva una delle esperienze fisiche più intense che si possano provare dentro un museo e probabilmente persino al di fuori, e che accompagnerà il visitatore per tutta la mostra e anche oltre. La boccetta contiene un composto chimico a base di feniletilammina, spesso associata a stati d’euforia e di felicità (la chiamano “la molecola dell’amore”), e Höller invita ad annusarlo (l’odore è estremamente pungente, e rimane) per spostare la relazione con l’oggetto dal piano estetico a quello fisiologico. E magari anche per divertirsi a vedere l’effetto che provoca agli altri visitatori. Per il secondo caso si può convocare Gillian Wearing col suo progetto Signs that say what you want them to say and not signs that say what someone else wants you to say, titolo lungo eppure efficacemente autoesplicativo: l’artista inglese, tra il 1992 e il 1993, fotografò centinaia di persone cui veniva chiesto di reggere un cartello con su scritto un proprio pensiero. Ne è risultata una galleria d’immagini alle volte scanzonate e allegre, altrettanto spesso toccanti, preoccupanti, disturbanti: l’opera, si potrebbe dire, nasce da un incontro fra artista e soggetti e si sviluppa nell’ulteriore incontro tra i soggetti e il destinatario. Infine, per trovare l’esempio d’un’opera che sorga da una relazione tra esseri umani e oggetti, non si potrebbe non pensare ai celeberrimi Candy works di Felix Gonzalez-Torres (in mostra è esposto A corner of Baci) senza l’azione del pubblico che, portando via una caramella o un cioccolatino, carica l’opera del suo significato.






L’intuizione forse più felice di Bourriaud è stata quella d’aver assegnato, peraltro arrivandoci per via empirica, un peso inedito alla relazione, che potrebbe esser financo considerata una dimensione dell’opera d’arte: se i futuristi avevano conquistato una quarta dimensione (il movimento) e gli spazialisti la quinta (il tempo), allora potrebbe non essere azzardato pensare che gli artisti relazionali siano arrivati alla sesta (la relazione, appunto). Bourriaud ha compreso che, arrivati a un dato momento della storia dell’arte, l’oggetto non ha più goduto d’una condizione d’autosufficienza: se un quadro esiste anche senza lo spettatore, le opere degli artisti relazionali non accadono se non è data un’interazione. Le opere di Cattelan (in mostra, per esempio, una fotografia dell’azione Untitled del 1999, in cui l’artista attaccò a un muro il suo gallerista Massimo De Carlo) non avrebbero senso se private della reazione del pubblico, ch’è parte integrante del processo creativo. Senza lo straniamento che provoca sul pubblico, l’albero di Natale di Philippe Parreno sarebbe solo una decorazione. Senza il suo sorprendente spazio interno, il boschetto di Opavivará, una delle opere realizzate per questa mostra, sarebbe solo un cumulo di piante fuori contesto. Naturale, a questo punto, rilevare che fin dall’epoca dei dadaisti siano esistite pratiche artistiche fondate sulla relazione come elemento dell’opera: gli happening, l’Internazionale situazionista, tutto quello che ricade nell’ambito della performance. Bourriaud ha inteso collocare la sua arte relazionale alla fine della linea che unisce tutte quest’esperienze, individuando gli artisti attivi sul finire del secolo come un “gruppo di persone che, per la prima volta dalla comparsa dell’arte concettuale a metà degli anni Sessanta non trae alcun nutrimento da alcuna reinterpretazione di questo o quel movimento estetico del passato”, e intendendo l’intersoggettività e l’interazione non come un “gadget teorico alla moda” e neppure come un “additivo (alibi) di una pratica artistica tradizionale”, bensì come “i principali informatori” dell’attività degli artisti che si possono identificare come relazionali. Ovvero artisti che si muovono nello “spazio dell’interazione” e che producono “elementi spazio-temporali relazionali, esperienze interumane che cercano di liberarsi (in un certo senso) della camicia di forza dell’ideologia delle comunicazioni di massa, dai luoghi in cui si elaborano forme alternative di socialità, modelli critici e momenti di convivialità costruita” (così in Relational Aesthetics). In breve: l’idea è che se nelle pratiche artistiche precedenti esisteva ancora un confine netto tra l’artista e il pubblico, nell’arte relazionale l’artista diventa una sorta di facilitatore (sulle modalità di produzione, Bourriaud sarebbe poi tornato con un altro suo fortunato titolo, Postproduction: qui basterà limitarsi a rammentare che per il critico francese l’arte, da questo punto di vista, è un “banco di montaggio della realtà”). Bourriaud, in sostanza, ha concepito un’arte che si pone come produttrice di nuovi legami sociali, creatrice di spazi di convivialità, di micro-utopie (benché l’obiettivo non sia quello d’immaginare mondi alternativi, ma di proporre semmai modelli d’azione per quello che Bourriaud chiama the existing real al fine d’imparare ad abitarlo meglio). In questo senso, l’opera d’arte è per lui da intendersi dunque come un “interstizio sociale”, dove il termine “interstizio” è ripreso da Marx che lo adoperava per riferirsi a comunità commerciali in grado di sfuggire al contesto economico capitalista (il baratto, forme di produzione autarchiche e via dicendo): allo stesso modo, per Bourriaud l’opera relazionale è uno spazio nelle relazioni umane che s’inserisce “più o meno armoniosamente e apertamente nel sistema complessivo, ma suggerisce possibilità di scambio diverse da quelle effettivamente in atto al suo interno”, con l’obiettivo di “creare aree libere e intervalli di tempo in cui il ritmo contrasta con quelli che strutturano la vita quotidiana, e incoraggia un commercio interumano diverso dalle ‘zone di comunicazione’ che ci vengono imposte”. Ancora qualche esempio dalla mostra: la famosa azione Untitled 1990 di Rirkrit Tiravanija che in una galleria d’arte di New York preparava e serviva ai visitatori un piatto tipico della Thailandia, il suo paese d’origine. Un’altra azione, My Audience, di Christian Jankowski che dal 2003 non ha ancora smesso di fotografare il pubblico che partecipa alle sue conferenze con l’intento di sondare, e in qualche modo di ribaltare, le dinamiche che si creano tra il relatore e l’uditorio durante occasioni siffatte. O ancora il Confessionarium trasparente di Alicia Framis: un confessionale dove l’ammissione dei peccati avviene dinnanzi a chiunque si trovi a camminare per la mostra e diventa, c’informa il pannello in sala, una metafora del bisogno di verità e del superamento delle ipocrisie del potere religioso.
Non è questa la sede per misurare portata, coerenza, felicità, originalità delle idee di Bourriaud, che pur se oggi largamente popolari hanno anche generato dibattito e hanno inevitabilmente ricevuto alcune importanti risposte critiche. Val la pena comunque menzionarne alcune: Claire Bishop, per esempio, si è chiesta fino a che punto la “struttura” di un’opera relazionale possa essere staccata dall’oggetto apparente dell’opera o quanto possa essere permeabile al suo contesto, e in che modo possa essere misurabile la relazione prodotta da un’opera d’arte (“la qualità delle relazioni nell’estetica relazionale”, ha scritto, “non viene mai esaminata o messa in discussione”, perché si presuppone che il dialogo e lo scambio siano intrinsecamente buoni quando invece, secondo Bishop, l’antagonismo dovrebbe esser la chiave per ripensare il nostro rapporto col mondo e con gli altri, dacché senza conflitto e senza dissenso l’opera rischierebbe d’esser superficiale o compiacente). Grant Kester ha invece accusato Bourriaud di confondere la dimensione estetica dell’arte con la dimensione politica, dal momento che, a suo avviso, l’aspetto più problematico del discorso dell’arte relazionale è la sua sostanziale rassegnazione, evidente nel momento in cui l’esperienze degli artisti relazionali rimangono scollegate da cambiamenti concreti o da una prassi politica reale (“il risultato”, ha scritto Kester, “è un quietismo invalidante che separa decisamente questa conoscenza prefigurativa-generativa da qualsiasi connessione con la prassi qui e ora”). L’opera dunque continuerebbe ad agire sul piano estetico, o al più su quello simbolico, senza tradursi in azione concreta, in sfida strutturale. Si potrebbe poi dissentire sull’idea di un’arte relazionale che non reinterpreta movimenti del passato, quando è difficile non avvertirla come figlia di tutto quel che l’ha preceduta. Si potrebbe contestare l’intercambiabilità del termine “relazionale” (c’è chi ha parlato di arte “interattiva” o “partecipativa” per descrivere sostanzialmente le stesse esperienze, critica peraltro contestata dallo stesso Bourriaud in catalogo: per lui, la partecipazione è uno degli strumenti della relazione, ma non è il soggetto dell’arte relazionale). Non è però questa, si diceva, la sede per verificare la validità degli assunti di Bourriaud: ci si potrebbe però limitare almeno a un aspetto utile anche per valutare la mostra. Ovvero si potrebbe contestare, da un lato, l’autoreferenzialità di molta arte relazionale e dall’altro, soprattutto, il fatto che molta arte relazionale nasca e si sviluppi all’interno d’un sistema ufficiale ch’è esso stesso autoreferenziale, chiuso, distaccato dal mondo, per giungere alla conclusione che l’arte relazionale non abbia tutto questo potenziale di cambiamento che le si potrebbe attribuire in astratto (o, se ce l’ha, magari è un potenziale mediato). L’universalità del contenuto che stride con l’elitarismo del contenitore.
Nessuno naturalmente vieta d’immaginare il museo come un laboratorio, né è intelligente pensare che l’intera umanità debba passare per un museo o una galleria in cui si consuma una performance relazionale: il potenziale di un’opera partecipativa è soprattutto quello indiretto, sta soprattutto nella sua capacità di filtrare all’esterno attraverso forme più o meno larghe di mediazione (l’architettura, l’attivismo, il cinema, l’urbanistica, la politica stessa). Matteo Innocenti ha fornito un esempio estremamente calzante nella sua recensione alla mostra pubblicata sul blog Antinomie: l’opera A Needle Woman di Kimsooja, che il pubblico trova in apertura di percorso al MAXXI (l’artista coreana, tra il 1999 e il 2001, si recò a Tokyo, Delhi, Il Cairo e Lagos e cominciò a farsi riprendere mentre stava immobile in mezzo alla folla che le passava accanto) è messa in parallelo con l’azione d’un giovane coreografo turco, Erdem Gündüz, che con la sua standing man protest tra il 2013 e il 2014 è diventato il simbolo del dissenso contro il governo di Erdoğan. Né si contesta che un’opera o una mostra possano cambiare il mondo in piccolo, magari soltanto a partire da due persone: l’obiettivo non è garantire al pubblico conversioni di massa, ma fornire strumenti. Tuttavia non si può neppure sottovalutare il rischio d’aver tra le mani degli oggetti che parlano soltanto a chi è già ben informato, e la mostra del MAXXI per certi versi non sembra prescindere da questa direzione, almeno nella sua costruzione di base, nella sua struttura. Intanto, 1+1. L’arte relazionale vien presentata come una “retrospettiva”, altro termine problematico e che vien spesso usato per classificare di tutto. Nell’introduzione al catalogo, Francesco Stocchi la presenta però come una mostra che “propone un’indagine completa sull’origine, lo sviluppo e l’evoluzione dell’arte relazionale intrecciando opere degli anni Novanta con ricerche di una generazione successiva, estendendo il campo di indagine oltre l’orizzonte eurocentrico che ne aveva caratterizzato le prime formulazioni teoriche”. Manca tuttavia di un taglio storico appropriato: se per chi ha una certa conoscenza dell’argomento è facile individuare una ancorché minima struttura all’interno del percorso immaginato da Bourriaud, sebbene la linearità della costruzione venga spesso sacrificata, anche in ragione d’uno spazio che non lascia grossi margini di manovra (ecco allora che prima vengono tutti i “padri fondatori”, chiamiamoli così, poi i progetti in fieri e i loro precursori, poi ancora tutti gli artisti che hanno anticipato l’arte relazionale, inclusa Maria Lai con la sua Legarsi alla montagna, qua e là le opere più recenti e quelle create per l’occasione: manca il Gruppo Piombino, cui però vien dato spazio in catalogo), il pubblico che non conosce quel ch’è accaduto negli ultimi trent’anni d’arte contemporanea rischia d’esser lasciato in balia di se stesso. A guidare i visitatori son state messe alcune domande nelle didascalie (per esempio, sotto a Hollywood di Cattelan: “Se potessi scegliere un luogo in cui installare una scritta famosa ed iconica con lo stesso spirito provocatorio dell’artista, quale scritta e quale luogo sceglieresti?”, o ancora, sotto VB74 di Vanessa Beecroft: “Nel mondo contemporaneo carico di immagini ad alta definizione, spesso modificate, il nostro modo di relazionarci ai corpi in carne ed ossa è cambiato?”). Uno strumento che suscita simpatia, ma che da un lato fa anche molto libro di testo delle scuole medie, con tutte le conseguenze del caso (una su tutte: è totalmente comprensibile l’intento di rendere relazionali pure le didascalie delle opere, ma neppure ci sentiamo d’escludere l’eventualità per cui anche un approccio più adulto avrebbe consentito letture parimenti e forse financo più approfondite), e dall’altro sembra quasi replicare le modalità d’interazione delle intelligenze artificiali generative come ChatGPT e Gemini che, finito di spiegarti un concetto, ti tempestano di domande: la differenza è che alla mostra non c’è nessuno disposto a replicarti con la stessa loquacità della macchina (potrebbe esser lo spunto per un’opera d’arte relazionale?). Oggi ci facciamo fin troppe domande, ma rimaniamo senza risposte, senza riferimenti, senza punti fermi in un mondo ch’è sempre più fluido e difficile da comprendere: ecco, forse un artista oggi dovrebbe colmare proprio questo vuoto.




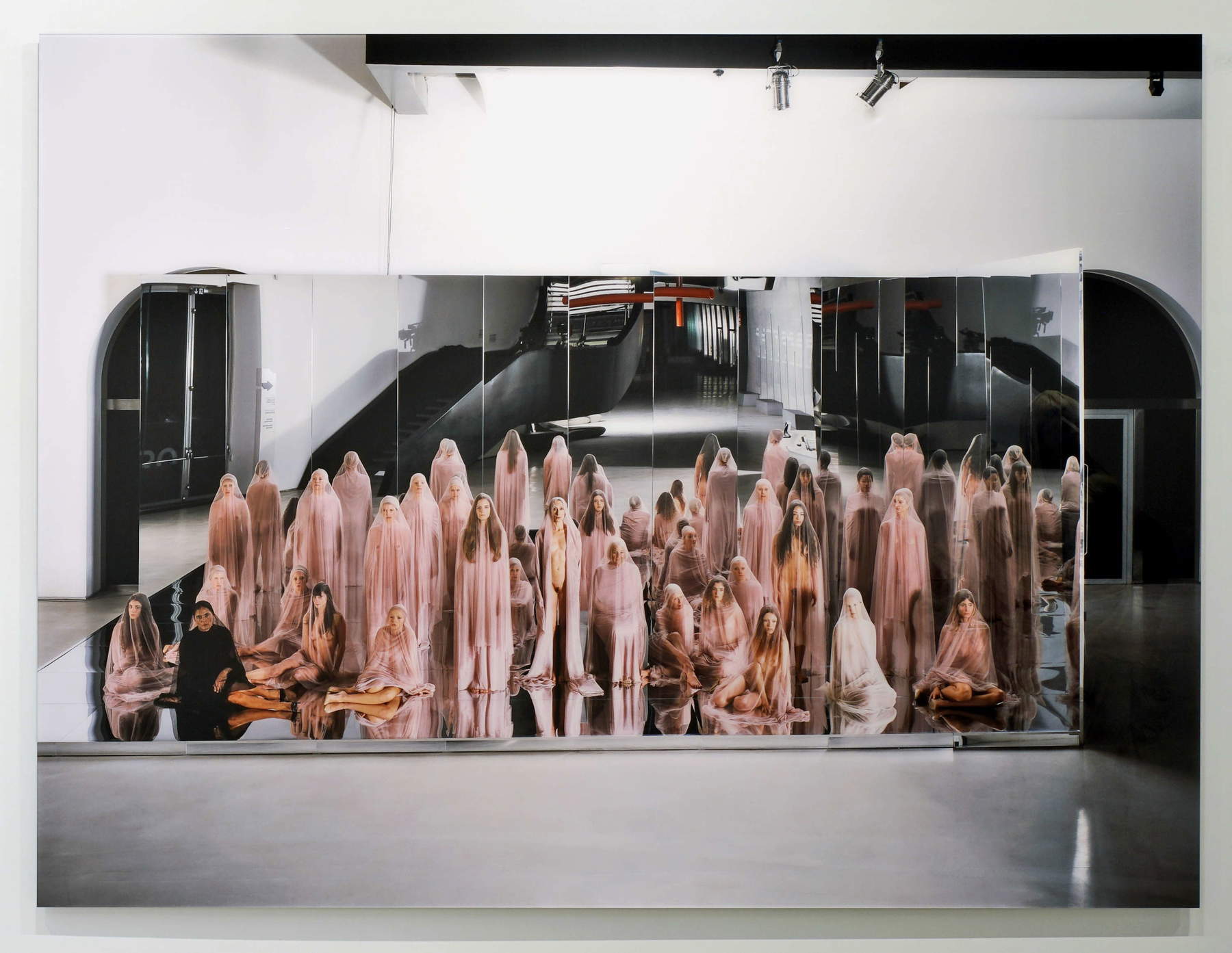

Ad ogni modo, se ne ricava la percezione di visitare una mostra pensata e costruita soprattutto per addetti ai lavori, una sorta di best of, di antologia di quel ch’è accaduto in trent’anni di arte relazionale, sebbene tra le sale aperte del MAXXI ci sia materiale sufficiente per ricostruire una cronologia strutturata (compito che, tuttavia, è ancora affidato al catalogo). Si potrebbe dividere la storia dell’estetica relazionale di Bourriaud almeno in tre momenti: il primo d’elaborazione teorica, che corrisponde grosso modo alla seconda metà degli anni Novanta e dura almeno fino a metà degli anni Duemila o poco più. Poi, un secondo momento di diffusione globale, e infine un momento di “crisi della misura umana”, per adoperare la stessa espressione del curatore, ovvero un momento in cui l’essere umano comincia a perdere la sua centralità nella rete delle relazioni in cui gli artisti pensano se stessi e i destinatari delle loro opere. Un periodo che comincia già in epoca piuttosto precoce (soprattutto con Pierre Huyghe) e dura fino al tempo presente, un tempo in cui gli artisti si son trovati a pensare a un “ambiente composto da soggettività (umane, animali, vegetali... ), un ecosistema in cui esistono soltanto soggetti […], fatto di relazioni infinite” (il momento di svolta, nella dettagliatissima cronologia di Linda Motto in catalogo, viene attribuito a Soma di Carsten Höller, opera del 2010 con cui l’artista tedesco costruiva uno scenario di connessioni tra esseri umani, animali, sostanze chimiche e biologiche). Se però il primo e il secondo momento sono ben documentati in mostra, dacché rappresentano il grosso del materiale radunato da Bourriaud, più lacunosa è la documentazione sugli sviluppi più recenti: c’è però da dire che, dato lo spazio a disposizione, e data anche la difficoltà degli ambienti del MAXXI, che poco si prestano a una rassegna costruita con strumenti, metodi e percorsi tradizionali, è anche molto difficile immaginare una mostra organizzata diversamente. Anche perché il mondo è cambiato a una velocità forse maggiore di com’è cambiata l’arte relazionale. La mostra rimane comunque un’utile antologia, che somma tanti dei momenti più interessanti del “movimento” definito da Bourriaud e offre al pubblico una prospettiva storica di sicuro interesse.
Non mancherebbe neppure l’occasione di ragionare sul presente dell’arte relazionale (molti gli artisti che continuano a produrre dentro il solco tracciato da Bourriaud: lui stesso, in un’intervista concessa a Finestre sull’Arte, ha dichiarato che le sue idee sono ancora vive e ci sono diversi artisti giovani che si riconoscono in queste idee) e, soprattutto, sull’impatto che l’arte relazionale è riuscita a esercitare. Varrebbe la pena soffermarsi almeno su un paio d’indiscutibili effetti del movimento relazionale, ragionando su di un paio di spunti in catalogo. Il primo è offerto da Bassam El Baromi, quando dice che l’estetica relazionale è stata in grado di valorizzare “le relazioni sociali, umane e in rete che le opere sono in grado di produrre come orizzonti di possibilità, anziché relegare l’arte alla tradizionale correlazione oggetto-soggetto”. Questo non vuol dire che nel ventunesimo secolo l’opera d’arte non deve più essere un quadro o una scultura, ma significa che l’arte può essere intesa anche come un processo dinamico che coinvolge le comunità, anche solo per poco tempo, e tanta parte dell’arte contemporanea s’è del resto orientata verso processi che favoriscono la partecipazione, l’invasione dello spazio pubblico, la trasformazione degli stessi luoghi dell’arte in laboratori.
Il secondo spunto viene dal saggio di Sara Arrenhuis: “Un aspetto della pratica dell’estetica relazionale nell’arte contemporanea che oggi, a posteriori, risalta in modo particolare è che prefigura e anticipa la mercificazione dell’interazione sociale che domina la nostra cultura attuale”. È argomento d’estrema attualità, anche se nel percorso della mostra rimane quasi scansato, o quanto meno non emerge in maniera così evidente. Molti artisti relazionali sembrano quasi aver previsto l’arrivo d’un tempo che ha trasformato ogni relazione in un prodotto, misurabile e soggetto a logiche di profitto: l’esempio più calzante e più chiaro è quello dei social network, che stanno modellando in maniera sempre più invasiva il modo in cui osserviamo la realtà, e lucrano non soltanto sulle nostre interazioni sociali, ma anche sulla nostra superficialità, sulle nostre ansie, sui nostri timori, sui contenuti che consumiamo attraverso le piattaforme. Non solo: gli artisti relazionali hanno capito con molto anticipo che il valore si sarebbe spostato dalle cose alle relazioni, dagli oggetti ai contatti. Il problema è che l’hanno capito anche tutti quei soggetti che detengono ed esercitano il potenziale di trasformare le interazioni tra gli esseri umani in prodotti da commerciare, coi risultati che oggi vediamo. La socialità progettata di Tiravanija che invitava sconosciuti a cena in un museo negli anni Novanta era un gesto di rottura, oggi è il meccanismo base di tante piattaforme che si reggono sul mercimonio delle relazioni. E se trent’anni fa gli artisti cercavano d’invadere gli interstizi, oggi lo spazio per quegl’interstizi s’è drasticamente ridotto. La sfida d’un’arte, relazionale o meno, che c’induca a ragionare sulla qualità delle nostre interazioni, che esprima dissenso, che offra forme di resistenza è molto più difficile rispetto a quelle che gli artisti relazionali affrontavano trent’anni fa.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini
Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.