Chi volesse girare un biopic dedicato a Elisabetta Sirani avrebbe a disposizione tutti i fattori utili al successo di un film: la figura di una donna indipendente, colta e decisa a perseguire uno straordinario successo, che effettivamente arrivò; un gossip amoroso e conturbante; un finale true crime con relativa indagine giudiziaria. Ambientata nella Bologna di metà XVII secolo, la storia è del tutto reale e ha per protagonista una pittrice talentuosa che seppe gestire una sua “accademia”, che nel suo atelier riceveva aristocratici e teste coronate desiderose di ammirare la sua bravura e di acquistare i suoi dipinti, e che osò addirittura superare i modelli imposti ai pittori bolognesi dal grande maestro Guido Reni, elaborando un linguaggio originale che strizzava l’occhio alle novità del Barocco romano. Il nuovo volume di Massimo Pulini, instancabile studioso di Seicento emiliano, nonché artista e docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ripercorre la biografia di Elisabetta Sirani corredandola con numerose opere inedite (Il diario di Elisabetta Sirani, NFC edizioni, Rimini, 2025, 288 pagine). Queste, insieme al corpus già noto, vengono peraltro messe in relazione con il cosiddetto Diario, un registro su cui la pittrice annotava le più prestigiose committenze e che per la prima volta viene riprodotto nella sua versione manoscritta.

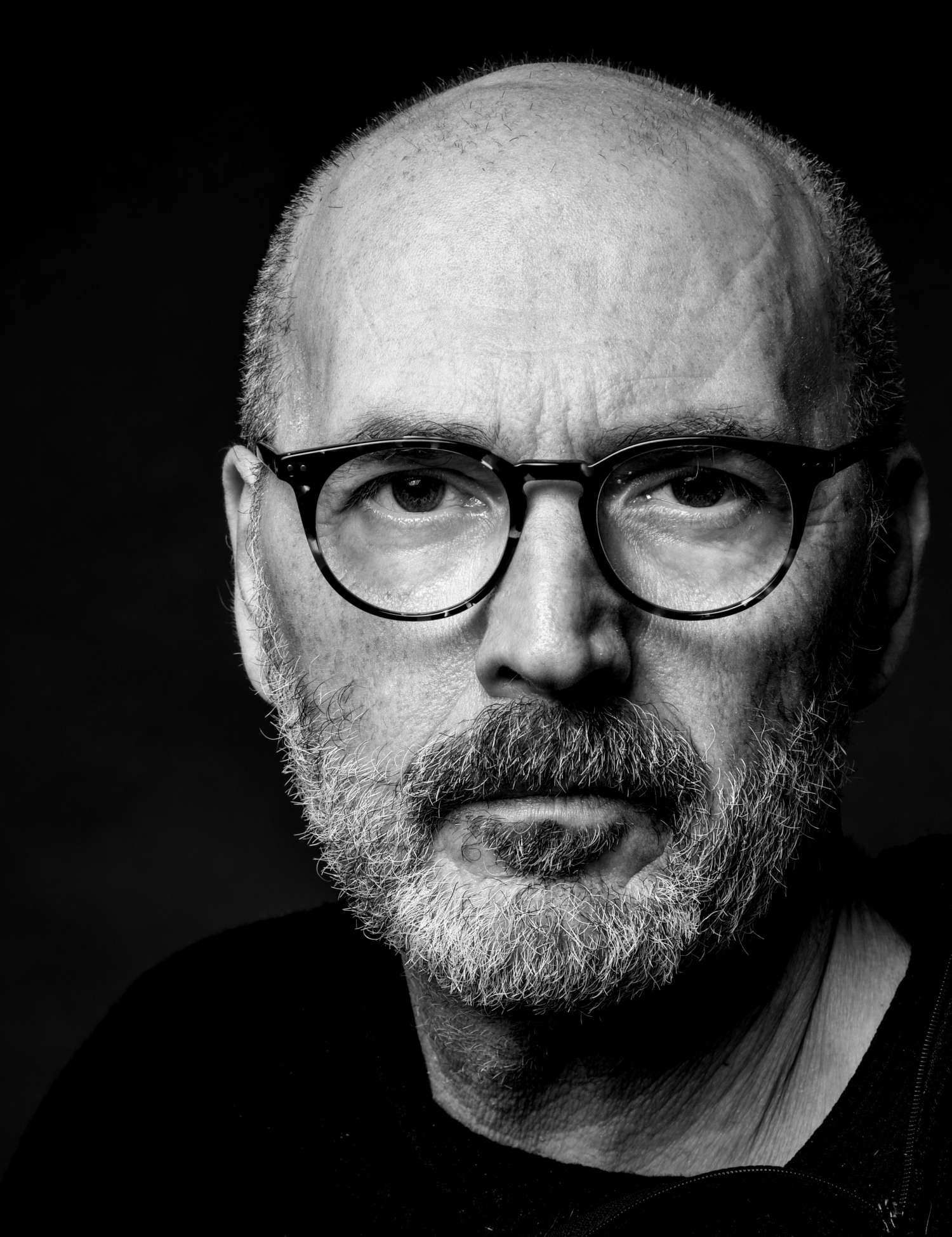
MS. Chi era Elisabetta Sirani, artista di cui si sente talvolta parlare e si ammira qualche rara opera nelle mostre di ricerca, ma che non è ancora conosciuta come al contrario meriterebbe?
MP. Elisabetta era figlia di un pittore, Giovanni Andrea Sirani, già affermato e attivo poiché rivestiva un ruolo pedagogico e quasi di capomastro all’interno della bottega di Guido Reni. Egli infatti, come racconta Carlo Cesare Malvasia, che possiamo considerare il corrispettivo bolognese di Vasari grazie alla sua raccolta di biografie degli artisti cittadini intitolata Felsina pittrice, impartiva agli allievi di Reni una formazione basata su un metodo rigoroso che prevedeva la replica delle invenzioni del maestro. Lo stesso approccio fu probabilmente adottato anche per l’istruzione della giovanissima primogenita che manifestò precocemente il proprio talento, e ce ne parla ancora Malvasia, abituale frequentatore della bottega dei Sirani. Si dice addirittura che la ragazza sia stata “scoperta” proprio dall’intellettuale, il quale convinse il Giovanni Andrea a impartirle una formazione professionale, cosa che del resto avvenne anche per altre due figlie.
A Elisabetta Sirani venne data solo una formazione da pittrice?
No, sappiamo che raggiunse un grado di cultura elevata, tant’è vero che il primo pagamento di ogni anno andava al maestro di musica: Elisabetta era un’eccellente suonatrice di arpa. Possiamo immaginarla come una figura simile a Sofonisba Anguissola, che però aveva natali nobili e venne chiamata alla corte di Spagna anche grazie alla sua educazione a perfetta damigella di corte. Giovanni Andrea probabilmente aspirava a qualcosa di analogo per le sue figlie, però ciò ha comportato anche un livello di autonomia intellettuale che ha avuto come conseguenza: ben presto Elisabetta divenne più brava del padre.
Nonostante la venerazione del padre e degli artisti bolognesi nei confronti di Guido Reni, Elisabetta si discostò subito dalla tradizione, elaborando un nuovo linguaggio, giusto?
Quando Guido Reni morì, nel 1642, Elisabetta aveva solo quattro anni, quindi non poté conoscerlo di persona, tuttavia a casa del padre erano presenti diverse opere del maestro, alcune delle incompiute e destinate a essere completate da Giovanni Andrea, l’unico autorizzato a farlo. Fin dalle primissime opere, però, la pittrice dimostra di voler essere autonoma e non si conosce alcuna sua copia da Reni; questo non significa che non ne abbia fatte, anzi probabilmente ne fu obbligata dal padre, tuttavia l’adolescente (aveva infatti circa quindici anni quando cominciò a dipingere) sviluppò una sua creatività indipendente, spontanea e rapidissima che la rese davvero famosa. Si sa che quando riceveva delle commissioni, Elisabetta faceva dei disegni all’impronta sull’idea che poi sarebbe diventata il quadro. L’indipendenza e la qualità di pensiero si notano anche nei suoi quadri, nel modo in cui preparava i soggetti mitologici o allegorici.
Il desiderio di autonomia è confermato anche dall’apposizione della firma per distinguere le sue opere rispetto a quelle del padre…
Infatti, i suoi primi successi furono seguiti da una serie di maldicenze secondo cui era stato il padre a dipingere alcune tele, raffinate al punto da gareggiare con quelle del grande Reni. Ciò spinse Elisabetta a firmare i dipinti, un po’ come aveva fatto Lavinia Fontana prima di lei, sempre a Bologna. Le dicerie però continuarono a circolare e anzi si moltiplicarono quando, a circa vent’anni, ricevette la commissione da parte della nascente chiesa di San Girolamo alla Certosa per la gigantesca tela con il Battesimo di Gesù. L’incarico era tra i più ambiti dai pittori bolognesi e l’artista non solo tenne testa alla prestigiosa committenza, ma riuscì anche a gestire una folla di personaggi, creando una scena sacra molto complessa. Vi appose quindi la sua firma a caratteri cubitali.
Si può affermare che Bologna fosse una città molto competitiva in campo artistico, e che questa atmosfera segnò profondamente la vita e la morte di Elisabetta Sirani?
Bologna era all’epoca la città con la massima concentrazione di pittori in rapporto agli abitanti. Più di Roma, Napoli, Genova: questo perché non vi soggiornavano solo artisti nativi, ma anche tanti provenienti da fuori, e questo già da vari decenni. L’Accademia dei Carracci prima, e poi le botteghe di Reni e di Guercino, erano vere e proprie industrie. Una tale “folla” rendeva l’ambiente estremamente competitivo e sotto i portici di Bologna le voci malevole correvano veloci. Inoltre la città era molto legata alla sua tradizione artistica che, giustamente, ne faceva una delle capitali europee della pittura, ma allo stesso tempo ciò comportava una certa chiusura mentale, un’autosufficienza che manifestava lo stesso Giovanni Andrea Sirani. L’ariosità, la qualità fresca e aperta, felice e gioiosa delle opere di Elisabetta (pur rimanendo nel solco della tradizione bolognese) si presentarono quindi come novità. Soprattutto negli ultimi dipinti si percepisce una pennellata mossa nei panneggi e nelle espressioni delle figure che guarda a Roma, a Carlo Maratta, a Giovan Battista Gaulli, anche se non sappiamo come avesse potuto conoscere il Barocco romano. Forse tramite dipinti, disegni e incisioni che giunsero a Bologna, inoltre visitò la corte di Modena dove ammirò Velázquez; e non è escluso che possa aver viaggiato nell’Italia Centrale insieme al padre.








Nonostante il suo desiderio di recarsi a studiare a Firenze o a Roma, il padre la trattenne nella sua bottega e le impedì di partire. Perché?
Dopo aver ricevuto il titolo di accademica da parte dell’Accademia di San Luca, per Elisabetta si accesero le speranze di andare a studiare a Firenze o a Roma, ma il padre però si rifiutò di lasciarla viaggiare da sola, anche perché in quel momento aveva dei problemi di salute e l’aiuto in bottega di Elisabetta era diventato cruciale per gli affari. Era la figlia, infatti, che portava avanti economicamente la famiglia, anche perché le sue tele costavano molto di più rispetto a quelle di Giovanni Andrea. A quel punto lei rispose al padre con una frase storica: “Se non posso uscire da Bologna, preferisco non uscire nemmeno di casa. Ma voglio qui la mia scuola”. Una scuola di sole femmine.
Questa scuola per donne pittrici è un unicum nello scenario italiano del Seicento?
Sì, Elisabetta chiamò la sua scuola “Accademia” e riuscì a coinvolgere fino a 15 allieve contemporaneamente tra nobili e donne sposate di Bologna che colsero l’opportunità per frequentare sia le lezioni della Sirani sia di Ginevra Cantofoli; quest’ultima aveva vent’anni in più di Elisabetta ed era stata lei stessa allieva di Giovanni Andrea. L’accademia femminile fu la prima e unica per molto tempo, ma dopo la morte di Elisabetta, purtroppo, venne inevitabilmente smantellata. Alcune delle pittrici cercarono lavoro in altre botteghe, ma nonostante a Bologna le artiste donne fossero pubblicamente e ufficialmente considerate, c’era ancora chi le rifiutava.
Nella sua recentissima monografia lei ricostruisce il corpus di Elisabetta Sirani, pubblicando anche molti inediti. Quanto ha disegnato e dipinto questa pittrice?
In trent’anni di ricerche sono riuscito a rintracciare 55 inediti tra disegni, incisioni e dipinti e il fattore scatenante per la pubblicazione di questo libro è stato il ritrovamento a Montefiascone delle 15 tavolette con i Misteri del Rosario. In totale, attualmente, il corpus di Elisabetta conta quasi 400 pezzi: una quantità consistente se si pensa che ha lavorato poco più di dieci anni.
Nel libro le opere sono inoltre contestualizzate nella “griglia” del Diario dell’artista. Oltre a essere una fonte preziosissima per ricostruire la carriera dell’artista, perché questo manoscritto è così importante?
Elisabetta cominciò a compilare questo registro nel 1655 e lo aggiornò fino al 1665, fino a poco prima di morire, e la prima opera citata è una pala d’altare realizzata per la marchesa Spada. Certamente non si tratta della sua prima opera in assoluto, e questo la dice lunga sul fatto che avesse già dimostrato il proprio talento. In particolare Sirani annota nel manoscritto le committenze, quindi solo le opere che le vengono chieste e ne indica sia il tema e sia nome e cognome della persona a cui l’opera è destinata. Inoltre appunta le visite dei personaggi di alto rango che le fanno visita: ad esempio la duchessa Enrichetta di Savoia si recò nel suo atelier e la pittrice realizzò davanti a lei un amorino. Molti regnanti e i nobili che passavano da Bologna non mancavano di andare a osservare di persona il lavoro di questa donna pittrice, diventando così i testimoni delle sue capacità. Nel Diario non sono invece menzionati, ma sono ugualmente autografi, molti altri lavori – anche firmati e datati – che Sirani realizzava di propria iniziativa.
Quali altre curiosità sono emerse dall’analisi del Diario?
Un aspetto curioso è che Elisabetta Sirani divenne ricercata per la sua capacità di realizzare dei ritratti post mortem. Tutto cominciò con un primo ritratto del padre inquisitore Guglielmo Fochi che venne apprezzato moltissimo come una cosa vivifica, capace di riportare in vita il personaggio. Si sparse quindi la voce e quando moriva un gentiluomo o un aristocratico di cui non si possedeva un ritratto recente, veniva convocata Elisabetta, la quale durante la veglia eseguiva degli schizzi a disegno come quelli conservati alla Royal Collection Trust di Londra. Probabilmente è realizzata post mortem anche l’effigie di un bambino che tiene in mano un mazzo di fiori, poiché il fiore reciso è simbolo di morte. Colpisce immaginare questa ragazzina pittrice che, durante le recite del rosario, saliva su una sedia per osservare il volto del cadavere dalla giusta la prospettiva, riportandone le sembianze nel taccuino: è una scena molto cinematografica.








Passiamo dal tema della morte all’amore… quale gossip ipotizza sulla base delle fonti scritte?
Abbiamo già accennato all’interesse di Malvasia, che era un canonico, per il talento di Elisabetta, ma sorprende leggere attentamente la biografia che scrive per Felsina pittrice. Oltre a un lungo proemio molto retorico, l’autore adotta un fraseggio totalmente diverso rispetto a quello delle altre vite, al punto che Luigi Crespi, quando riscrive la Felsina cent’anni dopo, sostiene che il canonico sembrava ottenebrato dal dolore. Penso quindi che Malvasia fosse sinceramente innamorato della giovane Elisabetta, tanto che a un certo punto il canonico passa dalla terza persona alla seconda, dando del tu al soggetto. Accenna addirittura a una ricongiunzione futura e, a distanza di alcuni anni dalla morte e nonostante le prove di un decesso naturale, scaglia anatemi contro coloro che ritiene colpevoli di avvelenamento della Sirani. Infine sappiamo che aveva commissionato a Elisabetta delle allegorie di virtù e di concetti morali che paiono quasi degli autoritratti allegorici. È solo un’ipotesi, ma tutto fa pensare a un pensiero amoroso di Malvasia, forse semplicemente casto… e non si sa se ricambiato.
Chiudiamo questa intervista con il gran finale tragico, la morte di Elisabetta. Come mai la sua vita si spegne a soli 27 anni?
L’artista, dopo qualche settimana trascorsa sopportando dolori molto acuti, morì a causa di un’ulcera cronica e perforata, che venne certificata mediante una seconda autopsia, successiva a quella eseguita dal medico curante, il quale aveva ipotizzato un avvelenamento. La morte improvvisa, infatti, aveva gettato il padre nello sconforto e, inconsolabile, accusò una serva di aver avvelenato la figlia. Bisogna tenere a mente che erano ancora vivi i già citati sentimenti d’invidia da parte di tanti artisti che non erano riusciti a raggiungere un successo pari a quello di Elisabetta. Malvasia tuttavia continuò a credere all’ipotesi di un assassinio tramite un veleno, come abbiamo già accennato, “anche se questo non è propriamente da cristiano”, scrive lui stesso. Inevitabile allora porsi una domanda: se Elisabetta Sirani fosse vissuta più a lungo, oggi forse supererebbe per fama l’arcinota Artemisia Gentileschi e senz’altro avrebbe contribuito a diffondere una ventata di modernità nella Bologna del secondo Seicento.

L'autrice di questo articolo: Marta Santacatterina
Marta Santacatterina (Schio, 1974, vive e lavora a Parma) ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, con indirizzo medievale, all’Università di Parma. È iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2016 e attualmente collabora con diverse riviste specializzate in arte e cultura, privilegiando le epoche antica e moderna. Ha svolto e svolge ancora incarichi di coordinamento per diversi magazine e si occupa inoltre di approfondimenti e inchieste relativi alle tematiche del food e della sostenibilità.Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.